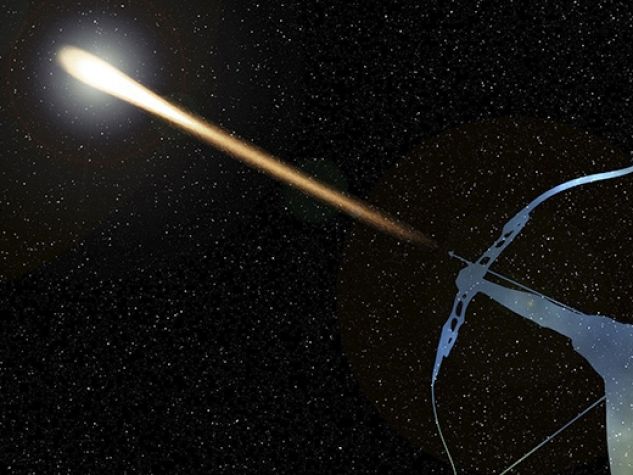Usa, il razzismo abita (ancora) qui?
Il 9 aprile del 1865, il generale degli Stati Confederati del Sud, Robert Lee, si presentò in una casa di solito usata come tribunale, ad Appomatox, in Virginia. Aveva di fronte il suo rivale degli Stati Uniti d’America, il generale Ulysses Grant, e da firmare il trattato di resa che avrebbe chiuso la guerra civile americana, cominciata nel 1861 e che fece più morti da sola di tutti gli altri conflitti Usa, dalla rivoluzione contro Sua Maestà britannica all’Afghanistan. La guerra era scoppiata per il dissenso radicale che da decenni divideva la giovane nazione, se la schiavitù degli afroamericani dovesse, o no, estendersi anche ai nuovi Stati che l’Unione, pian piano, acquisiva nei territori verso il Pacifico. Pochissimi, si badi bene, avevano dapprima chiesto la liberazione degli schiavi, che mantenevano l’economia agricola del Sud. Si trattava piuttosto di un contrasto politico tra la politica federale unitaria di Washington e la concezione decentrata del Sud, dove infatti ancor oggi la guerra civile è definita «Guerra tra gli Stati». Ma il geniale presidente Abraham Lincoln, che a lungo aveva cercato un compromesso per evitare le stragi orrende, comprese infine che la libera repubblica non poteva accettare che esseri umani venissero comprati e venduti come capi di bestiame.
Nel gennaio del 1863 Lincoln firmò un ordine presidenziale per l’emancipazione degli schiavi, che liberava, almeno sulla carta, tre milioni e centomila afroamericani ancora in catene negli Stati Confederati. La guerra, da dilemma di potere divenne crociata di liberazione: Lincoln, come poi nel discorso letto a novembre a Gettysburg, affermava che il razzismo è impossibile da accettare in una democrazia. Il male che ancora oggi perseguita l’America ebbe dunque, al momento della firma della resa del Sud e della ritrovata pace in America, un suo episodio chiave, spesso dimenticato in Europa, per comprendere la storia del razzismo. Il testo dell’armistizio era stato stilato per il generale Grant, futuro presidente americano, dal suo segretario particolare, il generale Ely Parker. Indiano della tribù dei Seneca, Parker era stato educato dai missionari cristiani e si era laureato in legge, per scoprire come per la sua gente fosse impossibile avere una licenza da avvocato in tribunale. Aveva allora preso un diploma in ingegneria, rivelandosi così brillante da venir reclutato da Grant nel Genio militare. Aveva redatto lui stesso, con l’esperienza legale, il testo dell’armistizio, e il documento originale ne conserva la calligrafia. Al tavolo ufficiale il generale sudista Lee lo riconobbe come un indiano, per la pelle scura, e gli tese la mano sorridendo: «Mi fa piacere veder qui un vero americano», ricordando che i primi abitanti del continente nordamericano furono proprio gli antenati di Ely Parker. Il generale Parker, stretto nella sua divisa blu, rispose cortese e fermo: «Siamo tutti americani qui».
Piccoli grandi progressi
«Siamo tutti americani», dal 1776 la repubblica cerca di dare, con progressi e lentezze dolorose, verità all’orgogliosa sentenza di Parker. I progressi sono stati straordinari, ancora settant’anni or sono era impossibile per un afroamericano sposare un coniuge bianco, usare un ristorante o un hotel al Sud; perfino accedere ai bagni, se non per colored. Durante la Seconda guerra mondiale, ufficiali tedeschi presi prigionieri in Germania da truppe americane si stupirono nel vedere che a loro era aperta la mensa ufficiali Usa, mentre i neri, anche se di grado, dovevano usare mense a parte. Combattuta per liberare l’Europa dal razzismo e dall’antisemitismo, la guerra americana fu vinta da un esercito segregato. E fu proprio il presidente Truman, succeduto a Roosevelt nel 1944 e rieletto nel 1948, a fare delle forze armate uno strumento formidabile di integrazione: le stellette davano a chiunque uno stipendio, una carriera, dignità e rispetto. E l’ex generale Eisenhower, eletto presidente nel 1952, spedì la Guardia Nazionale a Little Rock, in Arkansas, per impedire che i poliziotti del governatore Orval Faubus, e folle di teppisti, proibissero agli studenti neri di iscriversi alle scuole pubbliche, dopo la storica sentenza della Corte Suprema del 17 maggio 1954 che aveva, per sempre, messo al bando scuole separate per bianchi e neri.
L’avvocato dei diritti civili Thurgood Marshall è, nel 1967, il primo nero nominato giudice della Corte Suprema, il generale Colin Powell sarà il primo capo di Stato maggiore della Difesa, consigliere per la Sicurezza nazionale e segretario di Stato, con Reagan, Bush padre e figlio, e Condoleezza Rice sarà la prima donna nera consigliere per la Sicurezza nazionale e segretario di Stato. Nel 2008 Barack Hussein Obama romperà l’ultimo tabù venendo eletto primo presidente degli Stati Uniti d’America, e rieletto nel 2012. La strada del progresso è seminata dalle croci della sofferenza durante la schiavitù e, dopo la sua abolizione, dalle leggi non scritte di Jim Crow, che impedivano ai neri al Sud ogni diritto civile. La forca dei linciaggi razzisti del Ku Klux Klan, organizzazione terrorista fondata da ex ufficiali confederati per impedire che al Sud, dopo la sconfitta, i neri si liberassero davvero, resta simbolo di oppressione. Durante la Ricostruzione del XIX secolo, in realtà, poco mutò per i neri, liberi di diritto, schiavi di fatto. È la Seconda guerra mondiale, con il poderoso sforzo industriale che scuote il Paese, a indurre l’emigrazione di massa che trasforma milioni di afroamericani da braccianti poveri in campagna in operai attivi delle grandi metropoli, offrendo, ai loro figli, migliori condizioni di vita.
Mosaico di culture
Spesso per gli europei il razzismo in America è ridotto al conflitto bianchi-neri, da La capanna dello zio Tom, romantico romanzo della scrittrice bianca Harriet Beecher Stowe, ai film combattivi del regista Spike Lee, passando per le lotte del Nobel per la pace reverendo martire dei diritti Martin Luther King e del suo compagno di strada radicale, Malcolm X. Ma in realtà ogni comunità ha sofferto e patito prima di integrarsi nel «crogiolo di fusione» americano che ora tanti preferiscono definire «mosaico», disegno unico composto da identità diverse. Gli irlandesi vennero disprezzati dagli inglesi, perché cattolici, dopo la grande emigrazione dovuta alla carestia per la rovina del raccolto delle patate nel XIX secolo. Gli ebrei erano discriminati per la loro religione, e ancora nel XX secolo lo scrittore Arthur Miller dedicò al dramma dell’antisemitismo il suo angosciato romanzo Focus: le migliori università avevano una «quota» limitata di studenti ebrei da ammettere, gli altri restavano fuori. I polacchi erano emarginati, cattolici e dell’Est Europa e italiani dovettero subire ogni umiliazione, chiamati «wop», gente senza documenti, «guinea», come i porcellini d’India.
Ancora negli anni Cinquanta si leggevano nello Stato di New York cartelli con offerte di lavoro «Esclusi negri e italiani…» e il giovane avvocato italoamericano Mario Cuomo, futuro governatore, non venne assunto dagli studi legali di Wall Street perché rifiutò di anglicizzare nome e cognome. I cinesi vennero sfruttati a sangue, come «coolies» (portatori), per costruire ferrovie e città, salvo poi venire esclusi dall’emigrazione con una legge ad hoc, del 1882, rimasta in vigore fino al 1943. Dopo l’attacco giapponese alla base americana di Pearl Harbor nel 1941, 110 mila cittadini di origine giapponese vennero deportati in campi di prigionia dal presidente Roosevelt, mentre i loro figli combattevano in prima linea nell’esercito americano. I messicani venivano disprezzati come «wetbacks», sederi bagnati, perché arrivavano clandestini, guadando i fiumi al confine. C’è, nel bel film di Clint Eastwood Gran Torino, una magnifica scena in cui l’attore, interpretando un duro ex militare di origine polacca, spiega a un bambino, vicino di casa asiatico, come funzionino i rapporti tra gruppi etnici, portandolo dal suo barbiere italiano. I due uomini si scambiano battutacce razziste, legati però da affetto e stima reciproci: Eastwood chiarisce al ragazzino, figlio di immigrati, che ci si può voler bene e prendersi in giro, integrarsi pur restando diversi e fieri del proprio passato.
Il virus dell’intolleranza
I problemi però restano. C’è ancora meno educazione e lavoro tra i neri – gli asiatici sono più integrati, tra i latinoamericani alcune comunità eccellono, vedi i cubani –, droghe e criminalità sono diffuse, e le forze di polizia spesso commettono atti di violenza che sono costati, tra il giugno del 2015 e il giugno del 2016, 381 vittime nere (contro 732 bianche, ma con una minore presenza percentuale, fonte «Washington Post»). La polizia si difende ricordando che la maggior parte dei crimini violenti sono commessi da membri delle minoranze, ma le troppe vittime scatenano comunque manifestazioni e polemiche.Gli europei a volte alzano un po’ il ciglio nel giudicare il razzismo Usa, ma verrebbe da obiettare: quanti anni ci vorranno per un premier di origine giamaicana eletto in Gran Bretagna, un cancelliere dal nome turco al potere in Germania, un presidente di famiglia algerina a Parigi e un presidente del consiglio emigrato dall’Albania in Italia? Scommetterei non li vedremo presto.
Società omogenee, per razza, cultura, religione, tradizioni, conoscono meno il razzismo; società cosmopolite ne soffrono di più: badate a quel che è accaduto in Italia e in Europa durante i flussi migratori, nell’XIX, XX e XXI secolo e vedrete come, purtroppo, nessuno è esente dal virus dell’intolleranza. L’elezione di Obama, che aveva segnato un giorno storico per i diritti in America, si lascia alle spalle rancori e veleni che, nell’elezione del repubblicano Donald Trump, fanno riaffiorare spettri e umori che si credevano per sempre fugati. La destra detta «Alt Right» e certi consiglieri convocati per la Casa Bianca, come Steve Bannon, animatore del sito «Breitbart», impiegano toni che violano l’intesa scherzosa di Eastwood, criticando e irridendo le minoranze con linguaggi discriminatori, violenti, a tratti razzisti. È la nuova sfida che la nuova generazione dei millennials, pionieri del nuovo secolo, dovrà affrontare perché davvero tutti, e finalmente, possano essere americani, come il saggio generale Parker auspicò nel 1865.