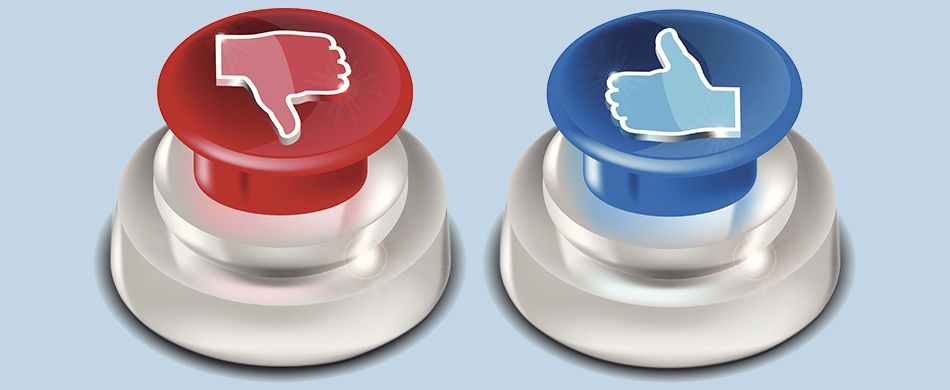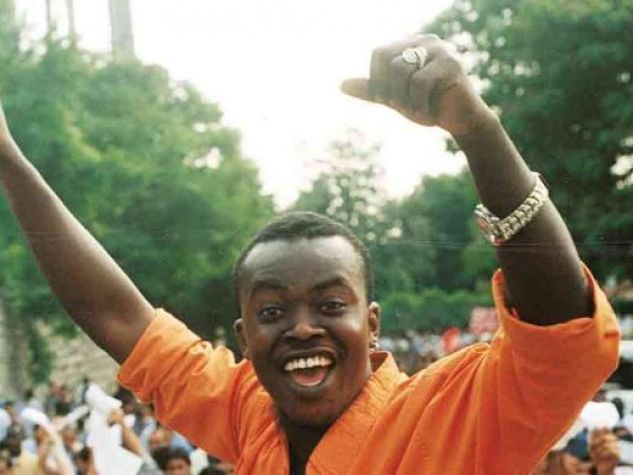Comunicare il positivo vince
Caro direttore, quando leggo il “Messaggero di sant’Antonio” tiro un sospiro di sollievo: è una luce in questi tempi bui». Frasi simili, che appaiono spesso nei messaggi dei nostri lettori, provocano in redazione reazioni positive ma anche qualche perplessità. L’aspetto positivo sta nel fatto che la scelta della rivista è sempre stata quella di dare corpo e anima in chiave moderna alla «Buona Novella» cioè al Vangelo.
Tuttavia, e qui s’insinua la perplessità, «buona novella» letteralmente significa «buona notizia» e le buone notizie nel circuito mediatico di oggi non godono di grande fama. Sembrano edulcorate, scritte per persone sentimentali e un po’ ingenue, mentre nella realtà il mondo è «brutto e cattivo». Di fatto tg, giornali e siti d’informazione sembrano veri e propri collettori di brutte notizie: il gesto razzista, la strage stradale, il comune chiuso per mafia, il Pil che collassa, il disoccupato che si suicida, l’ultimo femminicidio. Ma davvero la gente è più attratta dalle cattive notizie?
Alcuni studiosi affermano che c’è un “gene”
legato alla nostra storia evolutiva
che ci fa preferire le brutte notizie.
Una ricerca di due psicologi canadesi (2016), Marc Trussler e Stuart Soroka, dell’Università McGill, aveva proprio il fine di rispondere alla domanda. I risultati hanno confermato che le persone sono più attratte dalle cattive notizie, anche se affermano di preferire le buone. I motivi sarebbero due: la gente cerca le cattive notizie perché crede che il mondo in cui vive sia in realtà migliore della media. Il secondo motivo è quello che gli psicologi chiamano «pregiudizio di negatività», secondo il quale l’umanità si è evoluta reagendo alle potenziali minacce proprio grazie alle «cattive notizie», spie di pericolo che le hanno permesso di evitare i rischi e proteggere la specie. Insomma, secondo gli studiosi, «il gene della cattiva notizia» è inscritto nel nostro DNA e, in qualche modo, ci influenza ancora oggi. Resta da capire se dopo millenni di civiltà sia ancora giusto dare troppo spazio a quel gene.
Il Reuters Institute di Oxford, uno dei più importanti osservatori a livello mondiale sui media, ha messo a disposizione altri dati, che, al contrario, dimostrerebbero che quel gene conta sempre meno. La ricerca registra un allontanamento del pubblico dalle notizie: Il 48 per cento «perché possono avere un effetto negativo sul mio umore» e il 37 per cento perché non si fida delle notizie.
Secondo il Reuters Institute le persone
si allontanano dai notiziari perché hanno
un effetto negativo sul loro umore (48%)
e perché non si fidano (37%)
«Tale distanza è ormai innegabile – spiega Roberto Reale, ex vicedirettore Rainews e professore di Comunicazione all’Università di Padova – e ha a mio avviso due ragioni. La prima è che le notizie più che essere “negative” sono allarmistiche, e la gente non è più disposta a farsi spaventare e destabilizzare di continuo. La seconda ragione è che siamo bombardati da una grande quantità di notizie che sono frammentarie e contraddittorie. Il pubblico è frastornato e infastidito, e non sa più a chi credere».
E così il rischio più grave è la rassegnazione. Reuters rileva che il 28 per cento del campione, quindi quasi 1 persona su 3, evita le notizie «perché tanto io non ci posso fare niente». Una reazione che porta al disimpegno, alla chiusura nel proprio mondo, magari nella cerchia degli amici di Facebook, scelti in base alle proprie convinzioni. Senza più confronto con altre visioni. «Evitare tale deriva è una delle responsabilità più grandi di chi si occupa di comunicazione oggi, ma è una responsabilità, anche se in forma minore, di qualunque cittadino che usi il proprio smartphone diffondendo notizie negative, incontrollate, offensive. Prima di postare, fermiamoci a riflettere. Sarebbe già una conquista» conclude Reale.
Se il giornalismo, specchio della verità, riflette solo il male,
la percezione è che il “bene” sia solo un'eccezione.
Una ricerca di Ipsos dimostra che è vero il contrario.
Tuttavia, è il giornalismo il più grande imputato, visto che la ricerca della verità, unita alla correttezza e alla pubblica utilità sono alcuni dei suoi principi fondativi. Carl Bernstein, il giornalista del caso Watergate, afferma che «il giornalismo è la migliore versione ottenibile della verità». Tuttavia, se le cattive notizie occupano la maggior parte degli spazi nei media, ciò può indurci a pensare che «il male» sia la miglior versione ottenibile della verità, mentre «il bene» sia molto marginale.
Visione contraddetta da un’altra ricerca internazionale, realizzata da Ipsos, «I pericoli della percezione». Ecco alcuni dati sul Belpaese. Secondo l’indagine, gli italiani credono che la disoccupazione sia al 38 per cento, mentre in realtà è all’11; sono convinti che il nostro Paese si collochi al 69° posto nella graduatoria delle principali economie mondiali, mentre siamo all’ottavo. «È vero che se invece di usare il Pil riscriviamo la classifica per ricchezza pro-capite scendiamo dall’8° al 33° posto, ma siamo comunque in una posizione nettamente migliore rispetto a quella percepita» commenta Roberto Basso, giornalista, coautore con Dino Pesole di un libro appena uscito L’economia percepita (Ed. Donzelli). E introduce il vero problema che sta alla base di una comunicazione orientata al negativo: «Il guaio è che alle percezioni seguono i comportamenti: se si pensa che le cose vadano male, le famiglie consumeranno meno e gli investitori smetteranno di investire. E l’economia peggiorerà».
Esempi simili sono possibili in tutti gli ambiti della vita sociale: «In molte indagini sulla situazione della sicurezza dei quartieri – avverte Roberto Reale –, la gente afferma che c’è più degrado. Ma se poi la si intervista sul proprio quartiere, il più delle volte risponde: “Intorno a me va meglio”. Ciò significa che l’opinione non viene da un’esperienza diretta, ma da informazioni che sono arrivare dai media, dal sentito dire o dall’account di un politico che soffia sul fuoco».
«Il vero problema è il marketing della notizia,
le notizie allarmistiche passano
nella convinzione che ciò serva a vendere di più»
Una deriva che ha una vecchia radice: «Il vero problema è il marketing della notizia – spiega Reale –. Le notizie allarmistiche passano, mentre altre più utili o interessanti sono cancellate, perché c’è la convinzione che così facendo si venda di più». Un problema che viene però ingigantito dalle potenzialità e dalla velocità dei nuovi mezzi di comunicazione: «Nel caos mediatico, all’informazione veritiera, utile ma magari più lenta e difficile da leggere, si sostituiscono gli slogan e le soluzioni a buon mercato».
La posta in gioco è altissima: «Una democrazia non può vivere solo di un pubblico che sta di fronte ai talk show, che scarica la rabbia sui social, ma che non sa nulla di ciò che sta accadendo nel proprio Paese. Diventa una democrazia dell’emotività, irrazionale e manipolabile».
Fatta l’analisi, come se ne esce? Abbiamo innanzitutto bisogno di un’alfabetizzazione mediatica. «Le novità tecnologiche si sono mosse a una velocità molto superiore rispetto alla nostra capacità di rifletterci, di organizzarci e di rispondere adeguatamente – replica Reale – . Usiamo gli smartphone e i social media tutti i giorni, ma non sappiamo nulla degli algoritmi e delle logiche che li governano. Il tema della comunicazione è uno dei più importanti, perché incrocia tutte le interazioni dell’umano, eppure è uno dei meno studiati».
«Una democrazia non può vivere
solo di un pubblico che sta di fronte ai talk show,
che scarica la rabbia sui social, ma che non sa nulla di ciò che accade.
Diventa una democrazia manipolabile».
Un altro aspetto riguarda in particolare gli operatori dell’informazione, giornalisti e non solo: «È fondamentale dare un contesto alla notizia, fornire delle chiavi di lettura, dare i mezzi per sviluppare la coscienza critica. È un lavoro doveroso, che richiede una fatica pari a quella di risalire un fiume controcorrente con una barca a remi. Oggi il mito è la velocità, il pubblicare tutto e subito. Ma è un errore».
Il cambiamento è difficile ma è possibile, continua Reale: «I fenomeni sociali sono sempre dialettici, cioè sono in continua evoluzione. Questa è una fase di transizione, dove domina il disordine, ma qualcosa sta già cambiando. Ci sono segnali di una crescita di consapevolezza. Molta gente, per esempio, non sopporta più questa confusione mediatica e sta mostrando anticorpi contro l’aggressività in Rete e l’attacco ad alcuni diritti e valori fondamentali per la società».
«Siamo in una fase di transizione. Qualcosa sta cambiando.
Crescono gli anticorpi contro la confusione mediatica
e l’aggressività in rete. Abbiamo bisogno della parola che illumina»
La parola verità in greco si dice aleteia, conclude il professore: «che letteralmente significa “ciò che sta in luce, ciò che è fuori dall’ombra”». Anche papa Francesco usa spesso il verbo «illuminare» nei suoi discorsi. Ecco, ci vogliono fonti e persone che illuminano. Sant’Antonio forse oggi direbbe che è una delle forme della carità.
Nel Dossier completo, pubblicato nel numero di giugno 2019 del Messaggero di sant’Antonio, un’intervista a Mario Calabresi di Claudio Zerbetto, un approfondimento sul giornalismo costruttivo di Nicoletta Masetto e un intervento di Sabina Fadel su Antonio, santo della Parola. Prova la versione online del nostro mensile.