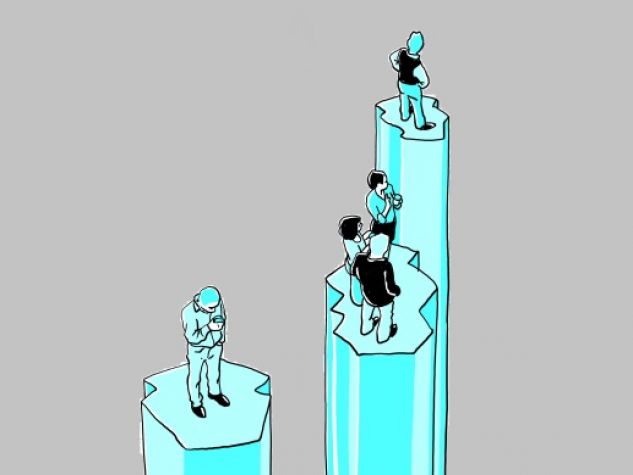Soldi e cura
La Bibbia potrebbe essere raccontata anche attraverso le sue monete. A partire dai trecento sicli d’argento pagati da Abramo per comprare dagli ittiti la tomba di sua moglie Sarah, il primo contratto monetario di cui si ha traccia nella Bibbia (Gen 23). Sempre nel libro della Genesi, la parola profitto (bècà), presa in prestito dal lessico commerciale del tempo, fa la sua comparsa nell’episodio della vendita di Giuseppe da parte dei suoi fratelli: «Quale profitto se uccidiamo nostro fratello?» (Gen 37,26). Così, dopo averlo gettato nella cisterna, i fratelli diedero retta a Giuda, e «per venti sicli di argento vendettero Giuseppe» (Gen 37,28) a dei mercanti di passaggio in viaggio verso l’Egitto.
Fratelli che vendono un fratello, e mercanti che lo comprano. Il profitto dei mercanti che entra da subito in conflitto con il valore della fraternità. Venti sicli era il prezzo di uno schiavo o di un paio di sandali (Amos), venti volte meno dei quattrocento sicli di Abramo. Questa somma infima pagata per un fratello dice disprezzo della vita e della fraternità. Giuseppe, poi (cap. 37), donerà a suo fratello minore Beniamino 300 sicli, dodici volte più del prezzo pagato per la sua vendita, un dono che supera dodici volte il profitto. Basterebbe questo ingresso del lucro dentro la Bibbia per intuire l’origine dell’ambivalenza del denaro nell’umanesimo biblico. Il cristianesimo, poi, ha ripreso e sviluppato questa ambivalenza, a partire dagli stessi vangeli, dove abbondano le monete, presenti in testi decisivi, dalla dracma perduta all’operaio dell’ultima ora, per non parlare di debiti e debitori presenti addirittura dentro il Paternoster.
Gesù scaccia i cambiavalute dal tempio di Gerusalemme, mette la religione del denaro («mammona») in alternativa alla propria; ma poi Luca ci narra una parabola, quella dei talenti – considerata, tra l’altro, tra le poche narrate probabilmente dal Gesù storico –, dove la logica del Regno dei cieli è affidata a due «procuratori» lodati perché hanno investito il denaro ricevuto, mentre il terzo è rimproverato in quanto pigro e avaro. Ma i denari più famosi della Bibbia cristiana sono senz’altro i trenta di Giuda. Il vangelo di Giovanni ci mostra Giuda che rimprovera la donna di Betania che aveva sprecato olio per Gesù: «Perché non si è venduto questo profumo per trecento denari e non si sono dati ai poveri?» (12,5). A dirci che Giuda oltre a essere traditore fu anche pessimo mercante, per aver svenduto per pochi denari il Cristo, che aveva un valore immenso.
Ma non finisce qua la presenza del denaro nel Vangelo. Ci sono anche i due denari che il buon Samaritano paga all’albergatore, aggiungendo quella bellissima frase: «Abbi cura di lui» (Lc 10,35). Questi due denari pagati per la cura ci dicono molte cose. Il samaritano avrebbe potuto invocare la sua stessa gratuità anche per l’albergatore, ma non lo fa: lo paga, e così riconosce il valore del lavoro di cura. Allora pagare un prezzo può essere un buon strumento per la cura. Non è solo il dono gratuito il buon linguaggio della cura. Al tempo stesso, il contratto con l’albergatore è pienamente cristiano e umano se è preceduto dalla cura diversa e gratuita del Samaritano, che si prende, appunto, cura della vittima imbattutasi nei briganti per il «movimento delle viscere». Oggi i pagamenti per la cura non mancano, ma essa è pagata sempre troppo poco, perché socialmente non stimata. Dalla rivoluzione della cura operata dal covid usciremo pagando meglio la cura stessa (e quindi le donne, che spesso sono quelle a essa dedite), e reimparando a chinarci sulle vittime, perché ancora capaci di sentir commuovere le nostre viscere davanti al dolore del mondo.
Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!