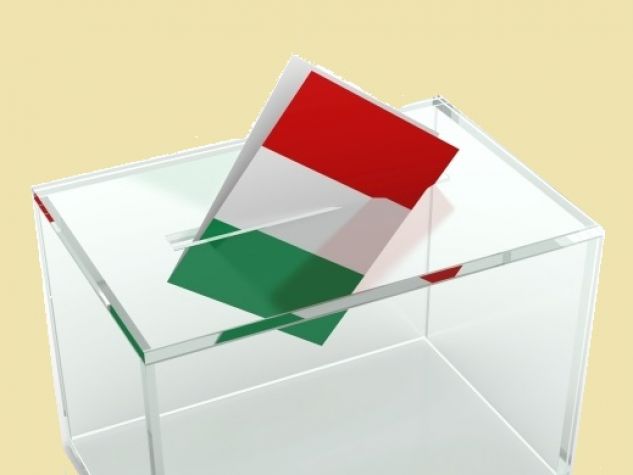Carità in azione
Si racconta che un giorno uno studente chiese all’antropologa Margaret Mead quando, a suo parere, fosse nata la civiltà umana. Lo studente si aspettava che Mead parlasse di fuoco, di pentole di terracotta, al limite di armi per cacciare. E invece Mead gli rispose che il primo segno di civiltà in una cultura antica era un femore rotto e poi guarito. All’interdetto studente spiegò, infatti, che nel regno animale quando uno si rompeva una gamba era destinato a morire, perché non sarebbe più potuto scappare dai predatori, né procurarsi acqua o cibo. E quindi un femore rotto e guarito era la prova che qualcuno, comprendendo il rischio che il ferito correva, si era preso del tempo per aiutarlo, portandolo in un luogo sicuro e provvedendogli cibo e acqua finché non fosse stato in grado di tornare a badare a se stesso. Pertanto aiutare qualcun altro nelle difficoltà è il punto preciso in cui la civiltà inizia.
Fermarsi, osservare, accorgersi del bisogno, farsi vicini e agire. Tutti verbi che rimandano a un’attitudine umana antichissima: la compassione. Un’attitudine che comincia a svilupparsi nel bambino già attorno ai pochi mesi di vita e che egli impara dai genitori, in particolare dalla madre, quando (come scrive Daniel Goleman nel suo best-seller Intelligenza emotiva) comincia a decodificare dalle espressioni del suo volto e dai suoi gesti le emozioni che essa prova. È un’alfabetizzazione primaria fondamentale per sviluppare l’empatia (la capacità di comprendere, di sentire nel profondo lo stato d’animo o la situazione di un’altra persona), empatia che rappresenta una sorta di trampolino di lancio per la compassione.
Empatia e compassione, infatti, nonostante spesso vengano confuse, sono differenti. «L’empatia – spiega Stefano Manera, medico chirurgo esperto in medicina integrata e funzionale, nel corso di un TEDx tenuto nel novembre 2023 – è un’emozione, mentre la compassione è un sentimento» vale a dire che è qualcosa di più complesso. «Compassione non è solo comprendere intimamente quello che l’altro sta provando – continua –, ma agire per alleviare quel dolore. Le neuroscienze, infatti, ci dicono che provare compassione stimola le aree corticali motorie del nostro cervello ed è quindi una condizione che porta necessariamente ad agire». Ma la compassione non è neppure pietà. «Pietà significa semplicemente dispiacersi per l’altra persona, ma con un lieve grado di comprensione dell’esperienza dell’altro e inoltre prevede anche una bassa dose di azione. Come a dire: mi dispiace per quello che provi, ma mi giro e riprendo a fare ciò che stavo facendo prima di incontrarti».
Compatire, quindi, comprende la pietà e l’empatia, ma va oltre: prevede una potenza di comprensione senza pari e una nostra azione decisa, mirata. «La compassione – chiosa l’esperto – quando è tale ha due importantissime qualità: la prima è la consapevolezza emotiva. Noi siamo davvero consapevoli di quello che stiamo provando, delle nostre emozioni. E la seconda qualità è la comprensione razionale. Non solo siamo consapevoli, ma razionalizziamo. Facciamo partire le aree corticali. La compassione si manifesta, dunque, quando ci allontaniamo dall’eccesso emotivo e ci chiediamo che cosa possiamo fare realmente per l’altra persona che sta soffrendo». Ed è questo allontanamento dall’esplosione emotiva che ci permette di prendere delle decisioni realmente efficaci per l’altra persona e anche per noi stessi.
Lo dimostra una volta di più uno studio condotto qualche tempo fa dalla neuroscienziata Tania Singer, che a Berlino dirige il Social Neuroscience Lab della Max Planck Society. Singer eseguì, infatti, una serie di scansioni cerebrali su un monaco buddista, Matthieu Ricard, il quale venne per l’occasione collegato a una macchina per la risonanza magnetica funzionale, mentre gli veniva chiesto di immaginare in modo compassionevole la sofferenza di un bambino orfano. Verificando i risultati della risonanza, Singer si accorse che, a differenza di quanto era accaduto precedentemente con altri soggetti sottoposti al medesimo esperimento, il pensiero non attivava le stesse aree cerebrali del dolore fisico reale, ma quelle aree associate alla ricompensa, come se il monaco stesse provando una sensazione piacevole.
Interrogato dalla neuroscienziata, Ricard rispose che gli era stato chiesto di effettuare una meditazione compassionevole su quel bambino, non di immedesimarsi semplicemente in lui. Singer capì in tal modo che empatia e compassione operano attraverso diverse reti neurali: l’empatia provoca sofferenza immediata, la compassione fa agire, perché è radicata nel nostro sistema di cura. E, agendo, ci sentiamo utili e dunque sperimentiamo sensazioni positive. Se quindi le cose stanno così, capiamo bene l’importanza della compassione in un tempo complesso e difficile come il nostro: uno sguardo compassionevole può infatti contribuire a cambiare il mondo. (Continua...)
Puoi leggere il dossier completo nel numero di marzo del «Messaggero di sant'Antonio» e nella versione digitale della rivista. Provala ora!