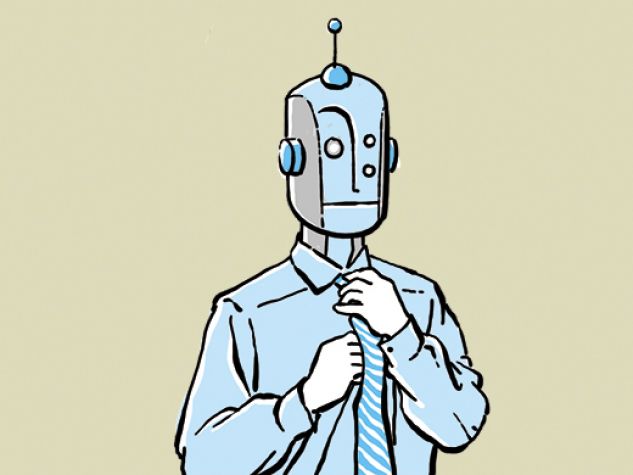Don Alberto Ravagnani, youtuber in «clergyman»
28 marzo 2020. Siamo nel momento più difficile della pandemia di covid-19. Da venti giorni l’Italia tutta è confinata. I ragazzi, lontani dai compagni e dagli amici, e spesso con qualche parente o conoscente malato o ricoverato o addirittura morto per il virus, non esprimono a voce alta il loro disagio e, d’altra parte, chi mai li ascolterebbe ora? Eppure i loro sguardi persi vanno accolti, e rassicurati se possibile. Vanno consolati. «Sì, ma come, se non posso vederli?» si chiede un giovane prete della parrocchia di San Michele Arcangelo, a Busto Arsizio, in provincia di Varese. «Potrei usare i social!» è la sua risposta immediata. Don Alberto Ravagnani, così si chiama il giovane sacerdote (27 anni appena) comincia così a girare qualche video che poi manda ai «suoi» ragazzi.
I video sono intelligenti, divertenti ma, soprattutto, talmente ben realizzati da non avere nulla da invidiare a quelli di tanti youtuber famosi. E infatti qualcuno gli dice subito: «Don, ma perché non li posti»? Lui, un po’ scettico all’inizio, ascolta il consiglio. E accade il «miracolo». Nel giro di pochi giorni i video su YouTube hanno decine di migliaia di visualizzazioni. Ma è soprattutto uno a lanciare don Ravagnani nell’olimpo degli youtuber italiani più seguiti. Un video che ha come tema la preghiera (A che cosa serve pregare?) e che, a dispetto dell’argomento di scarso appeal per un giovane, raggiunge in men che non si dica le oltre 600 mila visualizzazioni. Da lì in poi è un’apoteosi: i suoi video raggiungono una media di 60 mila visualizzazioni e il suo canale YouTube si ritrova in poche settimane con oltre 80 mila iscritti.
Msa. Don Alberto, ma come si fa a parlare di fede, e bene, sul web?
Ravagnani. Innanzitutto bisogna amare il contenuto di cui si vuole parlare, essere appassionati del Vangelo, di Dio, bisogna amare la Chiesa. Poi è normale desiderare che questo amore si veda concretamente, anche nella forma, perché ci si tiene. Inoltre, bisogna avere chiaro il modo in cui oggi i giovani recepiscono i temi di fede. In questo momento il credito dato ai preti, alla Chiesa, alla religione è molto basso e, vivendo a contatto coi ragazzi, a scuola o in oratorio, vedo che purtroppo il gap generazionale aumenta sempre di più man mano che l’età si abbassa. Quindi, se voglio colpire i ragazzi, così come il Vangelo ha colpito la mia vita, devo trovare una modalità che possa sorprenderli.
Ma perché la Chiesa di oggi fatica a parlare coi giovani?
L’origine del gap andrei a ricercarla nei movimenti del ’68, quando si è verificata una prima frattura tra i giovani e le istituzioni come la Chiesa. Lo sviluppo tecnologico degli ultimi decenni, uno sviluppo che non è mai stato così rapido prima e che ha inciso sul modo di comunicare, sul modo di concepire lo spazio e il tempo, la propria vita e la propria morte, ha poi aumentato in modo esponenziale tale frattura, perché i ragazzi sono stati portati avanti da quest’onda tecnologica, che ha lasciato indietro gli adulti. Oggi, quindi, la comunicazione giovani-adulti è davvero molto difficile e la Chiesa è rimasta intrappolata in questa difficoltà, sia perché è l’istituzione più istituzionale di tutte, sia perché è retta sostanzialmente dagli anziani. La difficoltà, quindi, secondo me, non è tanto legata a una distanza di vedute, ma proprio a un’incapacità di comunicare, perché il linguaggio diverso allontana i due mondi.
Ma come si fa a imparare un nuovo linguaggio in tema di fede?
Per impararlo bisogna parlarlo. Per imparare una lingua straniera posso studiarla sui libri, apprendere la grammatica, ma non automaticamente tutto ciò sarà funzionale alla comunicazione. Per comunicare davvero dovrò infatti andare dove la lingua si parla, perché quello che conta, al di là delle regole, è l’atto comunicativo che intercorre tra due persone che dialogano. Allo stesso modo, per trasmettere la fede, c’è bisogno di comunicare. Certo, bisogna prima conoscerne l’Abc, sapere la dottrina, il catechismo, ma poi la fede va comunicata in modo che l’altra persona possa recepire ciò che sto dicendo. E se, per farmi capire, dovrò ritoccare un po’ la forma dei miei contenuti, io credo che dobbiamo essere disposti a farlo. San Paolo diceva che lui si era fatto tutto a tutti, per poter salvare qualcuno. Ora, secondo me, questa spinta missionaria evangelizzatrice di san Paolo è la stessa che deve guidare oggi la Chiesa che, pur di comunicare il Vangelo alle persone, deve farsi un po’ come loro, parlare un po’ come loro, utilizzare gli strumenti che utilizzano loro. Questo non va a detrimento del Vangelo, anzi.
Lei, oltre che su YouTube, è anche su Instagram, su Tik Tok e su Facebook. C’è un modo diverso di comunicare la fede attraverso questi canali?
Assolutamente sì. Sono social diversi, con linguaggi diversi, utenze diverse, modalità diverse. Facebook è un social più riflessivo ed è utilizzato oggi più dalla popolazione adulta/anziana, grazie alla sua possibilità di scrivere lunghi post. Instagram, invece, ha un’utenza più giovane, e funziona con immagini ferme, belle, curate, attraverso le quali ci si presenta, si racconta la propria quotidianità. Tik Tok è il social più nuovo, in fermento, il più informale, nel quale si usano foto in movimento, video brevi che devono catturare l’attenzione degli utenti e che vogliono solo presentare un po’ la vita di chi partecipa, condividendo qualche pensiero. Quindi, nel momento in cui io devo utilizzare un social media per parlare di fede, devo capire che tipo di linguaggio esso mi permette di usare, come funziona e quali sono le persone che mi guarderanno. È anche qui una questione di educazione digitale. Io sono la stessa persona sempre, sia quando parlo coi miei amici sia quando parlo coi miei professori o coi miei genitori, però in ciascuno di questi contesti uso un tono e un linguaggio diversi: parlare allo stesso modo con tutti sarebbe un errore di comunicazione. E questo vale pure per la fede: il Vangelo è lo stesso, noi siamo sempre gli stessi, ma se dobbiamo parlare di Dio su Tik Tok non lo possiamo fare come fossimo su Instagram o su Facebook.
Lei attraverso i social raggiunge tantissimi ragazzi che normalmente non frequentano la Chiesa. Quali sono, in base alla sua esperienza, i valori che per loro sono importanti?
Sui social sono stato contattato da tanti giovani che si definiscono atei o lontani, eppure hanno scritto a me, don Alberto, che sono un prete, mi vesto da prete e dico cose da prete. In loro ho visto molto forte questo mito della libertà, ma si tratta di una pseudolibertà assoluta, senza regole, senza istituzioni, senza precetti, senza dogmi. I ragazzi, ma direi che è un fenomeno trasversale che riguarda anche molti adulti, vogliono essere liberi, e non si rendono conto che i legami, le relazioni sono proprio ciò che ci rende più liberi in assoluto, perché ci rende responsabili. Non comprendono che le norme o i precetti della Chiesa tracciano in realtà percorsi autentci che aiutano a custodire la libertà, rendendola davvero tale, cioè esprimendola nella forma della responsabilità.
Di recente non solo ha avuto modo di dialogare, attraverso le storie di Instagram, addirittura con Fedez, ma ha pure partecipato con lui a un episodio di Muschio Selvaggio.
Sì. Tutto parte da un passaggio di una recente canzone di Fedez, Roses, che dice: «Meglio bimbe di Conte che bimbi dai preti». Quando l’ho sentito, sono rimasto amareggiato, non tanto per la posizione di Fedez, ormai risaputa, ma per la possibile risonanza di questa canzone che sarebbe stata ascoltata da milioni di persone milioni di volte e sarebbe stata interiorizzata dai ragazzi più giovani. Si continua a dire che i preti sono pedofili e che è meglio tenere i bambini lontani da loro, ma questo è l’esatto contrario di quello che io e tanti miei confratelli cerchiamo di fare negli oratori, con la nostra presenza nelle scuole, con le miriadi di attività nelle parrocchie in cui siamo a contatto con centinaia di migliaia di bambini in tutta Italia. E questo fa del bene alle persone. Fedez stesso è cresciuto in oratorio. Dire queste cose con tanta leggerezza forse a lui non cambia la vita, però rischia di rovinare la fiducia dei genitori e dei bambini stessi nei confronti dei sacerdoti e dell’azione della Chiesa. Quindi ho fatto delle storie in cui ho salutato Fedez, gli ho detto che ascolto le sue canzoni, però poi gli ho mostrato l’altra faccia della medaglia: è vero che anche nella Chiesa ci sono stati veri e propri scandali legati alla pedofilia, però è altrettanto vero che c’è molto altro e che continuare a guardare il male che c’è stato rischia di far dimenticare il bene che c’è ed è molto di più. Lui ha sentito la mie storie, perché ormai vengono tutte condivise migliaia di volte, e mi ha risposto. Ho apprezzato che l’abbia fatto, perché mi ha permesso di dare voce a tanti sacerdoti che, come me, si spendono con i giovani per il Vangelo. Poi, in oratorio, dove l’ho invitato, non è venuto, ma, chissà?, forse un giorno ci farà una sorpresa…
Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!