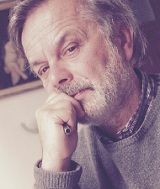La solitudine e la forza dell’Italia interna

Sono 13 milioni di italiani, vivono sul 60% del territorio nazionale, lontano dalle grandi città, abitano montagne e colline. Le chiamano Aree Interne e una «strategia nazionale» le condanna a uno «spopolamento irreversibile». Così non è: per la prima volta, gli abitanti della montagna sono cresciuti. I paesi si ribellano a un destino già scritto e rivendicano, con sindaci e vescovi in prima fila, il diritto a un futuro.
Ho passato tre mesi a Capracotta. Alto Molise, sul confine con l’Abruzzo. Il secondo comune più alto degli Appennini. 1421 metri. Un’Italia che più interna non si può. 750 residenti, ma se chiedi in giro confessano: «Saremo meno di quattrocento a vivere qui tutto l’anno». Fa freddo a Capracotta, un gran freddo, arrivano venti gelidi dai Balcani. I paesani rivendicano il record mondiale della nevicata in un solo giorno: 256 centimetri di neve in 18 ore nel marzo del 2015. Primato mai riconosciuto ufficialmente. Il monumento più importante del paese è per lo «spazzaneve», anzi per uno snow fighter arrivato in questa montagna nel 1950, dono dei capracottesi che erano emigrati a New York. Ben conoscevano i sei mesi di isolamento negli inverni appenninici. Qui, nel 1914, fu fondato uno dei più vecchi sciclub italiani. È ancora ben vivo.
L’altro monumento, appena fuori dal paese, è dedicato a chi è emigrato. Nei primi anni ’50, qui vivevano poco meno di quattromila persone. A migliaia se ne sono andati. Capracotta ha una sua celebrità: ha un ruolo in film storici con Alberto Sordi e Vittorio De Sica, Ernst Hemingway fece apparire il paese in Addio alle armi, e poche settimane fa il poeta Franco Arminio invitava il governo a riunirsi in questo Alto Molise.
Raccolgo voci del paese: l'ortolano, come ogni anno, minaccia di chiudere il suo negozio, ma, come sempre, non lo farà, chiude anche il più fornito tra i negozi di alimentari. Ci sono due forni a Capracotta, ma il pane arriva dai paesi vicini. Ci sono tutte le classi (pluriclassi) fino alla terza media, ventitré bambini e ragazzini in tutto: tre alla scuola dell’infanzia, tre in prima elementare. Quest’anno, in sette finiranno le medie e gli alunni diminuiranno di colpo. C’è la farmacia, un medico, un bancomat nell’ufficio postale, quattro corse di bus al giorno (nei mesi delle scuole) verso Isernia, il capoluogo di provincia. C’è un parroco. Il pronto soccorso più vicino è a 25 minuti di distanza. Ma se hai qualcosa di grave, meglio andare direttamente a Isernia, poco meno di un’ora di viaggio. Non va poi così male: la metà degli italiani dichiara di avere difficoltà a raggiungere un pronto soccorso. Tre milioni e 400 mila persone (soprattutto in Val d’Aosta, Basilicata, Calabria e Sardegna) vivono a più di mezz’ora da un pronto soccorso. Fra il 2018 e il 2023, dicono alla presentazione del rapporto Montagne del 2025, ha chiuso, nelle aree «periferiche», il 28% delle filiali bancarie.
Lo scorso marzo il «Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud», un ex-ministero che ora è un dipartimento della Presidenza del Consiglio, ha pubblicato il Piano Strategico per le Aree Interne. A pagina 45, obiettivo 4, viene annunciata la condanna all’eutanasia di un «numero non trascurabile» di territori «marginali»: si afferma che è possibile solo «accompagnarli in un percorso di spopolamento irreversibile».
Si arrabbia Candido Paglione, sindaco di Capracotta: «Non esistono comunità da accompagnare a un funerale. C’è un futuro possibile. Il declino non è una condizione eterna, non è una dannazione». Ad agosto hanno alzato la voce anche i vescovi italiani che operano in queste geografie quasi dimenticate: riuniti a Benevento, in 139 scrivono al governo e al Parlamento. Le prime righe della loro lettera sono una fotografia sconsolata: parlano delle disuguaglianze, di «nuove solitudini e dolorosi abbandoni» di questi territori. Ma è solo un momento, c’è una reazione, un impegno, «s’impone una diversa narrazione della realtà».
Le Aree Interne (dovremmo trovare un altro nome, questo è troppo sbrigativo) sono quasi il 60% dell’Italia, 13 milioni di abitanti (poco meno di un quarto della popolazione). Il 92% (!!) dei prodotti alimentari di eccellenza italiani (le Dop, gli Igp, i presidi SlowFood) proviene da queste terre. Come il 70% dei migliori vini italiani. Il sindaco di Capracotta ha un moto di orgoglio: «Io non sono solo il sindaco di settecento abitanti, sono anche il primo cittadino di due milioni di alberi». Come a dire: le pianure, i luoghi urbani, densamente abitati, hanno bisogno della montagna, delle colline, dei boschi. «Solo se si ha cura della montagna, nelle città di pianura si può dormire con tranquillità». «Non ci rassegniamo», dice (e immagino il suo sguardo) Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento. I vescovi conoscono bene queste terre interne: le parrocchie sono una delle poche realtà diffuse capillarmente su tutto il territorio nazionale. E hanno ragione a non rassegnarsi.
Lo scorso maggio, l’Uncem, l’Unione Nazionale dei Comuni Montani pubblica il suo ponderoso, quasi ottocento pagine, rapporto sulla Montagna italiana, una fotografia dettagliata dei territori di 3471 comuni. Una evidente «periferia» instabile, con la necessità di cure continue: 2934 comuni convivono con il rischio di frane e, nella maggioranza di questi piccoli centri, il pericolo è considerato «elevato». Eppure, tra il 2019 e il 2023, per la prima volta, la popolazione delle montagne è cresciuta. Centomila abitanti in più. Pochi, ma il segnale di una sorta di inversione di tendenza. Non solo: il 75% di questi nuovi abitanti sono italiani, «e sono giovani», dice Marco Bussone, piemontese, presidente dell’Uncem. Molti hanno meno di 40 anni, sono coppie, hanno bambini. Vero è che l’Italia è divisa in due: la popolazione montana cresce a nord di Umbria e Marche e lungo l’arco alpino, continua a diminuire al sud, anche se in percentuale molto più ridotta rispetto al passato. «Dobbiamo smetterla di parlare di marginalità, di spopolamento, dobbiamo darci da fare per sconfiggere la paura di sentirci male e non avere un medico – alza la voce il sindaco Paglione –. Voglio vedere accese le luci nelle case del paese».
Ho un «conflitto di interessi» in questo articolo. Mia figlia, nata a Firenze, vissuta per il mondo, è una dei nuovi abitanti di Capracotta. Questa estate ha messo al mondo uno dei due neonati del paese. Ve n’è un terzo, ma la famiglia vive a L’Aquila. Ho camminato a lungo per le sue strade e salito i gradini delle sue molte scalinate. E non ho visto, tranne che nel mese di agosto, molte luci accese nelle case. Con i mezzi pubblici è fatica e tempo per raggiungere questa montagna. A volte mi è parso impossibile. Il capoluogo del Molise, Campobasso, in questi mesi, è il solo capoluogo di regione senza un treno che lo raggiunga. Per andare fino a L’Aquila, 190 chilometri, con bus e treni, ci vogliono quasi sei ore.
Capracotta non è solo su questa frontiera tra solitudine e nuove vitalità, tra il rischio reale dell’abbandono e il desiderio di un «neopopolamento». Leggo che a Cabella Ligure, comune della bellissima e isolata Val Borbera, regione dell’estremo sud-est piemontese, non c’è alcun medico di base. Leggo un’intervista al vicesindaco, Vittorio Demicheli, ex-dirigente sanitario: «Se hai bisogno di una prescrizione e non sai usare le mail, devi fare almeno trenta chilometri prima di trovare chi possa scrivertela».
Nell’alto Veneto, montagne bellunesi, don Fabiano Del Favero, 42 anni, ha lasciato questa estate le sue cinque parrocchie, 64 frazioni, dieci chiese e mille e settecento abitanti, dispersi tra i mille e i mille e quattrocento metri di altezza. Don Fabiano, conosciuto come «il parroco della montagna», non è andato poi molto lontano: da luglio è già al lavoro nelle sette comunità parrocchiali attorno a Longarone. Un sacerdote per più parrocchie. Capace di dire alla domenica tre messe in tre paesi diversi e più o meno lontani. L’entusiasmo di un giovane prete sconfigge la fatica e la solitudine invernale di queste terre.
Leggo sul «Corriere della Sera» la storia della scuola di Parrano, cinquecento abitanti in provincia di Terni. Qui comune e scuola sono riusciti a realizzare una preziosa esperienza di scuola diffusa, ma Cinzia Meatta, preside dell’istituto omnicompresivo del territorio, avverte: «Se non ci concedono un insegnante part-time dovremo chiudere la scuola dell’infanzia». Non deve essere arrivato se, su Internet, leggo, nello stesso giorno in cui l’articolo è stato pubblicato, che la scuola quest’anno non ha riaperto. I bambini dovranno andare altrove «e così fra tre anni dovremo chiudere anche le elementari». Credo che il sindaco Valentino Filippetti sia preoccupato, la sua amministrazione aveva ottenuto piccoli, grandi successi: grazie a decisioni coraggiose (banda larga, trasporto gratuito verso la stazione, sgravi fiscali sugli affitti) a Parrano sono venuti a vivere 45 abitanti in più. Rimarranno se non ci sono più le scuole?
Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!