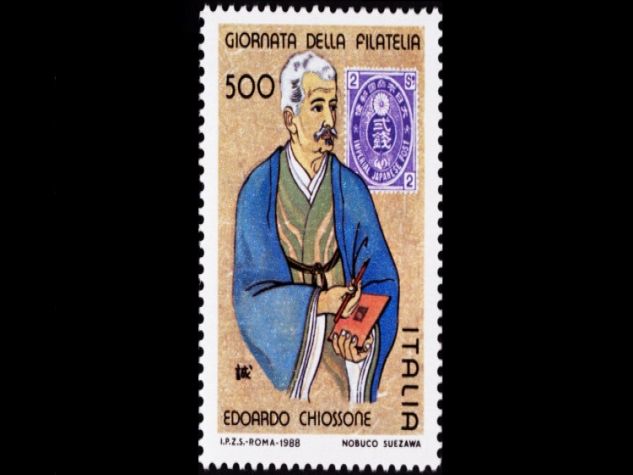Le ragioni del riscatto
È possibile, molto difficile o impossibile raggiungere i vertici della politica, dell’economia, dell’impresa, così come della ricerca scientifica, dell’istruzione, dello sport in un Paese di cui non si è nativi, ma nel quale si è immigrati o figli di immigrati? La domanda non è peregrina poiché dalla risposta si può evincere quanto una nazione sia permeabile al cambiamento, all’inclusione, alla valorizzazione delle risorse umane che compongono il suo mosaico sociale. Paesi che hanno al loro attivo un’esperienza migratoria assai consolidata come Stati Uniti, Canada, Australia, Brasile, Argentina e, per altri versi, anche Germania, Francia e Gran Bretagna, sono più predisposti al cosiddetto «ascensore sociale». Barack Obama è diventato il primo presidente afroamericano degli Stati Uniti. L’attuale vicepresidente, Kamala Harris, è di origini giamaicane e indiane. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, è musulmano, figlio di immigrati pakistani. L’ex presidente della Repubblica Francese, Nicolas Sarkozy, è figlio di un profugo fuggito dall’Ungheria in seguito all’occupazione dell’Armata Rossa; e poi gli italoamericani Rudolph Giuliani, già procuratore federale, assistente del Ministro della Giustizia e sindaco di New York, senza dimenticare un altro storico sindaco, Fiorello La Guardia; o Nancy Pelosi, speaker (presidente) della Camera dei rappresentanti al Congresso di Washington; anch’essi discendenti di immigrati. Sono segni dei tempi oppure solo delle eccezioni?
È un fatto che cittadini stranieri, indipendentemente dalla loro origine anagrafica, o dall’appartenenza etnica o religiosa, siano arrivati ai vertici, non solo della politica, nei rispettivi Paesi di nascita o di radicamento. E in questa particolare classifica internazionale, spulciando i Who’s Who di Stati Uniti, Canada, Australia e America Latina, spicca la folta e qualificata rappresentanza italiana come se, per ragioni storiche, culturali, o semplicemente per talento e competenze, gli italiani d’origine e i loro discendenti siano stati quelli che più di chiunque altro hanno saputo imporsi e scalare le vette dei Paesi d’adozione: ricordiamo Amadeo Giannini, fondatore della Bank of America; Lee Iacocca, presidente e amministratore delegato della Chrysler; Sergio Marchionne, figlio di emigrati in Canada, già amministratore delegato di FCA Automobili; Federico Faggin padre del microprocessore dei nostri computer; la dinastia degli italoaustraliani Grollo, costruttori di imponenti grattacieli in Asia e in Oceania; o quella dei Pallaro in Argentina. Se poi ci spostiamo sul versante della musica e del cinema, è quasi interminabile l’elenco degli artisti di origine italiana giunti all’apice dell’industria dello spettacolo, compresi cantanti, attori e registi – davvero tantissimi – spesso celati da nomi d’arte anglosassoni. Il tema dell’«ascensore sociale» continua a riproporsi anche oggi sia tra le giovani generazioni di italiani che all’estero cercano fortuna, opportunità di carriera oppure che inseguono i loro sogni, sia tra coloro che approdano nella «terra promessa italiana», carichi di aspettative e di ambizioni di riscatto per sé e per i propri figli. Una rivoluzione sociale che non sempre ci trova preparati e ben disposti.
Linee di faglia
«Di piccola statura e di pelle scura. Non amano l’acqua, molti di loro puzzano perché tengono lo stesso vestito per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno e alluminio nelle periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli altri. Quando riescono ad avvicinarsi al centro, affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti». Sapete chi sono? Gli immigrati italiani oggetto di una relazione dell’Ispettorato per l’Immigrazione del Congresso degli Stati Uniti d’America, datata ottobre 1921, come ci informa l’avvocato Claudio Falleti, vicepresidente generale dell’Organización Mundial de Abogados (OMA), e autore del libro L’esodo - L’emigrazione italiana nelle Americhe dal 1861 (Infinito edizioni). Ai migranti in America Latina, per esempio in Argentina, andò meglio. «Qui gli italiani non dovettero affrontare gravi problemi di carattere etnico o razziale – prosegue Falleti –, anche se l’inserimento non fu sempre facile. Quelle sudamericane erano società in formazione, all’interno delle quali i nuovi venuti non si scontravano con strutture consolidate. E non si sentivano nemmeno portatori di una civiltà superiore se non, talvolta, nei confronti degli indios».
Maria Cristina Bombelli è fondatrice e presidente di «Wise Growth», ed esperta di Diversity management. Lavora a fianco di aziende, associazioni e istituzioni per costruire strategie di inclusione della pluralità. È stata professore presso l’Università di Milano Bicocca e docente della Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi. Ha fondato, presso la SDA Bocconi, il Laboratorio Armonia, un centro di ricerca sul Diversity management sostenuto da un network di imprese. Secondo Bombelli, «ogni aggregazione umana definisce ciò che è giusto e che è sbagliato, ciò che ogni singolo deve fare ed essere per diventare parte della comunità. Si creano quelle che, in letteratura, vengono definite “linee di faglia” ovvero i confini che il gruppo mette tra sé e gli altri gruppi. La non accettazione deriva da quanto siano solidi questi confini, a volte completamente impermeabili». Non è difficile ricondurre questa distinzione «manichea» operata da un’aggregazione umana o da una comunità, a un pregiudizio antropologico che solo il successo o la ricchezza di un immigrato riescono a mitigare. «In realtà fa paura la diversità intrecciata con la povertà, con una presunta inferiorità sociale ed economica, con una altrettanto presunta arretratezza culturale», osserva il professor Maurizio Ambrosini, docente di Sociologia delle migrazioni all’Università di Milano che ha pubblicato il saggio dal titolo Altri cittadini per i tipi di Vita e Pensiero.
Quali sono allora, i fattori discriminanti che favoriscono l’accettazione o il rifiuto del migrante nella società d’adozione, e con esso le sue legittime ambizioni di carriera? «Noi non chiamiamo extracomunitari gli svizzeri o i giapponesi – aggiunge Ambrosini –. Immigrati ed extracomunitari sono, ai nostri occhi, soltanto gli stranieri provenienti da Paesi che classifichiamo come poveri, mai quelli originari di Paesi sviluppati. In quanto poveri, gli stranieri appaiono “minacciosi” perché potrebbero volerci portare via qualcosa, oppure sono bisognosi di assistenza, e quindi suscettibili di rappresentare un carico per la nazione. È singolare poi la condizione dei cittadini di Paesi di emigrazione, i quali, individualmente, sono riscattati dall’essere un’eccellenza nello sport, nella musica, nell’arte o negli affari. Il loro successo li ha affrancati da quella condizione di povertà che si associa intrinsecamente alla nozione di immigrato. Il calciatore africano o l’uomo d’affari medio-orientale non allarmano le società riceventi, e anche le loro eventuali diversità, religiose o alimentari, sono ampiamente tollerate». Se ne deduce che il concetto di immigrato allude alla percezione di una «doppia alterità»: una nazionalità straniera e una condizione di povertà. «E quando un individuo o un gruppo riescono a liberarsi di uno di questi due stigmi, cessano di essere considerati come immigrati». Insomma la riconoscibilità del prossimo come un soggetto simile a noi, fa cadere barriere ideologiche e pregiudizi.
Integrazione e mondo del lavoro
«Ciascuno ricerca nell’altro una conferma al proprio modo di pensare e alla propria identità – sottolinea Bombelli –. Il passaggio all’accoglienza è un ripensamento profondo del proprio modo di essere, e necessita di uno sforzo guidato dalla formazione. Dal punto di vista organizzativo, le aziende più consapevoli cercano di comprendere la propria cultura prevalente, le modalità di comportamento presenti, per agire in modo da creare una cultura inclusiva. Gli esempi positivi sono molti da quando ho iniziato ad occuparmi di “Diversity & Inclusion” nel 2000, quando il tema era considerato irrisorio». La genesi di questa forma mentis va ricercata a diversi livelli: nella scuola, nei luoghi di aggregazione, all’interno degli organismi sindacali, nel mondo della politica. Sul punto è d’accordo anche il professor Ambrosini: «L’inclusione degli immigrati procede quando diverse istituzioni e attori convergono nel promuoverla». Certamente il mercato e lo sviluppo economico contano molto, «ma serve anche un sistema educativo capace di accoglienza e di promozione del rispetto della diversità, servono normative severe e istituzioni vigilanti contro le discriminazioni. Serve un tessuto associativo e religioso vivace e aperto. Io vedo le religioni come una risorsa per promuovere solidarietà e costruire relazioni più fraterne tra le persone, le famiglie e i popoli». D’altro canto, occorre che anche gli immigrati facciano la loro parte «respingendo la tentazione della chiusura, e coltivando nuove identità culturali, aperte allo scambio con la società ricevente».
Purtroppo le resistenze e i pregiudizi ci sono e ci saranno sempre. Chi decide di emigrare in un altro Paese lo fa per andare alla ricerca di ciò che non riesce a trovare in casa propria. «Le difficoltà economiche e il sogno di una vita migliore sono sempre alla base delle partenze – rileva Falleti – sia del richiedente asilo che scappa dalla fame e dalla guerra, sia della donna sudamericana che arriva in Italia per fare la badante, sia del neolaureato italiano che decide di investire la propria conoscenza all’estero». In Italia, rispetto ad altri Paesi, è ancora molto difficile per gli immigrati imprenditori ottenere un importante riscatto sociale così come occupare ruoli di primo piano nella società. «Basta dare uno sguardo al nostro Parlamento – prosegue Falleti – per capire che gli italiani di seconda generazione si possono contare sulle dita di una mano. Finché non abbatteremo luoghi comuni come quello che si può condensare nella frase “vengono a casa nostra per rubarci il lavoro” quando, in realtà, chi pronuncia questa frase, il lavoro, spesso, non lo sta nemmeno cercando, non potremo mai considerare il nostro Paese favorevole alla crescita del prossimo anche se con passaporto diverso».
Allora in che modo uno straniero può «fare carriera»? Innanzitutto occorre partire da una comprensione attiva del problema. Bombelli spiega il suo metodo: «In molte aziende abbiamo organizzato un incontro con i dirigenti per creare la sensibilità al tema. Di seguito si è svolta un’indagine, in primo luogo quantitativa, per comprendere quali persone fossero minoranza all’interno del contesto, di solito donne, stranieri, persone senior o giovani a seconda della cultura aziendale, e disabili. Proprio da questa fotografia è stato possibile desumere le “linee di faglia” della cultura aziendale. Poi si sono svolti dei focus group con i collaboratori per riflettere sulle dinamiche che hanno consolidato lo status quo rilevato a livello quantitativo». La condivisione di queste indagini ha favorito attività interne di comunicazione e di formazione orientate proprio a diminuire le dinamiche di esclusione. «La controprova del successo di queste iniziative è quando un “diverso” raggiunge una posizione gerarchica importante perché significa che non ci sono più ostacoli alla rilevazione della competenza necessaria per interpretare un certo ruolo».
Tuttavia non spetta solo al mondo dell’impresa favorire l’«ascensore sociale» per gli stranieri migranti. Le disuguaglianze si combattono anche sul versante del sistema educativo, per esempio «offrendo una buona istruzione a tutti, e poi premiando i migliori – suggerisce Ambrosini –. Nel mondo del lavoro e delle professioni dovrà progredire un approccio più meritocratico, in cui siano le qualità delle persone a determinare il loro successo. Questo vale non solo per gli immigrati, ma anche per i giovani italiani, oggi penalizzati da sistemi familistici di trasmissione delle professioni di maggiore prestigio».
Meritocrazia ed emancipazione
In che modo l’emancipazione dei migranti può incidere sul percorso di accettazione dello straniero in una comunità diversa da quella di nascita o di origine? «Se da una parte l’integrazione aumenta la competizione – osserva Ambrosini –, dall’altra gli immigrati che accedono a una maggiore stabilità economica sono anche più accettati socialmente, e sono percepiti sempre meno come immigrati. Il rimedio ai conflitti per le carriere è la meritocrazia. Il rimedio alla concorrenza per le risorse del welfare è l’aumento degli investimenti, e una maggiore calibratura della loro distribuzione, per assicurare a tutti i residenti una rete di protezione sociale adeguata». La soluzione rievoca un problema che non è ignoto alle società occidentali. Se sostituiamo, infatti, la parola «immigrati» o «diversi» con la parola «donna», vediamo replicarsi le stesse dinamiche di esclusione dai ruoli di responsabilità che hanno investito, per molto tempo – e continuano tutt’oggi a interessare – anche le donne nella società civile, nella politica, nel mondo dell’impresa, in un processo di emancipazione che non è ancora concluso.
«Le dinamiche di esclusione sono sempre le stesse – rammenta Bombelli –: un gruppo decide implicitamente o esplicitamente i criteri di appartenenza. Quando questi criteri sono “radicali” si verifica l’in-group ovvero un fenomeno di intolleranza verso i non appartenenti. È quello che si sta verificando, ad esempio, negli Stati Uniti con alcuni gruppi estremisti che, alimentando l’adesione con notizie false, fa sì che l’incontro possibile diventi uno scontro totale. Nella dimensione più quotidiana avviene lo stesso: se in un’azienda le prassi di comportamento hanno qualificato come status symbol il lavorare 12 ore al giorno, coloro che non seguono questa modalità saranno additati come scansafatiche, e non avranno possibilità di carriera». Questo, in alcune aziende italiane, porta, per esempio, all’esclusione delle donne dalle carriere. «In azienda l’antidoto è la competenza. Le organizzazioni che sanno definire quali sono le capacità richieste ai singoli per proseguire un percorso di sviluppo, possono facilmente distinguere chi è più adatto, e chi non lo è». In questo modo arrivano ai vertici le donne, gli stranieri o qualsiasi altra categoria di persone. E una società inclusiva può garantire uno sviluppo umano ed economico più ampio per tutti.
Un ruolo decisivo può essere svolto anche dall’impiego pubblico. «Negli Stati Uniti – commenta Ambrosini – le battaglie per le pari opportunità hanno coinvolto le minoranze etniche prima ancora delle donne. Insieme al sistema educativo, è stato l’impiego pubblico a svolgere un grande ruolo di promozione delle donne. Oggi, purtroppo, le seconde generazioni immigrate si stanno affacciando a un mondo del lavoro in cui l’impiego pubblico si è ridimensionato, riducendo così la sua capacità di offrire buone occupazioni alle persone capaci e meritevoli». L’inclusione dei migranti nei ruoli cardine della società, nelle imprese, nella politica, che cosa ha insegnato e quali effetti ha prodotto in Paesi dove il multiculturalismo è da tempo una realtà consolidata, come, per esempio, in Canada, in Australia, ma anche, nonostante parecchi distinguo, negli Stati Uniti?
Bombelli è convinta che «la convivenza diviene propositiva quando ciascuno è disposto a mettere in discussione il massimalismo di alcuni gruppi. Il tema chiave è la legittimazione per i credenti, di altre religioni; per i politici, di altre espressioni; per chi compie scelte radicali, di altre modalità di vita. Le “linee di faglia” sono a volte banali: scelte alimentari, di comportamento, di cura». Date queste premesse, l’integrazione può funzionare laddove si sviluppa una cultura dell’accettazione delle opinioni altrui. E chi ce la fa a salire nella scala sociale del Paese d’adozione, diventa un modello per gli altri. Falleti ripensa alla sua esperienza personale: «La mia famiglia è emigrata in diverse parti del mondo: Argentina, Australia, Francia, Canada. In cento anni non abbiamo mai perso i contatti tra noi, inizialmente comunicando in calabrese perché gli anziani non parlavano l’italiano. I loro figli avevano imparato un po’ di calabrese. Con i nipoti parliamo inglese, spagnolo o francese, a seconda di dove vivono. Non abbiamo mai vissuto con invidia il raggiungimento di un traguardo di un nostro familiare, anzi abbiamo gioito con lui e per lui».
Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!