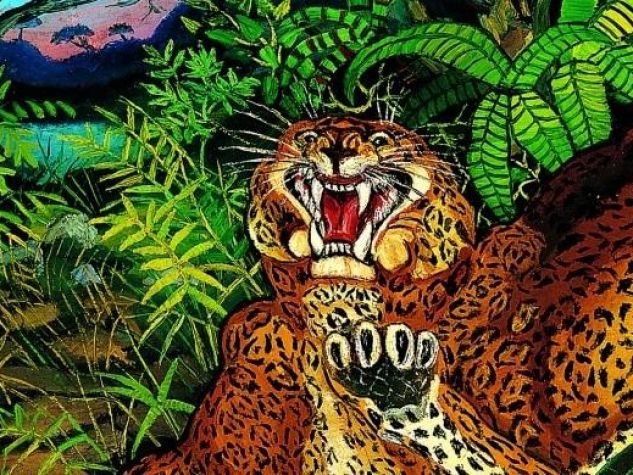Quarant’anni senza manicomi
«A Gorizia c’è un ospedale di 500 letti, diretto in maniera del tutto tradizionale, dove sono usuali elettroshock e insulina. Un ospedale dominato in primo luogo dalla miseria, la stessa che incontriamo in tutti i manicomi. Nel momento in cui vi entrammo dicemmo no. Un no alla psichiatria, ma soprattutto un no alla miseria». Parte da una città di frontiera, negli anni ’60 del secolo scorso, il lavoro di Franco Basaglia, psichiatra, e dei suoi collaboratori. Una rivoluzione che porterà alla chiusura dei manicomi e a un’idea di psichiatria che affronti la malattia là dove nasce, si produce, si scatena. Qualche anno dopo, nel 1971, Basaglia approda a Trieste. Quel manicomio con oltre 1.200 posti letto diventerà uno dei più grandi laboratori, a livello internazionale, di come «l’impossibile possa diventare possibile». Un luogo in cui il malato viene prima della malattia, l’uomo prima dell’internato.
Queste le sfide della legge 180 sugli «accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori», che decretò la chiusura dei manicomi. In verità, approvata il 13 maggio 1978, restò in vigore solo sei mesi. Con qualche modifica, fu inserita nella legge n. 833 sul Servizio sanitario nazionale del 23 dicembre. Grandi aspettative e altrettante polemiche seguirono la scelta di definire, in maniera nuova, il quadro giuridico del trattamento psichiatrico e le funzioni dei servizi di salute mentale. Aspettative e polemiche che, per certi aspetti, non sono mai venute meno. Continua anche oggi il dibattito tra chi è chiamato a fare i conti con la presa in carico, la cura e l’organizzazione dei servizi: dagli psichiatri agli operatori socio-sanitari, dalle istituzioni alle forze dell’ordine fino alle famiglie su cui pesa gran parte del carico assistenziale.
Quarant’anni di legge Basaglia offrono l’occasione, al di là delle celebrazioni e delle contestazioni, di fare il punto sullo stato della salute mentale in Italia. «La riforma ci portò, primo e ancora unico Paese al mondo, a chiudere definitivamente gli ospedali psichiatrici, dando corpo a una vera “psichiatria di comunità”, basata sul principio che le persone affette da disturbi mentali devono essere assistite laddove esse vivono – spiega Bernardo Carpiniello, presidente SIP (Società Italiana di Psichiatria), professore ordinario di Psichiatria all’Università di Cagliari –. L’impatto fu notevolissimo sulle famiglie, presso le quali oggi vive oltre l’80 per cento delle persone affette da disturbi mentali gravi e persistenti, con un inevitabile maggior carico emotivo e pratico per quanti assistono i loro congiunti ammalati. Le famiglie sono a tutti gli effetti dei caregiver (assistenti, ndr)fondamentali. Pur essendosi sviluppate ovunque forme di coinvolgimento e supporto (interventi psicoeducativi, gruppi di auto-aiuto, reti di “Utenti e familiari esperti” a supporto dell’attività dei servizi), l’impatto è forte e l’assistenza alle famiglie è un’area critica per i servizi italiani. Prima o poi non riusciremo più a fare miracoli. Perché c’è sempre meno disponibilità di personale in un settore in cui la cura è basata sulla relazione terapeutica e il capitale umano è dunque essenziale; perché il carico di lavoro pro capite sta aumentando creando sul personale livelli di stress non tollerabile, a cui si aggiunge quello correlato al fatto che si arriva non raramente a rischiare la vita per l’assenza di sicurezza; infine, perché le cure più innovative, che richiedono un congruo numero di operatori con specifiche competenze, che non abbiamo, restano appannaggio solo di una quota ristretta di pazienti. E se le nuove cure non possono essere utilizzate, come invece avviene ormai da anni in ambito oncologico, pare limitativo vantarsi di aver compiuto un grande e sacrosanto atto di civiltà per aver abolito i manicomi. Questo è stato un indiscutibile merito, ma dovrebbe essere un atto di civiltà altrettanto grande garantire le cure migliori, in strutture adeguate e con personale in numero sufficiente».
Gisella Trincas è presidente nazionale Unasam (Unione associazioni per la salute mentale). La sua battaglia a favore della 180 inizia molto presto. Gisella è la seconda di dieci figli. Nel 1974 la primogenita, Maria Antonietta, viene ricoverata nell’ospedale psichiatrico Villa Clara di Cagliari. «I primi anni eravamo concentrati nel chiudere al più presto quei luoghi che non erano luoghi della cura. All’epoca, oltre al manicomio, non c’era nulla. Non c’erano le leggi attuative della 180, c’era la legge e basta. Il nostro impegno era basato sulla nostra personale esperienza, su quel po’ di decente che avevamo visto in giro: l’esempio di Trieste tra tutti. Pensavamo, noi come famiglie, a nuovi luoghi che potessero sostituire le famiglie stesse».
Non tutti sono, allora come oggi, a favore della legge Basaglia. Tra loro l’associazione «Vittime della legge 180», secondo la quale «in Italia la 180 ha eliminato ogni seria cura della malattia mentale e la sua applicazione ha avuto come effetti inefficienza, crudeltà e abbandoni». Per Trincas, invece «è prima del 1978 che si assisteva al totale abbandono e alla distruzione delle vite di migliaia di persone. I pazienti erano privati, in maniera brutale, dei loro diritti umani fondamentali. Perché un malato, prima di tutto, è una persona».
Oggi in Italia ci sono i Dipartimenti di salute mentale, servizi ospedalieri e territoriali, centri diurni... Una fitta rete operativa su cui permangono questioni tuttora aperte: qualità degli interventi, distribuzione dei servizi sul territorio, pratiche di intervento nel rispetto dei diritti fondamentali della persona. Perché, ricorda Trincas, «Coercizione non vuol dire solo cinghie, ma anche, per esempio, terapie farmacologiche prescritte senza verificarne gli effetti, spesso più dannosi della malattia stessa. I servizi sociali dei Comuni sono pochi, complessivamente fragili, con personale insufficiente. Mancano psicologi, educatori, terapisti della riabilitazione psichiatrica».
L’«istantanea» sui servizi psichiatrici italiani è, oggi, a macchia di leopardo. Non esistono grandi differenze tra Nord e Sud. Eccellenze si possono trovare a Milano come a Catania (qui è stata realizzata una sperimentazione sul «dialogo aperto» avviata per la prima volta in Finlandia). All’avanguardia in fatto di servizi e aiuto alle famiglie, il Friuli-Venezia Giulia. Maglia nera, la Calabria. «Basaglia ha fatto capire – afferma Maria Grazia Giannichedda, tra i più stretti collaboratori dello psichiatra e presidente della Fondazione Franca e Franco Basaglia con sede nell’isola di San Servolo (Venezia) dove si trovava l’antico manicomio – come sia stato possibile, in luoghi concreti dell’Italia e in un tempo pieno di problemi e tragedie, immaginare e costruire iniziative, progetti, istituzioni in cui si è data l’opportunità di “vivere le contraddizioni”, trasformarle in ricchezza e “tenere presente la soggettività di tutti”, o almeno provare a farlo».
Le sfide di quarant’anni fa pongono oggi ulteriori interrogativi e una convinzione. Come affermò lo stesso psichiatra veneziano: «Magari i manicomi torneranno a essere (luoghi, ndr) chiusi e più chiusi di prima, io non lo so. Ma a ogni modo noi abbiamo dimostrato che si può assistere la persona folle in un altro modo, e la testimonianza è fondamentale. Non credo che il fatto che un’azione riesca a generalizzarsi voglia dire che si è vinto. Il punto importante è un altro: è che ora si sa cosa si può fare».
Nel numero di settembre 2018 del Messaggero di sant’Antonio e nella corrispondente versione digitale, l’approfondimento è completato da un’intervista allo psichiatra Eugenio Borgna.