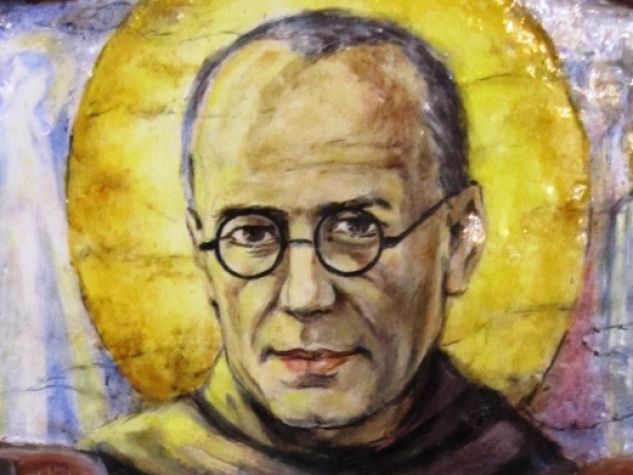Racconto la mia Sicilia guardandola in faccia
I boss mafiosi lo vogliono morto. Lo hanno fatto scrivere sui muri del ragusano. Glielo hanno giurato dai social network e perfino dalle gabbie delle aule di tribunale dove sono stati trascinati dalle sue inchieste giornalistiche. «Ti scippo la testa anche dentro il commissariato di polizia», è arrivato a minacciare, schiumando rabbia, il pluri-pregiudicato Giambattista Ventura, fratello di Filippo considerato il capo della mafia di Vittoria.
Ma lui, nonostante le intimidazioni, gli agguati subiti, il forzato abbandono della sua Sicilia e la vita blindata, con cinque angeli custodi che lo scortano ovunque, ha deciso di resistere e continua a denunciare gli affari sporchi delle mafie, pubblicandone i misfatti con nomi, cognomi e foto.
Il «condannato a morte» è Paolo Borrometi, 34 anni, ragusano, una laurea in giurisprudenza, figlio d’avvocati, giornalista collaboratore dell’Agenzia Agi, fondatore e direttore della testata giornalistica online «La spia», «un nome – spiega – scelto proprio perché una delle prime cose che mi sentivo dire quando cominciai a fare il cronista da chi non amava molto le mie inchieste era “sii unu spiune, sii unu sbirru”». Da tre anni vive a Roma, sotto scorta armata che lo segue a vista anche quando entra in chiesa e si siede tra i banchi a pregare. A dargli una mano, confessa, è «la fede in Dio e la dedizione assoluta per una professione che è indispensabile pratica di libertà».
In questi casi si tira in ballo l’eroismo. E per te? Gli eroi, in genere, fanno una brutta fine. Ho cercato e cerco solo di raccontare la Sicilia senza girarmi dall’altro lato. Ma agire così non è essere solo buoni giornalisti: ancor prima è essere buoni cittadini e buoni credenti. Ho fatto e sto facendo solo il mio dovere. Per essere uomini liberi. Ama dire don Luigi Ciotti: «Non ci può essere giustizia senza verità». Ed è così. Ci sono familiari di vittime della mafia che non hanno ancora avuto verità. E noi giornalisti abbiamo l’obbligo di raccontarla, scrivendo ciò che abbiamo visto. Questa è «la rivoluzione del quotidiano» in cui credo. E questa è la lotta all’indifferenza di cui ci parla il più rivoluzionario uomo del nostro tempo, «un certo» papa Francesco.
Tu sei stato il primo a raccontare i traffici illeciti e i lucrosi affari delle cosche mafiose ragusane. Hai denunciato il business delle agromafie: un filone criminale cresciuto lontano dai riflettori, che vale oltre 16 miliardi di euro l’anno, che ha come base Vittoria, il mercato ortofrutticolo più grande della Sicilia, e arriva coi suoi tentacoli fino alle grandi città del Nord Italia. È così? Sì. Le mie inchieste sono partite da lì. Dalla mia terra. In quella provincia si favoleggiava che non si fosse mai radicata la mafia. Ma è un insulto all’intelligenza il solo pensare che i clan, capaci di andare a fare affari in Usa, si fossero dimenticati della provincia siciliana che in proporzione agli abitanti ha il maggior numero di sportelli bancari.
L’escalation delle minacce nei tuoi confronti è stata rapida e i messaggi inequivocabili. «Stai attento», t’hanno scritto sul fianco dell’auto, come primo avviso. Ma il tiro s’è alzato presto. E siamo all’agguato del 16 aprile 2014. Che cos’è accaduto? Due uomini incappucciati, in piena campagna, mi hanno avvicinato e aggredito alle spalle. Mi hanno spezzato i tendini di un braccio torcendomelo tanto da causarmi un’invalidità permanente. E, dopo avermi percosso e gettato a terra, m’hanno urlato dietro, prima di andarsene: «T’affari i cazzi tui. U’ capisti?».
Che cosa passa, in quei momenti, nella mente di un giovane cronista? Non viene la tentazione di mollare tutto? Già. Più che la spalla e la menomazione fisica, sono stati i lividi morali i più difficili da guarire. E più arduo ancora è stato sollevarsi dalla paura e dall’isolamento in cui si cade in questi casi. Giovanni Falcone osservava che in Sicilia un uomo viene ucciso due volte: prima con l’isolamento, poi fisicamente. Aveva ragione.
E tu? Ho deciso di tirare dritto per la mia strada. Fino alla notte del 2 agosto dello stesso anno, quando, stavolta in centro a Modica, hanno appiccato il fuoco alla porta della mia abitazione. Allora fui tentato davvero di mollare tutto, di smettere di fare il giornalista. Mi sentivo solo e avevo paura. Quel momento fu lo spartiacque della mia vita professionale.
Chi ti venne in aiuto in quel momento? Anzitutto mio padre che mi fece trovare un bigliettino con su scritto: «Mai giù, sempre su». Poche parole, ma sufficienti per darmi la forza di non arrendermi ai miei persecutori. Confesso che quel bigliettino, piegato in due, con quel messaggio tanto laconico quanto forte sta custodito gelosamente nel mio portamonete, pronto ancora, alla bisogna, a ridarmi la forza di continuare.
Spesso, ti sei dichiarato credente. La fede ti ha dato una mano, anche in quel difficile frangente, a risollevarti? Assolutamente sì. E la preghiera in modo particolare. Decisivo è stato mettere tutte le mie debolezze e la mia paura tra le braccia della Madonna. Piangere, in silenzio, davanti a lei, e capire che non ho pianto invano; che, grazie a lei, le mie sono state lacrime asciugate. Da qui ho preso, e prendo, la forza e il senso per continuare a fare il giornalista che combatte la mafia.
L’intervista completa è disponibile nel numero di ottobre 2017 della rivista e nella versione digitale.