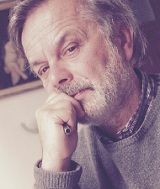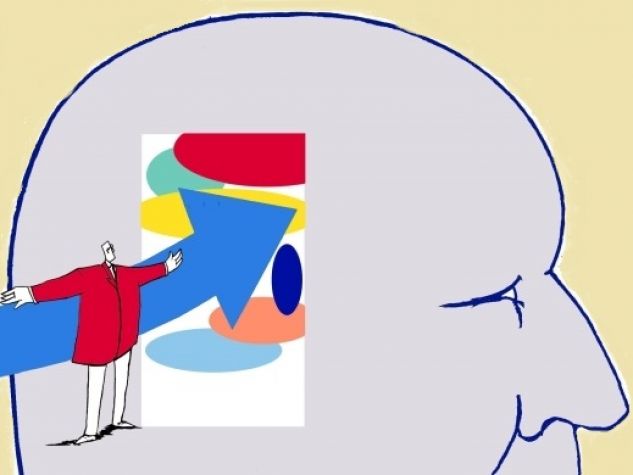C’erano una volta le cartoline…

Alcuni anni fa venni ricoverato in ospedale. Una storia seria. Vi rimasi per più di un mese. Mia figlia e la mia compagna organizzarono una sorpresa: chiesero ai miei amici di inviarmi una cartolina. Ne ricevetti a decine. Una volta le stesi sul letto e lo coprivano tutto. Venivano da Bologna, da Pistoia, da Pisa, da Matera. Dal Nicaragua. Dall’Austria. Credo che un tale affetto mi aiutò in un momento fragile della mia vita.
Le cartoline sono state un impegno dei miei anni. Mi sono dato anche delle regole: tre cartoline da ogni luogo in cui passo almeno un giorno. E credo di averlo rispettato. Costringendomi, negli ultimi tempi, a ricerche a volte complicate: cercare chi ancora vende cartoline, girare l’espositore rotante, trovare il francobollo (quante tabaccherie ne hanno ancora?) e, ultima impresa che diventa ogni giorno sempre più difficile: andare in cerca di una cassetta postale, quelle rosse, classiche, con due indicazioni sopra la fessura, «Per la città»; «Per ogni altra destinazione». Questo non è un post di nostalgie. È diventato urgente perché il 31 dicembre di quest’anno, le PostNord, società pubblica in comproprietà tra Danimarca e Svezia, consegnerà per l’ultima volta una cartolina, una lettera. Dopo 401 anni, il viaggio della posta nel piccolo paese del Nord Europa si interromperà. Oramai le mille e cinquecento cassette postali danesi sono quasi tutte già smantellate.
E in Italia il loro numero si sta riducendo sempre di più. Un piano del 2022 prevedeva che venissero eliminate oltre 17mila cassette postali. Erano 46mila e cinquecento tre anni fa. Adesso sono meno di trentamila. Meno trecento a Roma, meno ottanta nella terraferma di Venezia, meno settanta a Firenze. A Matera, l’impiegata delle poste mi conosce e, quando entro nel suo ufficio, allunga la mano: «Le spedisco io». La cassetta postale del Corso della città è chiusa ermeticamente da tempo. Che io sappia nei Sassi di Matera ve ne è in funzione solo una. Posso sbagliarmi. L’impiegata sa anche che ogni tanto mi presento al suo sportello e allora mi prepara una busta con una decina di francobolli per cartoline. Quando le chiese un francobollo la prima volta, già allora, mi guardò con uno sguardo interrogativo. Ci intendemmo: si alzò, prese delle chiavi, aprì un armadio metallico, trafficò con una serratura e tirò fuori un classificatore con i fogli dei francobolli.
Adesso mi accorgo che i francobolli non hanno più l’indicazione del loro valore. Le pensano tutte: così non sono costretti a nuove stampe se viene deciso un aumento. E viene deciso spesso, a quanto leggo: quattro euro in Danimarca per una lettera, la Francia ha deciso aumenti dell’8% per spedire una lettera. In Germania, mi raccontano, le poste tedesche faranno a meno di ottomila dipendenti entro la fine dell’anno. In Italia la quantità di lettere e cartoline tra il 2008 e il 2023 è calato del 68%. Non sono un collezionista di francobolli, ma ne amavo e ne amo la piccola bellezza. Mi sorprendeva sempre che più i paesi erano poveri, più belli e colorati erano i loro francobolli. Sono sempre stato grato a chi, 185 anni fa, in Inghilterra si inventò un bollo per indicare la tariffa di un servizio postale: si chiamava sir Rowland Hill e il primo francobollo è il celebre Penny Nero.
Le cartoline, a quel che leggo, esistevano prima dei francobolli. Per lo meno a livello internazionale. Nel 1875 un trattato postale firmato per unificare il sistema dei servizi postali, fino ad allora diversi tra stato e stato, ne consentì la circolazione. Poi venne deciso il formato: 10 x 15 centimetri e avrebbe autorizzato i privati a stampare cartoline. Ultimo passo: 1902, la prima cartolina illustrata su un lato e con il retro destinato al messaggio e all’indirizzo del destinatario venne impostata in Inghilterra.
Ai tempi dell’università, a Firenze, ho lavorato come trimestrale delle poste. Consegnavo telegrammi (quando avete scritto l’ultimo telegramma) e raccomandate (oggi ci sono le Pec), ma vedevo passare nell’ufficio accanto al mio, migliaia e migliaia di cartoline. Leggo un’intervista a Silvano Cangiari, riminese, uno dei fondatori di Litoincisa87, un’azienda produttrice di souvenir turistici e stampatrice di cartoline: «Agli inizi del 2000, in Italia, si stampavano 400 milioni di cartoline. Oggi è molto se arriviamo a 40 milioni». Mi sembra comunque un buon numero. Smartphone, whatsapp, messaggistica varia hanno relegato in un mondo arcaico le cartoline. Oggi invio un selfie con alle spalle i faraglioni di Capri. Troppo più comodo. Meno emotivo, a mio parere.
A Venezia ho camminato un’intera mattina con il postino del sestiere di Santa Croce, quello attorno alla stazione per intenderci. Dieci chilometri di buon passo. I postini, qui, vanno a piedi. Con un carretto di piccoli pacchi Amazon. Bollette, pensioni, buste verdi delle multe. Nessuna cartolina. Il mio postino, Alessandro, entrò in poste nel 1985, allora vi erano cento e venti postini nella città-isola. Oggi sono 49.
Quando osservo una cartolina, mi capita spesso di pensare ad Alex Langer, il più amato tra i leader dell’ambientalismo italiano. «Leggendario» scrittore di cartoline. Infaticabile anche in quello. Aveva cura di scegliere i francobolli, di trovare per ognuno parole giuste, Alex amava la lentezza, non so come si sarebbe comportato di fronte a whatsapp, ma credo che avrebbe insistito a scrivere cartoline: erano allora e sono ancor di più oggi, prove di affetto reale, tentativo testardo di rallentare, di regalarsi tempo per noi, per gli altri, per gli amici.
A volte credo di avere molti complici in questa passione per le cartoline. Quando incontro qualcuno/a che mi dice: «Anch’io ne scrivo», è come ritrovarsi con un appartenente a un gruppo di persone destinate a intendersi subito. Pensi: «Forse non siamo pochi, checché ne pensino le poste danesi, forse come i libri o i 33 giri le cartoline non moriranno, almeno per gli anni della nostra vita».
Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!