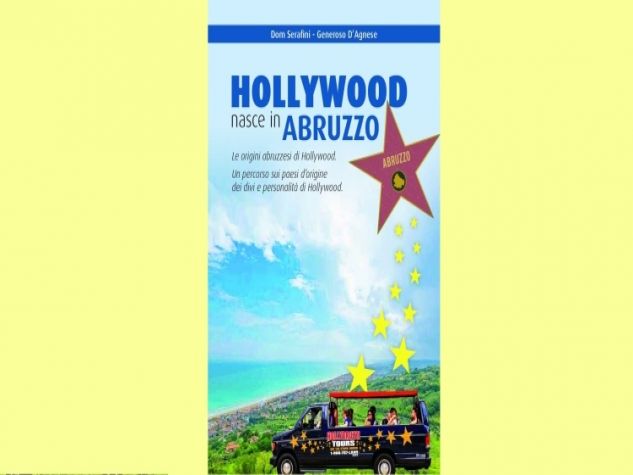Caccia nella savana
Segue un gruppo di turisti austriaci e tedeschi durante un safari africano il documentario Safari (Austria/Danimarca/Germania 2016) di Ulrich Seidl. Classe 1952, il regista austriaco è uno dei più originali e discussi documentaristi europei. Il suo stile è scarno, sobrio, distaccato. Le sue prospettive sono disumanizzate e noi non riusciamo a identificarci empaticamente con gli attori improvvisati. Patiamo un disorientamento: che cos’è questo safari? Un hobby? Un passatempo costoso? Una gita a uno zoo senza gabbie o il prolungamento di una conversazione sul rapporto tra neri e bianchi e sull’economia sudafricana?
Primo aspetto agghiacciante è che gli animali propriamente non si vedono. Certo, vediamo zebre, giraffe, bufali, leoni, gnu, gazzelle. Li vediamo vivi, poi colpiti, feriti, morti, scuoiati, scarnificati, imbalsamati. Ma il cacciatore, guardando le sue prede, non vede animali, distingue solo bersagli. Non vede neppure la propria violenza. Non chiamiamolo «uccidere», suggerisce una giovane esploratrice vestita con eleganza per la caccia grossa, come i suoi colleghi con gilet kaki, tute mimetiche, caschi e foulard. Chiamiamolo invece «abbattere»!
Nella parola uccidere c’è l’idea di un taglio violento della vita. Ma abbattere è solo battere per far cadere. Il maquillage è linguistico ed etico. L’attenzione di chi spara è rivolta al fucile, al bossolo, alla mira, al colpo giusto, al bersaglio vitale (il cuore, gli organi centrali). Non sorge neppure l’idea che anche noi umani siamo animali e che la giraffa, che sta morendo di morte cruenta davanti ai turisti soddisfatti, è un animale non umano, dall’eleganza invidiabile, il collo curioso, la delicatezza della corsa. Se l’animale non è visto, non si sente nemmeno il suo gemito di dolore. L’ambiziosa chiacchiera dei cacciatori, che si complimentano tra loro, sovrasta il respiro affannoso della vittima, così come negli allevamenti intensivi i capannoni insonorizzati nascondono i lamenti delle bestie innocenti.
Morte in diretta
Secondo aspetto grottesco è la dimensione familiare della caccia. «Bravo, l’hai colpito, hai imparato, sei con noi, come noi». Il giovane è abbracciato festosamente, affettuosamente dai più anziani. «Buona caccia!», «Saluto al cacciatore!» sono formule ripetute in tedesco («Waidmannsheil!»). Padre e madre sono commossi. Le coppie sono fiere di questa loro intimità selvaggia che ricorderanno ai figli, appendendo alle pareti i segni della potenza di gruppo. È il sacramento laico di una signoria sulla vita, che almeno per un giorno trasforma donne e uomini in padroni del Giardino, senza bisogno di alcun serpente.
Il cadavere ancora caldo della zebra è messo in posa, il collo girato e fissato verso la macchina fotografica o il cellulare di lusso. E dietro ci sono gli eroi. Intanto i più attempati, obesi, goffi e sudaticci si sdraiano al sole per una birra, spalmati di creme anti UV, comparano la qualità delle carni, confrontano i costi dell’impresa. «Perché dovrei giustificarmi?» si domanda il proprietario della riserva di caccia. Ormai la natura non c’è più; la terra è secca, gli alberi sono pochi, la savana è sterile, le bestie sono affamate e spaventate. Il rosso dei tramonti da cartolina si è eclissato. I bei vecchi tempi della caccia faticosa e rischiosa sono stati consumati dalle jeep possenti, dalle postazioni di fuoco protette, dai GPS d’orientamento. Puoi anche schiacciare senza rischi un pisolino all’ombra tra i leoni.
Lo spettatore è raggelato dalla farsa macabra, dall’avventura surreale, dai finti rituali di una vacanza mortifera, dall’équipe d’indigeni per la pulizia delle carcasse, dai ganci e dalle catene per il traino e la pesa. I villeggianti cecchini si prestano, pare, di buon grado a fungere da attori e comparse. Ci istruiscono con zelo. Ci confidano le loro paure (il battesimo del primo sparo, il timore che l’animale si rialzi, la vergogna di sbagliare), leniscono il nostro senso di colpa, ringraziano tacitamente per le riprese che li immortalano su pellicola. Sono attori come noi e come noi sono spettatori di una decadenza senza sacro né religione. Ulrich Seidl forse esagera con le inquadrature statiche, coi ripetuti ritratti di crudeltà, con la morte in diretta. Gira la sequenza (to shoot a sequence, si dice in inglese) come si spara (stesso verbo, to shoot) un colpo di fucile. Lo si voglia o no, un’intera società è nel mirino.
L’uomo arcaico chiedeva scusa all’animale colpito per sopravvivere e prometteva di servire la natura ferita come ne L’ultimo dei Mohicani (1992). Nel film del 1992 diretto da Michael Mann l’attore Daniel Day-Lewis pregava: «Ci dispiace ucciderti, fratello cervo. Rendiamo onore al tuo coraggio, alla tua rapidità e alla tua forza». In un’altra scena della pellicola un saggio della tribù degli uroni si domandava cosa fosse giusto fare, dal momento che «L’uomo bianco è arrivato e la notte è penetrata nel nostro futuro». Smarrito ogni orrore per la violenza, svanita l’angoscia per il peccato, i personaggi del safari sono irrisi e scorticati dalla cinepresa. Sono gli oggetti di un inseguimento e di una denuncia corrosivi, come animali allucinati che non sanno spiegare ciò che fanno, ma che seguono routine ammaestrate, apparentemente ecologiche, con qualche misera mancia ai poveri del mondo e ai ranger di colore, così sfortunati a esser nati africani.
Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!