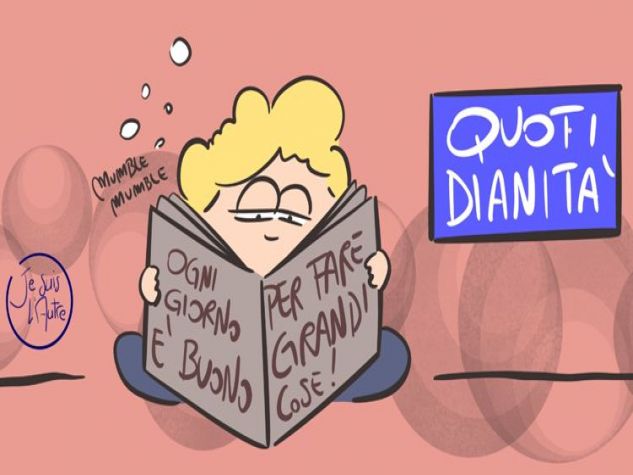Catechesi 2019: grande famiglia di santi
Se pur dovremmo di solito essere cauti nell’uso delle nostre idee per non trasformarle in idee fisse, ce n’è una che accompagna da sempre l’umanità. Un’autentica fissazione, che ha attivato energie e fantasie, strategie e progetti, mal di testa e notti insonni, producendo scoperte che sono andate ad arricchire l’intera umanità o esistenze tristi e grigie perché incompiute. E perciò dolorose per sé e per gli altri.
Sì, perché non realizzare proprio in nessun modo se stessi, le proprie ambizioni, le potenzialità che ci riconosciamo, ciò che noi chiamiamo anche «vocazione», non fa davvero piacere a nessuno.
«Se di tutto resta un poco, perché mai non dovrebbe restare un po’ di me?»: il verso del poeta Carlos Drummond De Andrade suona come un epitaffio per noi, la presentazione pomposa con cui veniamo scaraventati in questo pezzetto di storia. Allo stesso tempo bellezza e responsabilità di un compito innato, e salutare allusione a un limite. Cos’è e da dove viene quel non si sa che, che sentiamo bruciare in noi, che ci impedisce di accontentarci? Che ci costringe a cercare di spostare i confini sempre un po’ più in là? Che non ci riesce di zittire, perché non è tutta farina del nostro sacco? Probabilmente, di nuovo, solo i poeti sono riusciti a esprimerlo. Così Dante, nelle parole con cui Ulisse autogiustifica il proprio nomadismo recidivo: «Considerate la vostra semenza: / fatti non foste a viver come bruti, / ma per seguir virtute e canoscenza». Così, più vicino a noi, Dag Hammarskjöld: «E vengo spinto oltre, / verso una terra sconosciuta. / Il terreno si fa più duro / l’aria più fredda e pungente. / Le corde dell’attesa / vibrano / mosse dal vento della mia meta ignota». Siamo uomini per questo, ognuno per quel pezzetto di umanità che si ritrova addosso…
Poi, le sollecitazioni dell’infosfera in cui siamo sempre più immersi (messaggi veicolati dalla pubblicità, stili di vita di «successo» ma irrealizzabili, culto dell’immagine, sdoganamento dell’egoismo e colpevolizzazione dell’altruismo, deliri di onnipotenza, idealizzazione del self made man), ce la mettono tutta a banalizzare la bellezza di questa chiamata del tutto umana al meglio di sé. Creando solchi di ingiustizia tra chi se lo può permettere e chi, la maggior parte di noi, no. Perfidamente dicendosi «baciati dalla fortuna» o, peggio, benedetti niente di meno che da Dio in persona. Ma tutto ciò non riesce a offuscare la scintilla di infinito in noi, se addirittura non ne diventa paradossalmente anch’esso una prova inequivocabile. Come potremmo ridire cristianamente questo anelito che spinge ognuno di noi a realizzare in compiutezza la nostra umanità, o almeno a non esser niente di meno? E a farlo senza facili fughe o alienazioni nella spiritualità disincarnata e astratta, che per molti versi ci caratterizza come credenti? Arresi a contrabbandare nell’aldilà, alla fine del mondo, postumi risarcimenti, rischiamo di vivere perennemente in sala d’attesa, aspettando tempi e luoghi migliori. Quando «allora sì che potremo… riusciremo…». Non accorgendoci che di là, se sarà, sarà la pienezza di ciò che già di qua ha cominciato a essere.
Ebbene, la parola che il nostro lessico religioso ci suggerisce è impegnativa, risaputa e forse proprio per questo un po’ fuori moda. Come un soprammobile che non ci decidiamo a cestinare, ma di cui ci siamo dimenticati da dove mai arrivi o chi ce l’abbia regalato. Intuiamo che ha un certo qual valore affettivo, che dovrebbe richiamarci alla memoria emozioni e relazioni, e suscitarci pensieri profondi. È una parola che pare centrarci come i cavoli a merenda con la nostra quotidianità: santità.
Viene direttamente dalla parola di Dio: «Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo» (Lv 19,2)! Promessa per noi impossibile di somiglianza divina, nostalgia di casa, cammino di bellezza, noi ne abbiamo piuttosto fatto statue nelle nicchie delle chiese. A cui rivolgerci con devozione, di cui chiedere l’intercessione, da ammirarne la vita e i miracoli. Magari da portare in processione il giorno della loro festa. E basta.
Papa Francesco, con l’esortazione apostolica Gaudete et exsultate, ha letteralmente tirato giù dagli altari la santità. Per rimetterla nelle nostre mani, alloggiarla nuovamente nelle nostre case, farla circolare nelle nostre vite, riaffidarla a ogni uomo e donna, grande o piccolo, perché possa crescere, fiorire e portare frutto ancora. Una santità restituita al progetto di Dio di fare di ognuno di noi delle opere d’arte. Non semplicemente il sigillo per aver superato indenni tutte le prove, la fedina penale morale immacolata, il game over di un’esistenza in cui tutto è andato bene. Ma l’amore che lotta, rischia, cade e si rialza, si esprime nei piccoli come nei grandi gesti e scelte: la santità è la bellezza di dare la vita per gli altri! Forse, addirittura, proprio ciò di cui questi nostri tempi hanno bisogno?
Provocati e incoraggiati dalle parole di papa Francesco, vorremmo per quest’anno, nelle pagine tradizionalmente dedicate alla catechesi, mese dopo mese dialogare di santità con voi lettori. Pagine, ci auguriamo, da usare in parrocchia, per la catechesi con le famiglie, gli adulti o i giovani. Ma anche da leggersi personalmente.
Non si può dire che papa Francesco non sia stato coraggioso a ritirare fuori dagli armadi delle sacrestie la santità. E a rispolverarla a uso e consumo nostri. Di noi che, sotto sotto, qualcosa di bello vorremmo fare della nostra vita. Tanto più se addirittura di… divino!
«Ti preghiamo, dunque, o Signore Gesù, che sei salito da questo mondo al Padre nella forma della nostra umanità, tiraci su dietro a te con la fune del tuo amore. Ti preghiamo di non accusarci di peccato, di aiutarci a imitare la giustizia dei santi, di farci temere il tuo giudizio e di infonderci lo Spirito di verità che ci insegni la verità tutta intera. Accordaci tutto questo, tu che sei benedetto e glorioso per tutti i secoli» (sant’Antonio, Domenica IV dopo Pasqua).