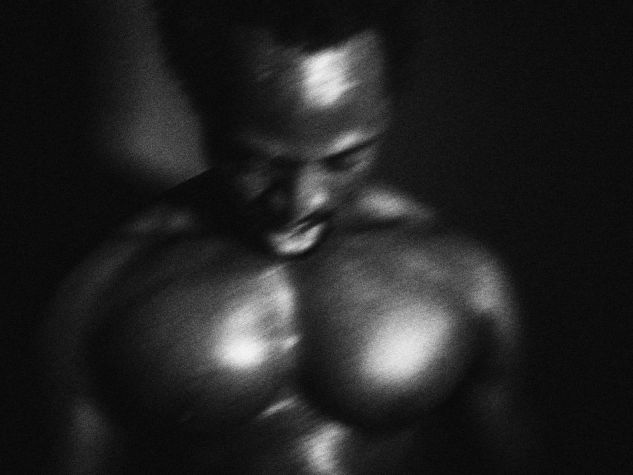Una pizza con Efrem

Erano gli anni Settanta quando conobbi Efrem nell’aula magna dell’Istituto Tecnico Antonio Bernocchi di Legnano. Indossava un eschimo verde quel giorno in cui noi ragazzi eredi del Sessantotto stavamo scioperando per impossessarci dei nostri diritti di studenti con lo sguardo già rivolto al terzo millennio. Efrem non passava inosservato: era parte del movimento studentesco, era uno dei leader. Aveva sempre un microfono tra le mani, che non mollava mai. Quell’amplificatore di messaggi era il suo punto di partenza: lo sapeva maneggiare con disinvoltura. Capitava di vederlo mentre se lo strofinava nella folta capigliatura fatta di riccioli ribelli. Efrem era un combattente buono, un rivoluzionario d’altri tempi. Uno di quelli che si battevano per i diritti degli altri.
Dopo i suoi esami di maturità – Efrem aveva qualche anno più di me – ci perdemmo di vista. Si era iscritto alla facoltà di filosofia, mentre io cercavo di finire il mio percorso intraprendendo un cammino completamente diverso. Continuammo a seguirci a distanza, ma senza più rivederci. Ci ritrovammo molti anni dopo. Non avevamo più i lunghi capelli della nostra gioventù, ma lo spirito era rimasto lo stesso: ribelle. Pioveva a Busto Arsizio in quella serata di fine autunno. Efrem, avvolto in un pastrano di pelle nera, ci (all'appuntamento venne anche mio figlio Hermes) stava aspettando sotto uno dei porticati della piazza. Mi riconobbe ancora prima che parcheggiassi l’auto, donandomi il suo benvenuto con un sorriso a distanza. «Ue Giovanni, ciao. Sei sempre lo stesso».
Evitammo d’istinto la tradizionale stretta di mano, per lasciarci andare in un aggrovigliato e caloroso abbraccio. «Gio… senti. Ascoltami! Ho prenotato per quattro in una pizzeria qui vicino. Dai andiamo, muoviamoci». «Perdonami Efrem – risposi io –, perché hai prenotato per quattro se siamo in tre?» Efrem sorride. «Gio, lo faccio sempre. Voglio avere spazio sulla tovaglia per appoggiare il pacchetto delle Lucky e il telefono». Annuisco, ma senza trattenere una sonora risata. «Sei un mito Efrem. Grande! Dai incamminiamoci». «Ti ricordi i bei tempi dell’ITIS?» rammenta Efrem. «Certo che mi ricordo, ho una grande nostalgia di quell’epoca». «Efrem, ti devo chiedere una cosa dei tempi andati…». «Dimmi Giuan». «I Ray Ban che cosa c’entravano con l’eschimo verde?». «Mmmhhh… servivano per spiazzare. No dai, nascondevano la mia timidezza».
Impiegammo quasi un’ora per attraversare le poche centinaia di metri che ci separavano dal ristorante. Il tavolo riservato era in un angolo nascosto della sala, capimmo subito che avremmo potuto parlare anche ad alta voce, senza disturbare nessuno. «Per me una Napoli, Hermes tu come la vuoi?». «Prosciutto e funghi, grazie!». «Per me con i carciofi» disse Efrem. «Carciofi?» replico io. «Ma Efrem, che roba è?». «Gio, adesso abbiamo altro di cui parlare. Un giorno ti spiegherò». «Abbiamo molto di cui parlare Efrem, dai raccontami. Ma non parlarmi di fotografia, proviamo a parlare d’altro. Che ne so… trova tu l’argomento, sei bravo ad imbastire dal nulla». «Tranquillo Gio, la fotografia non esiste più, o meglio… non è mai esistita» disse Efrem accennando un sorriso sarcastico. «Efrem, che cavolo dici». «Dico quello che penso Gio, lo sai come sono. Le mie parole raramente hanno filtri imposti da interessi o da qualcuno. Dai… ti parlo di Strip: il mio super gatto. Un giorno te lo presenterò, ma prima devi sapere che non lo devi mai guardare negli occhi. Perché si arrabbia, diventa pericoloso e aggredisce. È un gatto molto intelligente, fatti raccontare da Hermes di quella volta che abbiamo fatto l’editing dei suoi ritratti, quando abbiamo steso le stampe sul pavimento di casa mia». «Sì è vero papà, da non credere: zampettava tra i bordi delle fotografie senza mai calpestarle, neppure con le zampe posteriori quando cambiava direzione negli stretti spazi che avevamo creato tra le stampe. Incredibile!». «I gatti non solo mi piacciono, io li amo. Con loro parlo» aggiunse Efrem.
«Sto iniziando a capire un po’ di più le tue fotografie: quelle macchie di movimento senza una meta precisa, quei gattini che escono dal fotogramma lasciando una scia. L’irrequietudine che spesso vai a cercare, e che a volte sottolinei donandola agli occhi distratti di chi osserva le tue foto. La foto di Efrem Zanardi, non quella con l’impennata della carrozzina. L’altra: quella con le «sgommate». In quella foto, che trovo unica e meravigliosa, ora che mi hai parlato del tuo amore per i gatti, leggo quei segni lasciati dalla gomma delle coperture delle ruote con occhi diversi. Acquistano un’altra dimensione. Su quel limbo dello studio hai voluto disegnare una tua dinamicità mentale, quella che i tuoi felini hanno saputo donarti nel tempo. E che ora è dentro di te». Efrem sgranò gli occhi. Forse aveva colto qualcosa nelle mie parole e stava meditando un nuovo punto di vista su quell’immagine.
«Gio, mi hai detto una cosa che mi farà riflettere. Dammi tempo, riprenderemo questo discorso. Ora vorrei parlarti di un altro aspetto della mia fotografia, del mio essere fotografo. Con le fotografie che fai tu non è scontato entrare nel mio mondo visivo di fotografo punk». «Fotografo punk? Mi sono perso Efrem». «Mmmhhh, Gio… non capisci un fico secco, tempo buttato via». Scoppiammo in una sonora risata. Gli altri ospiti del locale ci guardavano sbalorditi. Nel frattempo ci servirono le pizze. «Efrem… sei sicuro di voler mangiare quei carciofi sulla pizza?». Efrem sorrise, poi iniziò a tagliare la pizza. «Gio, se hai voglia domani chiamami, ti spiegherò perché scelgo sempre la pizza con i carciofi. Questa sera abbiamo cose più importanti da trattare». «Mi hai incuriosito Efrem. Domattina alle 7.30 in punto ti chiamerò». «Gio, mi piacciono le tue fotografie. Le guardo spesso su Facebook, a volte ti metto anche qualche like. Mai troppi, altrimenti ti monti la testa. Ma da dove prendi spunto per le tue storie? E i testi che scrivi? Li leggo sai!». «Ah, grazie Efrem. Lo spunto arriva dalle storie che sono dentro di me. Siamo un tutt’uno». Seguì un lungo silenzio. In realtà Efrem stava pensando ad altro. Il suo sguardo vagava nell’essenza di quel nulla che appartiene a pochi. Forse solo ai grandi artisti.
Si era fatto tardi, la serata era volata: chiedemmo il conto. Pagammo «alla romana», poi ci avviammo verso la casa di Efrem poco distante. Pioveva a dirotto, e noi eravamo senza ombrelli. Camminammo radenti ai muri, cercando di ripararci sotto le sporgenze delle grondaie. «Gio... ci sciacqueremo i pensieri durante questa camminata, farà bene alla nostra età senza freni». «Dici Efrem?». «No Gio, era solo un pensiero sconnesso». «Efrem, scriverò un testo per te un giorno. Lo farò “scassato”, come piace a te. Non ti prometto nulla, ma mi impegnerò anche nella punteggiatura: a modo tuo, a modo nostro».
(Efrem Raimondi, fotografo noto per i suoi ritratti – tra i volti noti immortalati: Vasco Rossi, Monica Bellucci, Alex Zanardi, Giulio Andreotti e molti altri – è mancato a febbraio 2021)
Le fotografie sono state scattate da Luigi Raimondi (il babbo di Efrem) nel 1961 e da mio figlio Hermes, nel 2014. A Efrem piacevano molto questi suoi ritratti.