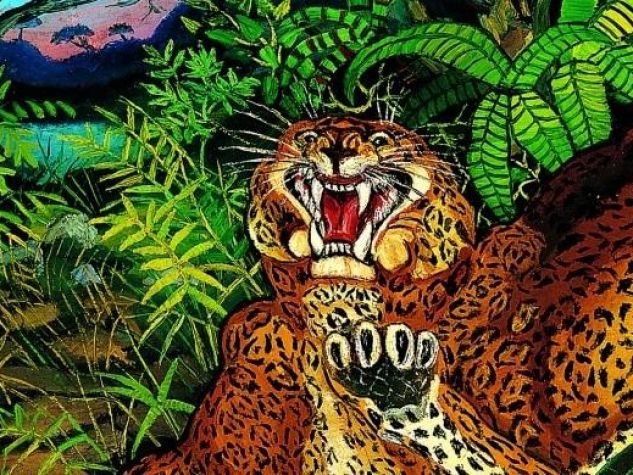L'arte di curare il prossimo
Nel nord della Francia, un esperto medico di campagna, Jean-Pierre, si ammala e per aiutarlo arriva dalla città una collega fresca di laurea, Nathalie. Basteranno le buone intenzioni e la comune passione lavorativa per superare le divergenze e creare una vera equipe? La giovane Nathalie, ex-infermiera d’ospedale, che s’immerge in un contesto rurale per lei nuovo, ha molto da imparare e assieme da offrire in termini umani e tecnici. Nathalie esplora le contraddizioni fisiche e morali di una comunità sconosciuta, senza nascondersi dietro un camice bianco o un freddo strumentario tecnologico, e senza gli ordinati automatismi della routine di reparto, fatta di turni, reperibilità programmata e possibilità di sostituzione in equipe.
Prima di diventare regista, Lilti aveva esercitato la professione medica e qui disegna Nathalie e Jean-Pierre come le due anime di un medesimo personaggio ideale (il medico di medicina generale), che unisce tatto femminile e rigore normativo, frenesia cittadina e pazienza contadina, aggiornamento tecnico e comprensione umana, metodo scientifico e pratica empirica, esattezza dell’informazione e calore empatico, sapere specialistico e creatività decisionale in delicate situazioni personali e familiari. Ebbene, è ancora possibile realizzare una sintesi di queste virtù, oppure si tratta di una pia illusione, di una vuota nostalgia, di una lusinga pubblicitaria? O invece è falsa proprio la presunzione di separare tecnica e umanità?
Eloquenti sono le sequenze in cui i due protagonisti diventano l’uno paziente dell’altro: Nathalie si fa visitare da Jean-Pierre per un certificato di sana costituzione e Jean-Pierre si lascia medicare e radiografare dopo un trauma contusivo, anzi è lui stesso che istruisce la collega su come preparare le lastre. Il guaritore – in altri termini – è sempre vulnerato; non potrebbe occuparsi dei mali altrui, se non ricevesse i segni di una premura affettuosa, se non godesse di una solidarietà allargata, se non tollerasse le precarietà del suo corpo mortale.
Jean-Pierre tace. Divorziato, abituato alla solitudine e geloso della confidenza con i suoi assistiti, non rivela a nessuno il suo male, né al figlio, né alla madre né a Nathalie, che noterà da sola i primi indizi sospetti. Perché? Congedato per malattia, privato dei suoi attrezzi da lavoro, strappato dal suo vivace ambulatorio itinerante, Jean-Pierre teme di cadere in un tragico senso di impotenza e di dover angosciosamente confessare che questa volta è lui che deve chiedere aiuto.
La forma del film corrisponde ai contenuti. Lo sguardo registico mima l’atteggiamento dei personaggi: la macchina da presa ha cura dei piccoli eventi relazionali e li annota con la sobrietà naturalistica di uno scarno diario professionale. Senza orpelli retorici o effetti speciali, il regista immerge banali accadimenti quotidiani nel contesto magico di campi e vigneti, nei riti e costumi contadini che offrono un senso di appartenenza arcaica.
Ci sono tanti racconti famosi sul medico di campana. Anche perché un racconto letterario o filmico si fonda su un patto simile a quello terapeutico. Si realizza uno scambio di promesse tra i partner (autore e fruitore del testo), che ricorda la fiducia che Jean-Pierre ha conquistato in trent’anni di dedizione: quei contadini sanno che possono contare su una persona leale e su un professionista competente. Anche l’esperienza narrativa instaura un’alleanza: andare al cinema significa sospendere l’incredulità, aprirsi ad altre vite, sperare che il film riveli una verità, che ci riguarda, e ci faccia respirare il profumo di terre e prati, che non avevamo mai calpestato.