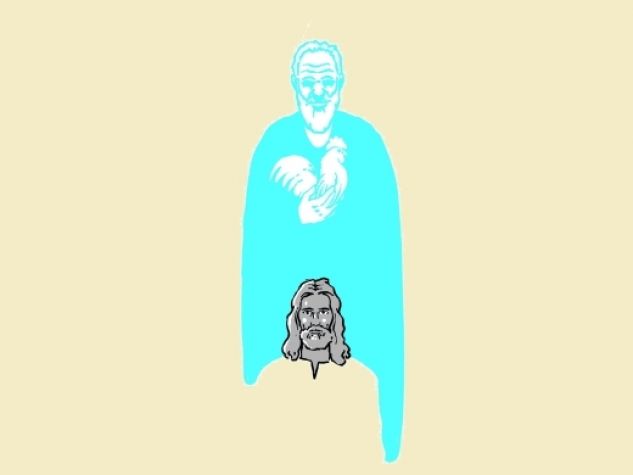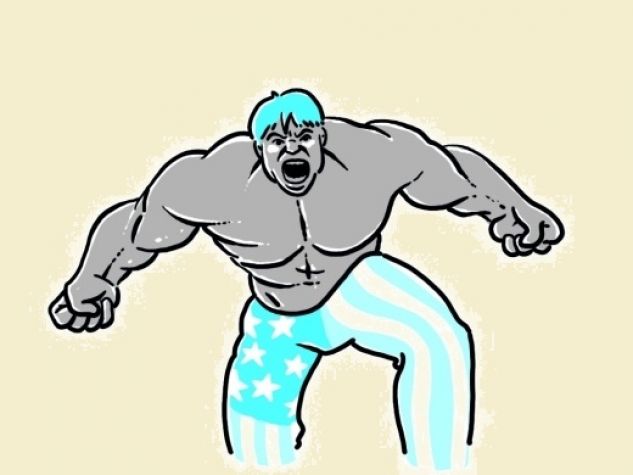Housing First, la casa come diritto
La casa è quel luogo dove ritroviamo noi stessi. Quelle quattro mura sono una seconda pelle, identità di pietra fuori dalle quali il mondo gira veloce e indifferente. Perderle è sempre più facile: un divorzio, una dipendenza, un licenziamento, una malattia mentale. A Giuliano, 58 anni, è bastato che i suoi due anziani genitori morissero per non riuscire più a pagare l’affitto con i mille lavoretti, racimolati di mese in mese: magazziniere, scaricatore di bilici per i supermercati, netturbino. Uno in più caduto nel cono d’ombra dei senza casa, che significa anche dei senza diritti.
Sono migliaia le persone che vivono in strada, soprattutto nelle grandi città ma anche nei piccoli centri, tanti eppure invisibili, visto che al momento non esiste neppure un censimento generale che quantifichi il fenomeno e ne fotografi le caratteristiche in modo più scientifico. Per tanti anni si è cercato di aiutarli potenziando i servizi assistenziali: dormitori, mense, docce pubbliche, ma da una decina d’anni a questa parte un nuovo modello è sbarcato in Italia, rivoluzionando il modo di affrontare il problema. Si chiama Housing First, letteralmente «Prima la casa», e ha al centro la convinzione che la casa sia un diritto umano fondamentale. A molti l’affermazione può sembrare utopica, di fronte agli affitti e ai costi delle case che sono sempre più alle stelle. Eppure l’Housing First sta dimostrando nei fatti, là dove viene utilizzato, che può ridurre in maniera significativa il numero dei senza tetto, recuperando vite, migliorando relazioni sociali e vivibilità nelle città, a un costo-beneficio molto più vantaggioso rispetto all’assistenza tradizionale.
Alle radici di una rivoluzione
L’Housing First nasce negli Stati Uniti negli anni ’50-’60, ma a renderlo noto al mondo è Sam Tsamberis, docente di psichiatria che fonda a New York nel 1992 il primo programma, Pathways to Housing, poi riprodotto in altre città statunitensi. Forte dell’esperienza americana, il metodo arriva in Europa a partire dal 2006 e in Italia dal 2014. Ed è proprio in Europa, precisamente in Finlandia, complice la presenza di un forte Stato sociale, che il metodo dimostra tutta la sua potenzialità, riducendo drasticamente le persone senza tetto del Paese, da 20 mila a meno di 4 mila in dieci anni. Com’è stato possibile?
Il metodo capovolge l’approccio tradizionale «a gradini» utilizzato nel recupero delle persone senza fissa dimora. Prima si richiedeva alla persona, in strada magari da molti anni, di accettare un percorso di recupero, che poteva prevedere, a seconda dei casi, un processo di disintossicazione da droghe o alcol o una cura psichiatrica; nel contempo le si offriva un posto in dormitorio, poi in una comunità, poi nei gruppi appartamento o in altre forme di convivenza. Solo alla fine, dopo anni, poteva accedere a una casa tutta sua, suggello di un percorso andato a buon fine, una specie di ricompensa. «Un iter impossibile per molti, perché se sei in strada da tanti anni, appiattito sulla sopravvivenza, non hai la forza mentale e fisica per intraprendere un percorso così complesso» spiega Caterina Cortese, referente dell’Ufficio Ricerca fio.PSD, una rete di oltre 150 organizzazioni, molte delle quali sono impegnate nei programmi di Housing First.
Tuttavia, se la casa diventa un diritto, questo processo graduale non ha più senso. Le persone, in qualsiasi stato esse siano, passano direttamente dal marciapiede alla casa. Una rivoluzione copernicana che mette al centro la persona e al bando il paternalismo o, peggio, la criminalizzazione di chi vive ai margini della società: «Prima si dà una casa, una stabilità, e solo in un secondo tempo si attivano i percorsi di recupero, grazie a un accompagnamento costante di un’équipe multidisciplinare e all’accesso ai servizi sociali, sanitari, fiscali, formativi», continua Cortese. Un approccio olistico che cambia completamente il punto di vista e che ha nella casa il centro del processo di recupero.
Risultati straordinari
Il passaggio repentino dall’invisibilità alla dignità di cittadino rappresentato proprio dalla casa è uno shock positivo per la maggior parte delle persone senza tetto, anche di quelle che sono in strada da anni, più difficili da avvicinare e da convincere: «Alcuni restano increduli, altri non si fidano perché temono di rivivere daccapo il trauma di tornare in strada, per altri ancora l’Housing First non è la soluzione che va bene per loro e lasciano il programma poco dopo. Ma per la maggior parte è un ritorno alla vita, un recupero della propria dignità, della propria privacy. Avere la possibilità di chiudersi la porta di casa alla spalle vuol dire anche recuperare la sicurezza personale, avere un luogo che ti rappresenta, che ti accoglie in ogni ora della giornata e non solo di notte come nei dormitori, che custodisce le tue cose e può accogliere chi ami». I risultati sono sorprendenti: «Dopo due anni, l’80 per cento delle persone nei programmi di Housing First riesce a tenersi la casa, ciò significa che non solo ci vive rispettando le regole – cosa di per sé straordinaria per chi è vissuto per molti anni in strada – ma la cura, la gestisce, contribuisce economicamente al suo mantenimento. I nuovi inquilini, molti dei quali con gravi problemi di dipendenza, diminuiscono l’uso di sostanze o alcol, si costruiscono una nuova vita sociale e tendono a riallacciare i rapporti con i famigliari, tagliati spesso a causa della vergogna o delle difficoltà di non avere più una casa. Molti di loro non potranno mai riprendere una vita normale perché troppo vecchi o troppo malati, ma sono in grado di vivere una vita dignitosa, senza essere più un peso o un “disturbo” per la comunità».
Risultati straordinari facilitati da un nuovo tipo di accompagnamento da parte degli operatori sociali: «Le persone, una volta in casa, sono seguite da un’équipe multidisciplinare, composta da educatori, psicologi, assistenti sociali, personale sanitario, mediatori culturali, fino ad avvocati e altri tipi di consulenti – spiega la ricercatrice –. L’équipe elabora un percorso di recupero e integrazione sociale, tagliato a misura di individuo, tenendo presente la sua storia, le sue abilità residue, i suoi desideri. Non è mai imposto dall’alto». Per questo la formazione del personale all’interno dell’Housing First è fondamentale per la buona riuscita dei programmi.
Un circuito virtuoso
La storia di Giuliano ne è la prova. L’uomo ha vissuto in roulotte per un anno al margine di un campo, patendo il freddo più estremo e il caldo insopportabile delle estati di oggi, senza acqua e servizi. La sua sembrava una strada senza sbocco, poi l’assistente sociale l’ha segnalato alla Caritas, che a Padova ha una casa in co-gestione con la cooperativa Gruppo R del Gruppo Polis: «L’abbiamo inserito nell’alloggio – spiega Riccardo, uno degli operatori – e da lì è iniziato il percorso di accompagnamento a 360 gradi. Giuliano, come del resto gli altri coinquilini, ha sempre il nostro numero a portata di mano per qualsiasi problema; lo seguiamo giorno per giorno, nelle incombenze quotidiane, promuovendo l’autonomia personale. Per esempio, in questo momento, lo stiamo aiutando a gestire i suoi soldi, perché Giuliano è un generoso e se un compagno di strada gli chiede l’ultimo euro, lui glielo dà». L’aiuto spazia dalle questioni fiscali a quelle relative ai documenti, all’accesso ai servizi sanitari e ai sussidi statali: «Oggi Giuliano sta usufruendo dell’assegno d’inclusione – continua Riccardo –, ma un domani potrà contare su una piccola pensione, visto che siamo riusciti a ricostruire vent’anni di contribuiti che lui non sapeva neppure di avere. Ora ha ottenuto l’assegnazione di una casa popolare, ha già firmato il contratto e, grazie alla pensione, potrà contribuire alle spese di mantenimento». Un esempio concreto di come l’Housing First inneschi un circuito virtuoso, proprio a partire dalla casa, combattendo concretamente la marginalità e le conseguenze economiche e sociali legate a essa, a beneficio dell’intera comunità.
Tuttavia, mettere in moto questo circuito virtuoso non è semplice. In Italia è possibile grazie a una caratteristica peculiare: la collaborazione tra il pubblico e il privato sociale che si occupa di marginalità. «Da un lato c’è una spinta dall’alto, dall’Europa e dalle istituzioni nazionali che in varie forme stanziano fondi per i servizi ai senza tetto e per co-finanziare l’Housing First, dall’altro c’è una spinta dal basso molto forte che viene dai territori e dal terzo settore, quindi associazioni, cooperative, per portare avanti quanti più progetti abitativi possibile con o senza l’aiuto pubblico» afferma Caterina Cortese. La debolezza dei programmi finanziati dal pubblico sta spesso nel fatto che essi finiscono con la fine dei fondi, mentre l’Housing First prevede l’accesso all’abitazione fino a quando occorre, anche per tutta la vita, altrimenti la casa smette di essere un diritto. «Fortunatamente la fitta rete che c’è in molti territori, fatta di enti pubblici e privati locali, spesso riesce a dare continuità ai programmi».
L’altra grande difficoltà per la realizzazione dell’Housing First è il reperimento degli alloggi: «Vengono assegnati a tali progetti le case popolari più piccole non adatte alle famiglie, oppure alcuni beni ecclesiastici in disuso o beni confiscati alle mafie; altri appartamenti vengono reperiti nel mercato privato, grazie ad accordi con agenzie più sensibili, che mettono a disposizione gli immobili meno appetibili per i clienti, ma utilissimi ai fini sociali» afferma Cortese.
I numeri italiani
In dieci anni di Housing First in Italia i risultati sono significativi e promettenti: «Sono stati realizzati 75 progetti in 39 città di 14 regioni. Le persone accolte sono state 1.763 in 795 case» snocciola Cortese. Contrariamente a quanto si crede, la maggior parte, il 61,2 per cento, sono italiani, in maggioranza uomini, con un’età media di 47 anni, con un incremento, negli ultimi tempi, delle fasce più giovani. Segno che il problema rischia di diventare più grave in futuro, a causa di nuove forme di marginalità e povertà. I numeri dell’Housing First sono ancora piccoli rispetto alla quantità di persone che ne avrebbero bisogno, ma l’esperienza sta facendo apprezzare la maggiore efficacia di questo tipo di approccio, anche dal punto di vista del costo-beneficio: «In media, una persona in dormitorio costa 15-20 euro a notte – fa notare la ricercatrice –; in un programma di Housing First costa di più, circa 30, però mentre nel primo caso l’aiuto mantiene le persone appese al filo dell’assistenza, nel secondo le persone diventano soggetti attivi di autosviluppo». Una situazione che li porta presto a contribuire ai costi dei programmi, grazie al fatto che – ora che hanno una casa e un’identità – possono trovarsi un lavoro o avere una pensione, come nel caso di Giuliano. Proprio per queste caratteristiche partecipative, «abbiamo notato che i progetti di Housing First costano di più all’inizio, ma diventano sempre meno onerosi nel tempo, fino a diventare più convenienti rispetto all’assistenza tradizionale» chiosa Cortese.
Un vantaggio economico che presto diventa un vantaggio sociale allargato: chi ha una casa controlla meglio i suoi problemi senza portarli all’esterno, non ha più bisogno di un certo tipo di assistenza, ha diritto al medico di base e quindi non intasa più il pronto soccorso per curarsi, ha tutti i documenti e può, quindi, ritornare a essere un soggetto attivo con delle potenzialità per se stesso e per la società, mentre per lui la vita rifiorisce. Giuliano alla domenica va al bar con un’amica conosciuta durante la vita di strada. Con Riccardo hanno deciso che ora può permetterselo. Le offre il cappuccino con la brioche. Ama molto farlo. La vita, quella vera, in fondo è fatta di piccole cose.
Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!