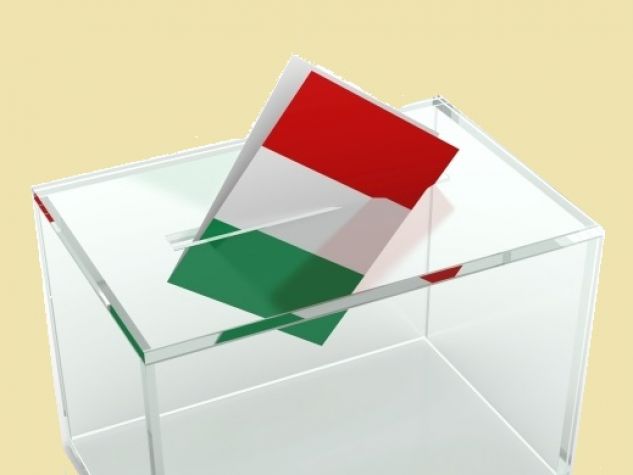Carità in azione (II^ parte)
«La compassione è oggi un tema da riscoprire e da riscoprire con urgenza – sottolinea anche Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose, che lo scorso giugno ha tenuto una lunga conferenza sul tema all’interno della rassegna SENTIMENT, a Misano Adriatico (RN) –. Perché ci sono molti segni in questo momento, soprattutto nel nostro Occidente, di ritorno verso la barbarie, verso una vita in cui bisogna solo affermare se stessi senza prendersi cura degli altri. Esempio emblematico è la vicenda del giovane migrante feritosi al lavoro al braccio e lasciato morire dissanguato. Dove manca la compassione accade esattamente questo. Quella scena ci dice in modo epifanico la banalità del male, il quale si afferma proprio quando non c’è compassione».
Fino a qualche tempo fa, spiega ancora il monaco, il termine era rivestito, forse, di accezioni negative («io non voglio far compassione a nessuno» si diceva), che lo assimilavano alla pietà provata da chi guarda una persona sofferente dall’alto verso il basso, sentendosi superiore. Ma recentemente, per fortuna, «è tornato a essere usato nel suo valore semantico che, secondo la sua etimologia latina, cum patior, sta proprio a significare un patire insieme» senza delineare posizioni di potere.
Ma parlare di dolore ci conduce al problema del male. «Noi esseri umani – prosegue Bianchi – siamo per così dire affascinati dal problema dell’enigma del male. Unde malum? Da dove viene il male? È sempre questa la domanda che ci poniamo. Eppure non esistono risposte convincenti. Nessuna religione, neppure il cristianesimo, ci dice in maniera convincente da dove viene il male e perché c’è la sofferenza nel mondo. In verità, la vera domanda che dovremmo farci non è “da dove viene il male?”, ma “che cosa dovremmo fare per ostacolare il male?”. È a questo interrogativo che gli umani hanno cercato di dare risposte concrete, operative. E le differenti vie religiose percorse dall’umanità hanno percepito che l’unica cosa seria che si può fare contro il male è praticare la compassione, il soffrire insieme. La compassione non è quindi una soluzione alla sofferenza, ma è l’unica risposta sensata che l’uomo può dare di fronte al male. Si tratta di soffrire dinanzi alla sofferenza di un altro». E, attenzione, sottolinea ancora il monaco: «Questo sentimento, questa passione da assumere in primo luogo nelle relazioni interpersonali, non si può limitare a tale dimensione, ma deve aprire una strada a livello sociale e anche politico. Tutto inizia in un rapporto faccia a faccia con chi soffre, ma la dinamica della vita porta a sentire la compassione come un problema sociale di cui si deve essere investiti e responsabili nella vita della polis».
Eppure oggi la compassione appare particolarmente difficile, perché il nostro contesto culturale ha una percezione del male molto diversa dal passato. «Oggi i media sono diventati barriere per il dolore altrui e ci condannano sempre di più a un quotidiano di solitudine e isolamento – conclude Enzo Bianchi–. Nella società della comunicazione abbiamo paradossalmente difficoltà a farci prossimi agli altri, diventiamo con facilità virtualmente prossimi, perché il web ci fa moltiplicare (attraverso i social) la nostra prossimità virtuale, ma creiamo contatti liquidi inversamente proporzionali alle relazioni solide. Realmente vissute. E così la morte della prossimità è vissuta come negazione, come morte del prossimo, come ha acutamente compreso il sociologo Luigi Zoia che ha intitolato un suo libro La morte del prossimo».
Ma se è vero che i media sono spesso barriere, i media possono anche diventare ponti. In che modo? «La compassione oggi manca, è vero – concorda Alessandro Banfi, conduttore e autore di programmi televisivi, già direttore del Tgcom24 –: manca nell’atteggiamento della gente, ma anche nei mezzi di comunicazione, nel raccontare le storie degli altri, le vite degli altri, perché poi alla fine il giornalismo e la comunicazione non sono altro che raccontare le vite degli altri. Ma se le raccontiamo con spietatezza, con cattiveria, cercando di dividere il mondo in buoni e cattivi, cercando i nemici, cercando lo scandalo, cercando il male, è chiaro che alla fine avveleniamo la nostra convivenza, non gli diamo la possibilità di essere umana. Eppure, la compassione è connaturata all’essere umano. È sempre esistita, come ci mostra il finale del secondo libro dell’Eneide: Enea sta scappando, dopo che i greci sono entrati a Troia, ma nella fuga perde la moglie, così torna indietro e vede da lontano il popolo che lo aspetta e ha un moto di compassione fortissimo nei suoi confronti, si commuove. Enea è un esempio di quello che c’è trasversalmente in tutta la letteratura, in tutta l’esperienza umana, quella naturale compassione che è un sentimento non solo religioso, ma innanzitutto umano, fondamentale in un periodo come il nostro, nel quale viviamo in una continua guerra e in una continua spinta a dividere il mondo in amici e nemici».
Ma la compassione non può esulare da un incontro personale, da una relazione autenticamente umana. «A tal proposito – continua Banfi – mi viene in mente una pagina bellissima di Eraldo Affinati, che è un grande scrittore e un grande insegnante, uno che ha messo in piedi nel nostro Paese la prima scuola gratuita per l’insegnamento dell’italiano agli stranieri. Nel suo libro su don Milani, raccontando la propria esperienza di insegnante, dice che la prima volta che è entrato in una classe ha sentito come un magnetismo tra lui e i ragazzi, perché in essi si rivedeva. E racconta, testualmente: capii che “c’erano ferite da risanare, persone da rimettere in piedi, lacrime da asciugare. Se fossi riuscito a fare questo, pensai, avrei affermato un principio d’umanità, sul quale altri avrebbero potuto costruire la loro vita”.
Questa è la vera compassione: vedersi, riconoscersi nell’altro e agire per sollevarlo dalla sua difficoltà. E un racconto molto simile lo fa anche Agnese Moro, la figlia dello statista Aldo ucciso nel 1978 dalle Br, quando spiega l’incontro con gli assassini del padre che per lei, per tanti anni, erano rimasti solo dei fantasmi. Invece, ha confidato, quando li ha incontrati essi sono “diventate persone” e lei ha provato ad ascoltarli. Perché, alla fine, il segreto sta tutto qui: essere capaci di toglierci le maschere che ci hanno intrappolato per decenni. Loro, quelle dei cattivi per sempre, noi, quelle di vittime per sempre. Quando racconta questo episodio, Agnese Moro lo dice chiaramente: bisogna incontrarsi, guardarsi in faccia, provare a raccontarsi e imparare a disarmarsi per ascoltare. Questa è una cosa bellissima, perché alla fine la compassione sta proprio in questa capacità di ascolto per curarsi reciprocamente le ferite, non è solo un fatto di umanità, è anche un fatto che costruisce un nuovo modo di vivere».
Un modo di vivere che è prettamente umano, ma è anche, e soprattutto, divino. E lo comprendiamo in particolare quando accompagniamo una persona in una malattia grave o alla morte. Dice infatti Luciano Manicardi, già priore di Bose e autore de L’umano soffrire: «Dal punto di vista teologico, la Bibbia attribuisce la compassione anzitutto a Dio e ne fa l’elemento in base al quale Dio “vede” la sofferenza del popolo e si appresta a intervenire a suo favore (Esodo 2,23-25; 3,7-8); Cristo nei vangeli appare come narrazione e personificazione della compassione di Dio, ben espressa nell’atteggiamento del buon samaritano che, passando accanto all’uomo ferito, “lo vide e ne ebbe compassione” (Luca 10,33). Da questo sconvolgimento interiore, da questo soffrire la sofferenza dell’altro, il samaritano è condotto a un comportamento etico in base al quale fa tutto ciò che è in suo potere per alleviare la situazione del bisognoso».
La compassione, prosegue il monaco, «non è solo un sentimento che si impone al cuore dell’uomo, ma diviene scelta, responsabilità. Essa è risposta al muto grido di aiuto che si leva dal viso dell’uomo sofferente, dagli occhi atterriti e più che mai nudi e inermi della persona soverchiata dal dolore, vicina alla morte; è il no radicale all’indifferenza di fronte al male del prossimo: in essa io partecipo e comunico, per quanto mi è possibile, alla sofferenza dell’altro uomo. La compassione, facendo della sofferenza una sofferenza per l’altro, spezza l’isolamento in cui l’eccesso di sofferenza rischia di rinchiudere l’uomo. L’impotenza del malato, del morente ha la paradossale forza di risvegliare l’umanità dell’uomo che riconosce l’altro come un fratello proprio nel momento in cui non può essere strumento di alcun interesse. In questo senso la sofferenza per la sofferenza altrui è uno dei più alti segni della dignità umana».
«La compassione – conclude Manicardi – è dunque una forma fondamentale dell’incontro con l’altro, un linguaggio umanissimo, perché linguaggio di tutto il corpo, che coinvolge i gesti, la gestualità, la parola, la presenza personale. Certo, la compassione nasce in chi accetta di lasciarsi ferire e colpire dalla sofferenza dell’altro, sicché solo chi riconosce la propria vulnerabilità sa aprirsi alla sofferenza altrui: “Solo un io vulnerabile può amare il prossimo” diceva il filosofo Emmanuel Lévinas. E di fronte al malato per cui non c’è più nulla da fare dal punto di vista medico, che altro resta se non con-soffrire restandogli accanto, parlandogli, esprimendogli, nei modi che lui può ancora capire, che noi lo amiamo? “Io non so come accada che, quando un membro soffre, il suo dolore divenga più leggero se le altre membra soffrono con lui. E l’alleviamento del dolore non deriva da una distribuzione comune dei medesimi mali, ma dalla consolazione che si trova nella carità degli altri” scriveva sant’Agostino. Sì, decisamente, nella compassione vi è la rivelazione di qualcosa che è profondamente umano e autenticamente divino».
C’è un passaggio, nel libro La notte di Elie Wiesel, nel quale l’autore racconta un episodio avvenuto in un campo di sterminio. Un mattino vennero impiccati alcuni prigionieri. Tra di essi vi era un bambino che subì la stessa sorte degli altri. Ma lui non riusciva a morire, perché era troppo leggero, e così era rimasto ad agonizzare per mezz’ora con la corda al collo. Tra gli altri prigionieri, costretti a guardare, una voce si alzò: «Dov’è Dio ora?». E un’altra subito rispose: «Dio è appeso a quella corda, insieme a quel bambino». Dio soffre con noi. E noi, fatti a sua immagine, dobbiamo saper vivere la stessa passione per gli altri che soffrono. Perché se l’indifferenza e l’odio disumanizzano, solo la compassione può renderci pienamente umani.
Puoi leggere tutto il dossier nel numero di marzo del «Messaggero di sant'Antonio» e nella versione digitale della rivista. Provala ora!