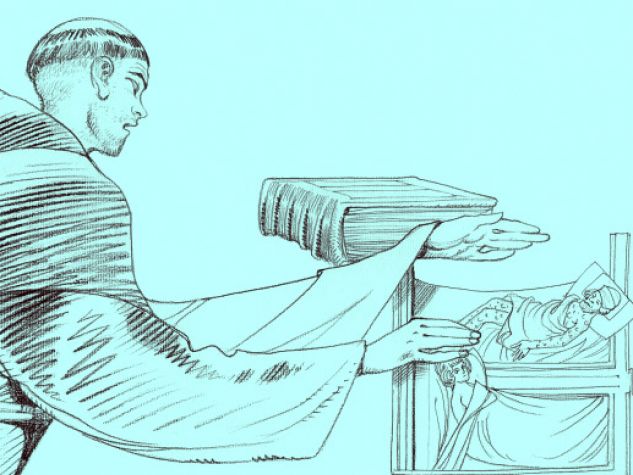Dostoevskij, il cantore della fragilità
Lo scrittore e regista austriaco Peter Handke, sostiene che «una narrazione che non passa attraverso l’io dell’autore non è letteratura ma solo un semplice prodotto». Un’affermazione che non potrebbe essere più vera nel caso di Fëdor Dostoevskij, uno degli autori più letti al mondo (se lo sapesse, dopo anni di stenti e di debiti…) – e del quale ricorrono quest’anno i due secoli dalla nascita –, che fin dalla più giovane età fu ossessionato dall’osservazione e comprensione dell’umano. Potenti risuonano le sue parole in una lettera del 1849 al fratello Michail, una volta scoperto, a un passo dalla pena di morte, che il suo castigo è stato tramutato in quattro anni di lavori forzati: «La vita è vita ovunque, la vita è dentro di noi, non al di fuori. Intorno a me ci saranno altri uomini, ed essere un uomo tra gli uomini e rimanerlo per sempre, qualunque disgrazia capiti, senza lamentarsi, non perdersi d’animo: ecco in che cosa consiste la vita, qual è il suo scopo. Me ne sono reso conto. Quest’idea si è fatta di carne e sangue. È la verità!».
Carne e sangue: l’umano. Una vera ossessione per Dostoevskij, se è vero che le sue opere si pongono nient’altro che questo obiettivo audace, che fu anche di certa letteratura antica: l’indagine dell’essere umano. Laddove la narrativa del tempo si immergeva nella descrizione del mondo circostante, della borghesia, della guerra, della storia, in Dostoevskij le parole narrano il profondo dell’animo umano, indipendentemente dalla narrazione di una trama, spesso solo superficialmente legata al nucleo reale del romanzo.
E così, magicamente e senza che ce ne accorgiamo, diventiamo tutti Raskol’nikov di Delitto e castigo: non abbiamo mai ucciso per soldi ma condividiamo i suoi pensieri e la sua pena. Oppure il principe Myškin dell’Idiota: siamo meno ingenui, ma comprendiamo nel profondo il suo dolore e contempliamo la sua saggezza. I personaggi di Dostoevskij sono tutti noi, siamo noi: ecco un frammento di umanità che non sapevamo di avere. Eccolo che esplode in noi.
Amore per l’umano
Ma in questa costante esplorazione dell’animo umano dove si trova l’autore? «Vi ho descritto tutto questo e vedo che della cosa principale, cioè della mia vita spirituale, del cuore, non ho detto nulla e non ve ne ho nemmeno dato un’idea. Sarà così sempre, fino a che ci scriveremo. Non so scrivere le lettere e riguardo a me stesso non so scrivere con misura».
Era il 1865 e Fëdor Dostoevskij scriveva queste parole. Ma com’è possibile che un uomo che ha dedicato la vita alla scrittura e che ha prodotto in vita centinaia e centinaia di lettere affermi di non saperle scrivere? Così come molti altri autori, Fëdor Dostoevskij non si trova a suo agio nello scrivere lettere. Per uno scrittore che fa dell’animo umano il centro della sua indagine non c’è altro modo di raccontare se non andando in profondità, scandagliando il mondo interiore con tutta la precisione di cui si è capaci; ma farlo con un personaggio che si ha nella mente e che quindi in qualche modo si ha in pugno è un’attività che l’autore compie con disinvoltura.
Ben diverso è farlo con se stessi, doversi aprire al prossimo, fotografare un frammento di sé, che per sua natura, molecola dopo molecola, ingiallirà presto, deperirà. Se ogni essere umano è in costante divenire, fotografare il proprio pensiero è, in qualche modo, per Dostoevskij, un atto innaturale. Solo l’Opera è eterna. Solo l’Opera è imperitura. È con la sua opera che è possibile interrogarsi su tutto: sui misteri dell’universo, sulla fede. La scrittura per lui è un mezzo di costante ricerca di fede. La sua fede non ha nulla di dogmatico: è una religione che accoglie i limiti dell’uomo e che può persino inglobare una qualche forma di ateismo, una religione che accoglie tutti e tutto, che abbraccia il colpevole e l’innocente, che sfuma i contorni netti che siamo abituati a dare alle cose e che si fa guidare solo e unicamente dall’amore, motivo per il quale la figura di Cristo risulta sempre fondamentale per l’autore, dentro e fuori dai testi.
In una lettera del febbraio 1854, l’autore scrive: «Vi dirò di me che io sono un figlio del secolo, sono un figlio del dubbio e della miscredenza, fino a oggi e (lo so) finché campo. Questa sete di fede mi è costata e mi costa spaventose sofferenze, ed essa cresce nel mio animo tanto più forte quanto più in me albergano conclusioni opposte. E tuttavia, Dio mi concede a volte degli attimi in cui sono assolutamente in pace; in quei momenti amo e vedo che sono amato dagli altri, e in quei momenti ho riposto in me il simbolo della fede nel quale per me è tutto limpido e santo. Questo simbolo è molto semplice, ed è questo: credere che non ci sia niente di più bello, profondo, disponibile, sensato, coraggioso e perfetto di Cristo e non solo non c’è, ma mi dico con amore geloso, che nemmeno può esistere. Inoltre, se qualcuno mi dimostrasse che Cristo è al di fuori della verità, e davvero la verità si trovasse fuori di Cristo, preferirei comunque rimanere con Cristo piuttosto che con la verità».
Cristo è quindi massimo esempio d’amore e unica via da seguire per poter sopportare il peso della tragedia umana, costretta in un corpo perituro e schiacciato dalla fragilità, e costretta da impulsi nefasti che – in qualsiasi essere umano, anche il più chiaro e limpido – rovinano i giorni e le notti. Siamo esseri fragili, fuori e dentro, e proprio per questo Dostoevskij prova pietà per l’essere umano e per se stesso, esempio supremo di questa debolezza. Eccolo lo scrittore, eccolo pieno di vita, così vivo da non nascondere neanche a se stesso i suoi lati oscuri, sia fisici (è fin da giovane malato di epilessia e ne soffrirà per tutta la vita) che interiori (basti pensare alla sua passione per il gioco d’azzardo che porterà lui e la moglie più volte a un passo dalla rovina). Intrecciare segmenti di sé nelle sue opere. Vivere la scrittura come un’esplorazione e come un assedio.
E così Fëdor Dostoevskij non è poi dissimile dai suoi personaggi, anche lui brancola alla ricerca di una verità superiore, anche lui scende negli abissi dell’umano, il sottosuolo, per poi cercare faticosamente di risalire per un bene superiore, dal quale veniamo tutti attratti e che non dobbiamo smettere di cercare.
Sanguina ancora la parola di Dostoevskij, come recita il titolo del libro di Paolo Nori. Sanguina ancora a distanza di secoli e ancora lo farà, secolo dopo secolo. Perché esplorando i meandri della sua mente, attraverso i suoi romanzi, ci parla di noi, delle nostre debolezze, delle nostre sofferenze. Ci fa tremare. Ci lacera. Ci abbraccia. È un abbraccio, la sua opera, doloroso e commovente come gli abbracci di addio o di riconciliazione. Sembra dire, la sua opera, che l’unico modo per sopravvivere a questa vita è accettare anche il male, accettare anche il «sottosuolo»: risalendo troveremo sempre qualcuno pronto ad abbracciarci.
Per approfondire:
Alice Farina è la curatrice del volume Lettere (Il Saggiatore, pagine 1376, € 75) che raccoglie l’immenso espistolario di Dostoevskij.
Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!