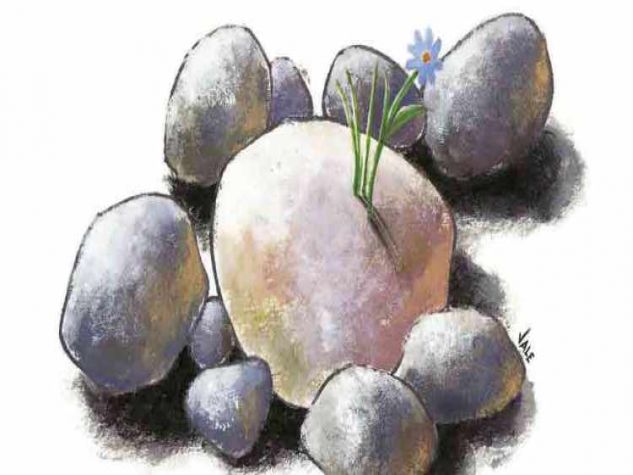È possibile una «santa» indignazione?
Esiste una strana pretesa nell’animo di chi non ha nulla da temere o niente da cui difendersi: è quella di non vedere intorno a sé nessuno che protesta, scuotendogli la serenità. Se proprio c’è qualcuno che non può fare a meno di lamentarsi, la speranza di chi vive tranquillo è che costui abbia almeno la buona educazione di organizzare un dissenso composto, meglio ancora se invisibile. L’aspettativa di chi vive comodo è che chi protesta non debba causare il minimo disagio a chi non ha niente per cui protestare. È un meccanismo che abbiamo visto molte volte e, in inglese, prende il nome di tone policing, un’espressione che indica l’abitudine paternalistica di fare agli altri la lezioncina su quelli che sarebbero i giusti toni da tenere quando ci si lamenta di un’ingiustizia.
Chi si serve di questo meccanismo dice le stesse frasi a ogni latitudine: protesta, ma non alzare la voce. Scendi in piazza, ma non creare scompiglio. Di’ che non sei d’accordo, ma fallo silenziosamente. Hai ragione, ti dicono, ma sbagli i toni. Stai esagerando e, così, passi dalla parte del torto. Se lo sentono dire da anni gli attivisti Lgtb che organizzano eventi per rendere evidente la loro esistenza a chi la nega, ma sono frasi che conoscono bene anche i partecipanti alle manifestazioni del movimento Black Lives Matter e le femministe, accusate di essere sempre troppo «arrabbiate».
Partendo dal fatto che è proprio creando un disagio che si diventa visibili, è giusto chiedersi quali sarebbero i toni che non fanno passare dalla parte del torto. Chi subisce un’ingiustizia ha l’obbligo di essere beneducato nel far notare che vive una sofferenza? L’indignazione davanti all’umanità calpestata deve essere composta per essere considerata legittima? Lo scorso mese ci sono stati due episodi in cui queste domande sono tornate a risuonare.
La prima volta è stata quando Roberto Saviano è stato costretto a presentarsi davanti a un tribunale per rispondere del fatto di aver usato un termine forte nei confronti di Giorgia Meloni e Matteo Salvini in una trasmissione televisiva, con spontanea indignazione davanti alle immagini del corpo di un piccolo migrante affogato per assenza di soccorsi nel Mediterraneo. La seconda volta è stata quando il cantante Ghali, allo stadio di San Siro, si è alzato inveendo sempre contro Matteo Salvini per motivi analoghi a quelli di Saviano. Entrambi sono stati apostrofati come persone scomposte, che hanno ecceduto i toni della buona creanza. Est modus in rebus, avrebbero detto i latini, e i modi dello scrittore e del cantante sono apparsi sanzionabili a molti.
Davanti a queste considerazioni risuonano le parole del Salmo 136, che comincia con il celebre verso: «Sui fiumi di Babilonia». Il Salmo racconta la situazione surreale degli ebrei, conquistati e deportati dai babilonesi da più di una generazione, un tempo così lungo che i loro conquistatori si illudono di pacificare la violenza passata invitando gli esuli a integrarsi, dimenticare il passato e condividere i canti della loro terra. «Cantateci i canti di Gerusalemme!».
Alla prospettiva, il salmista ammonisce se stesso – «mi si attacchi la lingua al palato se intono i tuoi canti in terra straniera, o Gerusalemme» –, poi esegue un canto di maledizione con parole così pesanti che si stenta a credere che possano essere una preghiera. «Ricordati, Signore, dei figli di Edom, / che nel giorno di Gerusalemme, / dicevano: “Distruggete, distruggete / anche le sue fondamenta”. / Figlia di Babilonia devastatrice, / beato chi ti renderà quanto ci hai fatto. / Beato chi afferrerà i tuoi piccoli / e li sbatterà contro la pietra».
L’immagine di bambini sfracellati, di una città distrutta e l’augurio del contrappasso sono così violenti che è lecito sentirsi urtati da quei versi. Eppure il Salmo dice una cosa preziosissima: c’è un registro di invocazione al cielo che è fatto di rabbia e dolore, di indignazione e senso profondo di ingiustizia, uno stato d’animo orante a cui le parole di pace e conciliazione non sono sufficienti. La violenza di Babilonia devastatrice non è la stessa violenza del salmista che invoca la distruzione dei suoi deportatori. Da un lato c’è un fatto violento concreto – un’invasione, la rasa al suolo di Gerusalemme, lo sradicamento di un popolo, la pretesa di vederlo felice fuori dalla sua patria –, dall’altro c’è un uomo con una cetra in mano che rifiuta di considerare la violenza subita come un fatto che può essere dimenticato.
La Scrittura non equipara la violenza dei carnefici alla protesta delle vittime. L’indignazione che dovrebbe scuoterci il cuore non è quella per le parole violente del cantore che non vuole fare il giullare per i figli dei suoi carnefici, ma è quella per la violenza primaria che ha sbattuto sui fiumi di Babilonia migliaia di persone a piangere la propria casa natale distrutta e i propri neonati sfracellati sulle rocce. È la stessa indignazione che dovrebbe animarci davanti al corpo di un bambino morto per mancanza di soccorsi e farci gridare – sì, anche allo stadio – davanti a chi ha costruito le politiche per rendere impossibile l’accoglienza.
Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!