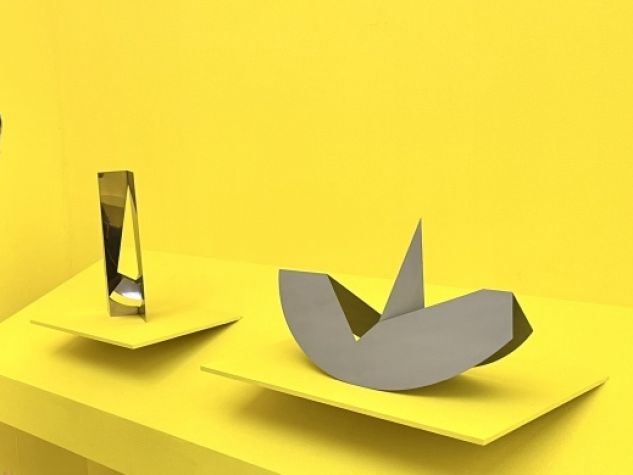Il disagio si vince sul palco
Via Cassia 472, Roma. Sala prove del Teatro Patologico. Un pomeriggio di inizio primavera. La compagnia stabile prepara il nuovo spettacolo, L’Ulisse. Il miracolo della creazione artistica va in scena. La voce della Callas risuona nella sala. Gli attori disabili provano con pazienza. Lavorano sui personaggi, ma anche su loro stessi. Il lavoro conclusivo sarà l’esibizione plastica di un percorso interiore. Fatica e passione come uniche strade da percorrere, giorno dopo giorno. «Siamo qui per sbagliare, non vi preoccupate se non ci ricordiamo una battuta, andiamo avanti», spiega Ilaria, l’assistente alla regia.
Un progetto innovativo
II Teatro Patologico non è solo una compagnia teatrale, ma un vero e proprio laboratorio di sperimentazione, che ha dato vita alla prima «Scuola europea di Formazione teatrale per persone con disabilità», denominata «La magia del Teatro». Qui il teatro diventa terapia, canale di comunicazione e strumento di crescita personale. Un’idea rivoluzionaria, una missione sociale e artistica che rompe le barriere della disabilità per trasformarla in pura espressione teatrale. La sala in cui ci troviamo – pareti nere, parquet di legno a terra – è il cuore del Teatro Patologico, un’esperienza, nata nel 1992 da un’idea di Dario D’Ambrosi, che offre a persone con disabilità psichiche un palcoscenico su cui raccontarsi, esprimersi e, soprattutto, riscattarsi.
Nativo di Milano, attore, regista e drammaturgo, D’Ambrosi è un artista capace di coniugare la passione per il teatro con lo studio delle malattie mentali. La sua formazione ha radici internazionali: a soli 19 anni si trasferisce a New York, entrando nel celebre Caffè La Mama, un locale che ha visto esibirsi artisti del calibro di Robert De Niro. Nel corso della sua carriera D’Ambrosi ha lavorato anche nel cinema e in televisione, recitando in film come Titus di Julie Taymor e La Passione di Cristo di Mel Gibson, oltre a dirigere pellicole come L’uomo gallo.
Lo incontriamo nel suo ufficio, a pochi passi dalla sala prove della compagnia, dove ci racconta come tutto è nato: «Da ragazzo pensavo che il calcio fosse la mia strada; ho giocato anche nella Primavera del Milan. Ma con il tempo ho capito che quello non era il mio mondo: troppo lusso, il mito del successo, cose che non mi appartenevano. La mia vita privata era complicata: avevo problemi a casa, mio padre era un uomo violento, vivevo a San Giuliano Milanese, periferia altrettanto violenta. E da tutto ciò non sapevo come uscire, avevo un carattere molto tormentato emotivamente, non mi sentivo bene dov’ero e com’ero. Così chiesi consiglio ad alcuni amici psichiatri e da lì nacque l’idea di trascorrere un periodo da internato all’ospedale psichiatrico “Paolo Pini”, nel capoluogo lombardo. Fu illuminante. Il tempo trascorso tra quelle mura fu la mia salvezza. Senza di esso avrei fatto una brutta fine, com’è accaduto a molti miei amici d’infanzia».
E fu proprio grazie a questa esperienza che D’Ambrosi maturò il desiderio di dedicarsi ai più deboli, ai disabili psichici e fisici. «Feci un corso di teatro a Milano, in viale Torino, con un regista argentino – continua –. E poi creai uno spettacolo, Tutti non ci sono, nel quale raccontavo la mia infanzia, la violenza in famiglia, l’esperienza al manicomio di Milano. Andò bene e da lì pensai di andare avanti. Ma a Milano non respiravo abbastanza fiducia nei miei confronti, così a nemmeno 20 anni andai negli Stati Uniti. A New York conobbi Ellen Steward, una direttrice artistica e impresaria che mi diede la possibilità di andare in scena con il mio spettacolo. Fu un successo. Al ritorno in Italia iniziai a lavorare con associazioni che si occupavano di malati di mente, fino a creare il Teatro Patologico. Oggi posso dire che la vita passata coi miei attori mi ha salvato».
Da allora, di strada D’Ambrosi ne ha percorsa tanta e anche il suo modo d’intendere il teatro con gli anni si è evoluto: «All’inizio il mio lavoro era basato su alcuni esercizi che avevo acquisito lavorando con il regista Peter Brook – racconta –, ma, poco alla volta, stando a contatto con le persone disabili, ho scoperto che i loro tempi non potevano essere dettati dall’orologio. Le loro pause non erano quelle che ti insegnano nei corsi di teatro. Non erano mai noiose, ma non capivo la loro natura. Solo col tempo ho realizzato che quelli erano “momenti di vita e di morte” per loro, come diceva il regista francese Antonin Artaud. Era come se quei miei attori speciali uscissero da un mondo reale per poi tornarvi. Così, pian piano, gli esercizi teatrali si sono evoluti. Ora sono più forti, più chirurgici. Si legano alle emozioni degli attori. Si sono modificati in base a ciò che ho scoperto sulla psiche umana».
Un lavoro delicato, fatto di continue scoperte e che richiede giorno dopo giorno continui aggiustamenti. «Gli attori della mia compagnia mi stupiscono ogni giorno – prosegue D’ambrosi –. Soprattutto i ragazzi autistici. Mi colpiscono per la loro creatività, che è molto più libera rispetto a quella degli attori accademici. A loro lascio sempre una grande libertà. Le faccio un esempio. La Medea, uno dei nostri lavori di maggiore successo, rappresentato in tutto il mondo, è nata nel periodo del delitto di Cogne, dopo che Claudia, una ragazza con la sindrome di Down, mi aveva chiesto di fare un lavoro sul tema di una madre che uccide il proprio figlio. Ne discutemmo insieme, facendo uscire i nostri pensieri. Da lì lavorammo con esercizi non tradizionali, evitando una lettura a tavolino delle scene. Con gli attori partiamo spesso da elementi concreti, come l’acqua e la farina che impastiamo insieme. E questo approccio iniziale ci piace molto, ci stimola molto. E poi lavoriamo per ottenere un buon risultato. Io dico sempre ai “ragazzi” che dobbiamo ambire a un applauso sincero da parte del pubblico, slegato dalla nostra condizione di disabilità».
Gli attori della compagnia provengono da mondi ed esperienze diverse, ma sono accomunati da una vita difficile. «Le persone con cui lavoro sono per me il sale della vita – insiste il fondatore di Teatro Patologico –. Senza di loro la mia stessa esistenza sarebbe una noia mortale. Alcuni attori, quando sono arrivati qui, stavano molto male. In molti hanno alle spalle una vita durissima. Quando abbiamo lavorato sull’Inferno di Dante, per esempio, ci siamo ispirati al loro inferno personale. Aiutiamo e salviamo tanti ragazzi, perché quando una persona con disabilità sta bene, anche la sua famiglia ritrova equilibrio. Spesso i genitori dei ragazzi mi dicono: “Da quando nostro figlio frequenta il Teatro Patologico, siamo tornati a dormire la notte e a sorridere”. E questo per me è il regalo più grande».
Teatroterapia, una speranza
Ma come vivono l’impegno teatrale e le tournée gli attori di una compagnia così particolare? «È un osservatorio interessante per loro – informa D’Ambrosi –. In questi momenti possono vedere le differenti reazioni emotive di ogni tipo di pubblico. E questo li aiuta tantissimo a livello psicologico. Chiaramente gli spostamenti sono impegnativi dal punto di vista organizzativo. In viaggio con gli attori e la compagnia ci sono sempre anche famigliari, psicologi, assistenti sociali. Molti dei ragazzi che salgono sul palcoscenico prendono farmaci specifici e necessitano di essere seguiti da vicino». Ma questo di certo non spaventa D’Ambrosi, che riconosce come anche il pubblico nel tempo sia cambiato: «All’inizio, solo a sentir parlare di Teatro patologico si spaventava… Il nostro lavoro è servito anche a questo, a far diminuire lo stigma sociale nei confronti della malattia mentale e a far avvicinare le persone alla disabilità psichica. Certo, c’è ancora molta strada da fare, ma qualche barriera abbiamo contribuito anche noi a buttarla giù».
Molto utile in tal senso è stata anche l’esperienza cinematografica vissuta dalla compagnia. «Nel 2024 – ricorda ancora il fondatore della compagnia – abbiamo debuttato sul grande schermo con il film Io sono un po’ matto e tu?, collaborando con attori di fama come Claudio Santamaria, Edoardo Leo, Raoul Bova, Claudia Gerini, Vinicio Marchioni, che erano affiancati da trenta ragazzi con disabilità. Dopo il successo al Torino Film Festival, il film è volato a Hollywood per il LA-Italia Festival, portando il messaggio del Teatro Patologico anche oltre i confini nazionali».
Mentre lasciamo la sede della compagnia, ci arriva l’eco delle prove. Un’attrice con sindrome di Down è in difficoltà nella sua parte, ma il regista la incoraggia: «Bastano poche parole, purché siano incisive, piene di senso». Un monito che sembra racchiudere l’essenza stessa del Teatro Patologico. Eppure, nonostante il prestigio internazionale e l’impatto dimostrato, la compagnia non gode di finanziamenti pubblici significativi ed è sempre in bilico per la sostenibilità. Ma Dario D’Ambrosi non si arrende. Sorretto dalle famiglie dei suoi attori, dalla fiducia di studiosi e medici, e grazie all’incoraggiamento di figure come papa Francesco, continua con determinazione a portare avanti la sua missione: dimostrare che il teatro non è solo espressione artistica, ma anche cura dell’anima. In questo senso, il prossimo giugno, nella sede dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, a New York, potrebbe compiersi un passo storico: il riconoscimento ufficiale della teatroterapia come cura per i disturbi psichiatrici. «Certo, il teatro non può sostituire gli psicofarmaci – conclude D’Ambrosi –, ma può davvero rappresentare una terapia significativa per i malati psichici». E forse, chissà, i tempi sono maturi perché il mondo dei cosiddetti «normali» lo ascolti.
Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!