Il triste caso dell’omelia
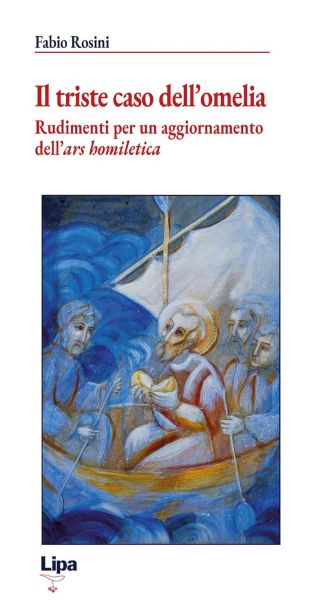
L’arte della predicazione non è qualcosa che si possa improvvisare. L’omelia è parte del ministero dei presbiteri, ma spesso manca di incisività, soprattutto perché non coglie il suo vero scopo. Don Fabio Rosini, prete romano noto per il percorso delle Dieci Parole e docente di comunicazione e trasmissione della fede alla Pontificia Università della Santa Croce, offre una traccia utile per riflettere su questo tema. Partendo da quanto già delineato dal magistero della Chiesa, mette anzitutto in luce che «il fine principale dell’omelia è il sacramento dell’eucaristia», il centro è la celebrazione del mistero pasquale, non la spiegazione di temi contingenti: le Scritture vanno lette alla luce del Cristo Risorto, come nel brano dei discepoli di Emmaus.
Nello sviluppo del testo, l’autore delinea le origini dell’omelia. Da un punto di vista etimologico, la parola viene da un verbo greco che significa intrattenersi, creare intimità: questo richiede una modalità comunicativa relazionale più che razionale, in continuità con l’ambiente in cui la Scrittura è nata, nel quale prevale una logica non concettuale ma integrale, non etica ma radicale. Il rischio è spesso la deriva moralistica o quella gnostica: basare la predicazione sul dovere o sul conoscere, senza mettere realmente in relazione con le opere che Dio compie, «quello che Dio può fare con te, non quello che devi fare tu». Il passaggio fondamentale al quale la liturgia invita – e quindi anche l’omelia che ne è parte – è quello dalla legge alla grazia, dalla condanna alla salvezza, dall’autoreferenzialità al lasciarsi salvare. Nel comunicare questo, la predicazione non può essere tanto assertiva, quanto piuttosto addestrativa, cioè rivolta alla pratica, capace di mostrare com’è possibile vivere ciò che viene annunciato.
Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!










