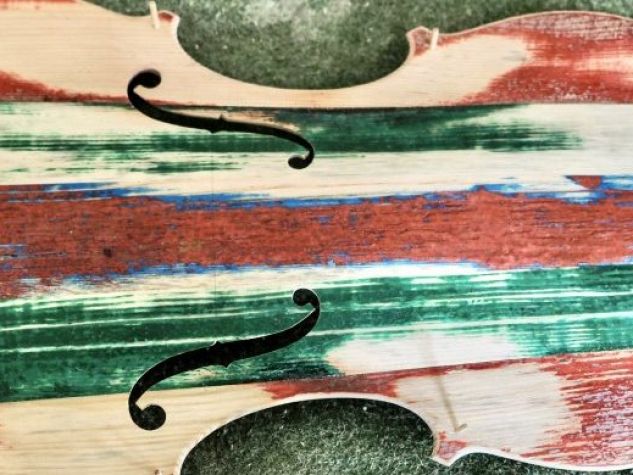La fisica di Cristina
A volte le manca un po’ la «sua» Padova. Ma per il diritto questo e altro. Da due anni Lucia è iscritta all’Università di Bologna, indirizzo: giurisprudenza. Nel capoluogo emiliano condivide un appartamento con altre due ragazze, frequenta il più possibile le lezioni e torna a casa da mamma e papà almeno un paio di volte al mese. Niente di straordinario, insomma. Lucia è una studentessa universitaria «fuori sede» come migliaia di altre in Italia. Qualche secolo fa, tuttavia, una ragazza veneta più giovane di lei, destò non poco scalpore per la sua stessa scelta di studiare all’università, e per lo più lontano da casa. Si chiamava Cristina Roccati questa pioniera, proveniente da una nobile famiglia di Rovigo, che si guadagnò il titolo di «prima studente donna fuori sede della storia» (oltre a quello di terza donna a laurearsi in Europa, dopo Elena Lucrezia Cornaro Piscopia e Laura Bassi). È dedicata proprio a questa virgo rodigina vissuta nel XVIII secolo la mostra «Cristina Roccati. La donna che osò studiare fisica», a Rovigo, fino al 29 giugno, da un’idea di Sergio Campagnolo.
Curata da Elena Canadelli, professore associato in Storia della Scienza all’Università di Padova (Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità), l’esposizione si sviluppa tra il piano terra e il secondo piano di Palazzo Roncale alla scoperta di un personaggio troppo a lungo dimenticato. Colpa di un ambiente – quello accademico e scientifico dell’epoca – prevalentemente maschile e molto chiuso nei confronti delle donne (solo a metà ’800 le cose inizieranno lentamente a cambiare). A maggior ragione, dunque, merita di essere ricordata Cristina Roccati. Lei che nel 1747, 15enne, raggiunge Bologna accompagnata dalla zia e dal precettore per seguire personalmente le lezioni, partecipare alle osservazioni di astronomia e agli esperimenti di fisica. Forte di un’istruzione impartitale fin da piccola (suo padre Giovan Battista le aveva comprato una biblioteca fornitissima di testi classici e scientifici in latino, italiano e francese), nel capoluogo emiliano la giovane studia con successo discipline come la logica, la filosofia, la geometria, la matematica, la meteorologia e l’astronomia, oltre all’amata fisica. Si laurea il 5 maggio 1751 a soli 18 anni. Ad accompagnarla di fronte al Collegio dei dottori dell’Università di Bologna è, guarda caso, Laura Bassi, fisica, sperimentatrice e, al tempo, l’unica docente donna dell’Università di Bologna. Quando si dice la solidarietà femminile…
La laurea di Cristina assume le dimensioni di un evento pubblico, perché, parafrasando un giornale dell’epoca, porta «nuovo splendore alla Patria, al Bel-Sesso, e alle Madame letterate del nostro secolo». In occasione di questo traguardo, vengono composti sonetti e poesie. Alla giovane viene dedicato pure un ritratto (una piccola incisione di Lorenzo Capponi, conservata all’Accademia dei Concordi di Rovigo), l’unico in effetti giunto sino a noi. Si tratta, però, di un’opera di qualità minore, che molto probabilmente non rende giustizia al vero volto della nostra pioniera.
Viene da chiedersi, dunque, che aspetto avesse davvero Cristina Roccati.
Per rispondere a questa domanda, gli organizzatori della mostra rodigina hanno coinvolto l’artista contemporaneo Matteo Massagrande che, pur tenendo presente la stampa d’epoca, ha dovuto compiere un vero e proprio viaggio nel tempo. «A mia moglie venne in mente una frase del grande poeta Kahlil Gibran che dice: “Il ricordo è un modo d’incontrarsi”. Dovevo avere dei ricordi di lei (Cristina) per incontrarla, per poterla ritrarre, quindi è iniziata una minuziosa ricerca – ha spiegato l’artista –. Leggi-leggi, scava-scava, in un pomeriggio pieno di attese abbiamo trovato l’unica descrizione fisica della sua persona in una biografia scritta da (Vincenzo) De Vit: “Fu Cristina Roccati piccola di statura, di capelli castagni, di occhio nero e di viso piacente anzi che no. Era poi dotata di molta vivacità e di somma leggiadria nel porgere da destarne sovente al primo aspetto l’ammirazione”». Il dipinto nato da questa ricerca è ora esposto al piano terra di Palazzo Roncale: una graziosa giovane donna dagli occhi a mandorla che osserva piazza Vittorio Emanuele II attraverso un vetro e, di tanto in tanto, incrocia lo sguardo dei passanti, invogliandoli a varcare l’ingresso della mostra.
Studio e sperimentazione
Dopo aver incontrato Cristina «olio su tavola», saliamo le scale per conoscere anche il suo mondo. Un mondo fatto prima di tutto di libri. Quei testi di Aristotele, Cicerone, Dante, Boccaccio – solo per citarne alcuni – su cui fin da piccola passa le giornate. Volumi che fanno parte della biblioteca della ragazza insieme a testi scientifici, come le Lezioni di fisica sperimentale di Jean Antoine Nollet (di cui è esposta una copia del 1746) e il Trattato sulla formazione de’ fulmini (1747) di Scipione Maffei, le Instituzioni analitiche ad uso della gioventù italiana di Maria Gaetana Agnesi (1748, uno dei primi manuali completi di matematica scritti in italiano) e gli Elementi di geometria di Euclide. Tra una Dama che legge un libro (incisione di Bernard Picard datata 1716, per il frontespizio dell’opera di Richard Steele Bibliotheque de dames) e una raccolta di Rime di donne illustri (Luisa Bergalli, 1773), incontriamo lungo il percorso molti strumenti scientifici in uso nei gabinetti sperimentali dell’epoca, su tutti quello di Giovanni Poleni a Padova, frequentato anche dalla nostra «egregia ed erudita donzella» (per dirla con le parole di Dafneristo Pastor Arcade, autore nel 1750 di un Sonetto a stampa in onore di Cristina Roccati), che proprio a Padova si trasferisce dopo la laurea per approfondire le teorie newtoniane.
Se la lanterna magica in mostra permetteva di proiettare un’immagine ingrandita, la leva a squadra consentiva di sperimentare l’equilibrio dei momenti statici, mentre la pompa pneumatica portatile consentiva di produrre il vuoto e studiarne la natura. La visita prosegue davanti a uno strano tavolo di legno sopra cui pendono otto sfere legate a una specie di «impalcatura». Stiamo ammirando la replica (Gianni Miglietta, 2007) di un apparecchio per studiare gli urti elastici e anaelastici illustrato dall’abate Nollet nelle sue Lezioni di fisica sperimentale. Nel periodo in cui la neolaureata Cristina frequenta l’élite degli scienziati padovani, la moda delle dimostrazioni sperimentali di fisica e degli spettacoli di elettricità ha ormai conquistato corti e salotti.
Quando la Roccati, nel 1751, torna a Rovigo, trova ad attenderla una cattedra di fisica all’Accademia dei Concordi, impegno che la docente porterà avanti fino al 1777. È dedicata proprio a quegli anni da professoressa la sezione successiva della mostra. Nelle sue lezioni, pubbliche e aperte a tutti, Cristina tratta di meccanica, statica, ottica, magnetismo, materia, gravità, elettricità… Alle fitte pagine di testo scritto la studiosa abbina diagrammi e disegni con l’obiettivo di illustrare esperimenti virtuali o dimostrazioni geometriche. Perché, in fondo, la fisica fa parte della vita quotidiana e, dunque, quale modo migliore per spiegarla se non applicandola alla realtà che ci circonda? «Vogliamo noi sapere, onde traggano la loro origine, i venti, i fuochi sotterranei, i tremuoti? La Fisica ce lo discuopre – scrive Cristina Roccati nella sua prima lezione del 15 novembre 1751 –. Come i vapori, le esalazioni, la ruggiuda, la pioggia, la grandine, la folgore, ed infinite altre cose finalmente si formino? La fisica ce lo insegna? E queste cose tutte non ecciteranno in noi piacere e diletto? E se queste ne piacciono ed estremamente dilettano, la fisica che ne le discuopre, e chiaramente ne le mostra, non sarà ella gioconda e dilettevole?».
Posto che l’insegnante migliore è colui che sa trasmettere, oltre alle nozioni, anche la motivazione nei propri alunni, c’è da credere che Cristina Roccati sia stata davvero una grande professoressa. Non c’è da stupirsi allora se, di recente, l’Agenzia Spaziale Europea – su proposta del team italiano guidato da Roberto Ragazzoni dell’Osservatorio Astronomico di Padova, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica di Catania e Milano – ha deciso di rendere omaggio alla scienziata rodigina ricordandola nel progetto PLATO (Planetary Transits and Oscillations of stars, ovvero una missione finalizzata a trovare nuovi pianeti extrasolari simili alla Terra). Si chiamerà proprio Cristina Roccati uno dei 26 telescopi che, a fine 2026, saranno lanciati in orbita a bordo di un satellite. In attesa di quel momento, Palazzo Roncale ospita sotto una volta stellata il modello stampato in 3D dall’INAF-Osservatorio Astronomico di Padova. Chissà che la nostra pioniera, oltre all’entusiasmo, non porti anche fortuna alla missione...
Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!