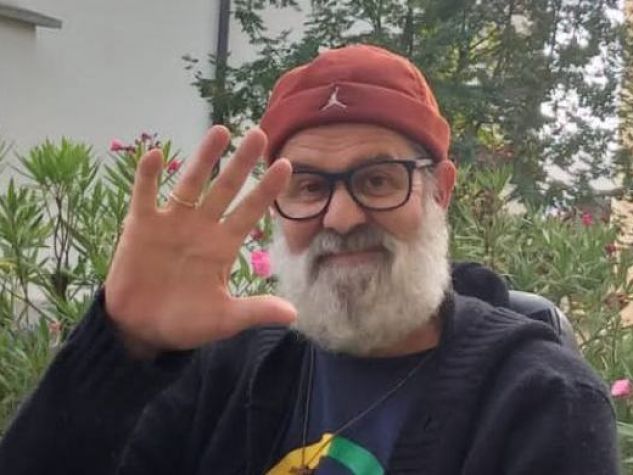L’amore immaginato
Uno psicoterapeuta di New York alle soglie della pensione, Jack Mickler (interpretato da Marlon Brando), convince John De Marco (Johnny Depp) a non gettarsi da un parapetto e si offre di prenderlo in cura personalmente, contro il parere dell’équipe. Il malato è un bel giovane vestito da moschettiere con maschera nera e spada. Rifiuta i farmaci e sostiene di essere Don Juan, Don Giovanni, il più grande amatore del mondo sia per il numero che per l’intensità delle sue relazioni sessuali. I deliri a sfondo romantico ed erotico, che John recita, affascinano l’obeso psicologo, il quale sta vivendo una relazione coniugale ripetitiva e anemica con la moglie Marilyn (Faye Dunaway). Nonostante i sospetti reciproci, l’alleanza tra i due tiene e incide nei vissuti di Jack. Il film si chiude davanti a una corte di tribunale, che deve stabilire la capacità mentale di John, e poi nel mezzo di un’isola solare e paradisiaca, che i tre protagonisti visiteranno.
Lo psichiatra del film Don Juan De Marco - Maestro d’amore (USA 1995) di Jeremy Leven invidia l’immaginazione sfrenata del proprio cliente, come capitava al dottor Dysart nel film di Sidney Lumet Equus (1977), con Richard Burton. Ne ricaviamo una lezione etica. Una cosa è spiegare biochimicamente i sintomi psichiatrici, un’altra cosa è cercare di comprenderne il senso. Il racconto allucinato di John e il suo folle tentativo di suicidio («non potevo più vivere dopo essere stato abbandonato dall’unica donna, su migliaia, che ho veramente amato») esprimono non solo un vissuto doloroso, ma anche un innato desiderio di narrare, che funge sia da arte della seduzione sia da metodo di ricerca esistenziale: che cosa ho perduto attraversando innumerevoli e mirabolanti avventure?
Ho presentato recentemente questo film alla Fondazione svizzera Sir John Eccles. Eccles (1903-1997), medico e premio Nobel per la fisiologia nel 1963, rifiutava sia il dualismo cartesiano che le concezioni materialistiche della persona umana. L’emergenza della coscienza negli animali e nell’uomo non poteva essere spiegata, secondo lui, sulla base di cause fisico-biologiche. L’io impara dalle sue esperienze nel mondo ed è il responsabile del suo stile morale. L’io, che è coscienza originale e libera, si sorprende del proprio svegliarsi, di ciò che contempla, di ciò che inventa. L’essere umano trova in queste esperienze originarie persino un indizio d’immortalità. La mente cosciente agisce sul cervello, lo prepara a funzionare nelle situazioni vitali e a perseguire intenzioni degne. Eccles, prima di morire a Locarno nel 1977, instaurò un’amicizia fruttuosa con Karl Popper. Assieme scrissero il libro L’io e il suo cervello. Se Eccles avesse visto questo film, si sarebbe divertito, credo, dello staff psichiatrico e della goffa obbedienza alle procedure farmacologiche. Eccles avrebbe cercato di comprendere il significato culturale del florido delirio di Don Juan.
Il film di Leven è un ibrido: a scene realistiche ne seguono altre decisamente oniriche e altre comiche. Inquadrature ordinarie lasciano il posto a sequenze melodrammatiche, coloratissime, sature di passione. Le interazioni tra i personaggi sono intrise di ammiccamenti ironici, il che evita la caduta in un lessico pubblicitario e in un inverosimile ottimismo da fotoromanzo. È un film sul racconto e, in particolare, sulla capacità di curare (sé e gli altri) raccontando. La narrazione ha, infatti, una potenza trasformatrice che fu attestata dal fondatore della psicoanalisi. Sigmund Freud (1856-1939) sosteneva che, quando lo scavo «archeologico» nel passato non dà risultati e non si riesce a disseppellire il trauma subìto dal paziente, una «costruzione» convincente e ben «indovinata» da parte dello psicoanalista può avere la stessa efficacia del ricordo recuperato. Freud riteneva che queste intuizioni narrative, che vengono poi comunicate in seduta, fossero semplici ipotesi in attesa di verifica e gli sembravano equivalenti alle idee deliranti che perseguitano i soggetti psicotici. Eppure non potevano essere solo inganni. Nelle allucinazioni – scriveva Freud – ritorna qualcosa che è stato vissuto in tempi remoti da un bambino che non sapeva ancora parlare. La follia contiene, quindi, un pezzo di realtà storica, che riemerge grazie al distacco patologico dal mondo reale e alla spinta a soddisfare il desiderio. Per questi motivi, se si ottiene dal malato un sicuro convincimento circa l’esattezza della «costruzione», quest’ultima ha lo stesso effetto curativo di un ricordo recuperato (il testo di Freud è del 1937 e s’intitola Costruzioni nell’analisi).
Notissimo è il Don Giovanni musicato da Mozart nel 1787 su libretto di Lorenzo da Ponte (1749-1838). Ma è dal poema incompiuto di George Byron (1819-1824), Don Juan, che il paziente del film trae le sue visioni (si vede il volume in alcune sequenze). Byron definì la propria opera «epica e satirica»: erano le gesta di un eroe e assieme l’irriverente scherzo di un moralista. Nella pellicola, il dottor Mickler (Brando lo interpreta magnificamente) accetta la sfida d’immergersi nel mondo di Don Juan De Marco, un mondo in parte letterario e in parte onirico, facendosi passare per il Don Octavio del dramma. Sarà a suo rischio e pericolo! La letteratura (cinema compreso) instilla imprevisti germi di cambiamento nelle minestre riscaldate degli spettatori borghesi, che hanno timore di sognare a occhi aperti.
Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!