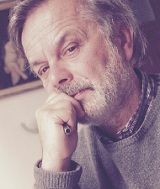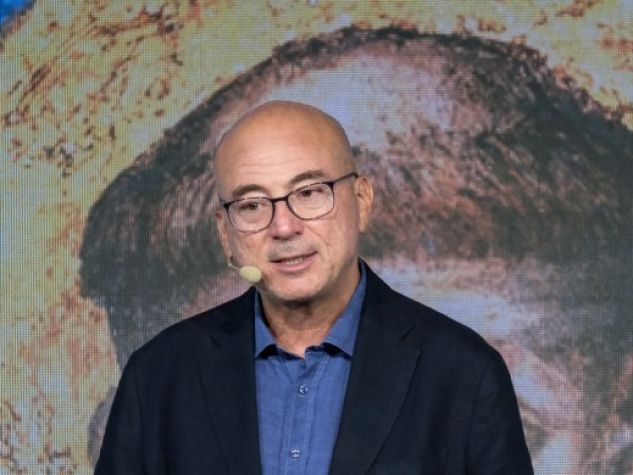Mille anni di campane

Alessandro, barbiere nel corso di Agnone, paese di cinquemila abitanti dell’Alto Molise, raccoglie, con la scopa e con attenzione, i miei capelli appena tagliati. E mi spiega: «Finiranno impastati con l’argilla, nel processo di fabbricazione delle campane». Lo guardo con qualche stupore. Ci devo credere? Mi piace l’idea che i miei capelli possano, in qualche modo, essere utilizzati da una delle più antiche fonderie di campane al mondo. Mi piace l’idea che possano ascoltare i concerti dall’alto di un campanile.
Di fronte all’albero genealogico della famiglia Marinelli non ho dubbi sulla storia di questa infinita famiglia di fonditori. La firma di un loro capostipite, Nicodemo, campanarus, appare su una campana di due quintali fabbricata ad Agnone nel 1339 e destinata a una chiesa del frusinate. Sono ventisette le generazioni dei Marinelli che, in settecento anni di storia, si sono succedute nell’arte e nel mestiere di costruttori di campane. Una storia unica tra le famiglie di imprenditori. È certo che in questo paese delle solitarie montagne molisane già si fabbricassero almeno fin dall’anno Mille. Armando Marinelli, erede, assieme al fratello Pasquale, di quel Nicodemo, mi racconta: «I Marinelli arrivarono in queste montagne lontane dal mare dalle Venezie. Qui vi era già una tradizione di campanari». Nel museo che la famiglia ha creato accanto alla fonderia è conservata una campana «gotica» fusa ad Agnone probabilmente attorno all’anno Mille. La fonderia Marinelli è l’unica rimasta fino ai nostri anni. E gode una buona, antica salute. E di una magnifica reputazione nel mondo.
In questa terra, tra Molise, Abruzzo e Campania, la regione del Sannio, la leggenda delle campane è diventata storia. Una tavoletta in bronzo, risalente al III secolo avanti Cristo, è considerata la prova delle capacità metallurgiche dei Sanniti: a metà dell’800, l’aratro di un contadino, al confine tra Agnone e Capracotta, la riportò alla luce e servì per decrittare l’alfabeto della lingua di quel popolo. Vogliamo tutti credere che fu san Paolino, vescovo di Nola nel V secolo, a introdurre nella liturgia cristiana il suono delle campane. Nacquero allora numerose fonderie per produrre i «Vasa campana», i vasi in bronzo della Campania. Attorno all’anno Mille, la costruzione di chiese e cattedrali accelerò e i fonditori di campane divennero artigiani ricercati. Erano itineranti: non era possibile trasportare le grandi campane sulle strade impercorribili dell’alto Medioevo, i fonditori andavano a vivere e lavorare nelle terre delle comunità che volevano che le loro giornate fossero scandite dai rintocchi di questo nuovo meccanismo. I Marinelli non lasciarono Agnone, ma con le maestranze si trasferivano per mesi e mesi, a volte per anni, vicino ai campanili sui quali dovevano issare le loro campane. Spesso viaggiavano assieme ai pastori transumanti lungo i tratturi della loro regione.
Armando Marinelli e suo fratello Pasquale, nati negli anni ’60 del secolo scorso, sono la prima generazione di fonditori campanari che non ha avuto bisogno di ricreare i forni di fusione lontano da Agnone. «E lo dico con rammarico – ha sempre spiegato Armando –. Perché deve essere stata un’avventura incredibile». Sì, deve essere stata un’epopea: per costruire, nel 1923, le otto campane del campanile del Santuario di Pompei, i Marinelli, i suoi fonditori, e l’inseparabile Felice D’Onofrio, uno dei più grandi artisti dei bassorilievi in bronzo, si trasferirono per ben sei anni nella città campana e vi allestirono una fonderia semi-permanente. Il bronzo di queste campane proveniva in parte dalla fusione dei cannoni della prima guerra mondiale. Papa Pio XI, per questa impresa, per la bellezza di queste campane e per la perfezione del loro suono, concesse alla fonderia di Agnone la possibilità di usare lo stemma pontificio.
Nel 1943 i nazisti occuparono il paese molisano, chiusero la fonderia, ne fecero un loro quartiere generale; durante la guerra i militari si erano già impossessati di migliaia di campane, fusero 7500 tonnellate di bronzo per farne artiglieria pesante. Fu una tempesta, i Marinelli riaprirono la fabbrica nel 1950, riuscirono a recuperare 1500 tonnellate di bronzo e oltre 800 campane. Si racconta che l’80% delle campane che suonano nel Sud d’Italia siano opera dei Marinelli. Infinita la geografia delle loro fusioni: i fonditori di Agnone hanno fabbricato le campane del santuario di Lourdes per il centenario dell’apparizione di Maria e quella che rintoccò per il Concilio Vaticano II; la campana della Perestrojka per ricordare lo storico incontro del 1989 tra papa Giovanni Paolo II e Michail Gorbaciov; le campane del Giubileo del 2000 e quella dell’attuale Anno Santo. Campane Marinelli suonano a San Pietro e nel Duomo di Milano.
Una devozione mariana ha ispirato i fonditori molisani: le loro campane sono a Medjugorie, ad Aparecida in Brasile, a Fatima. Dopo la guerra, i Marinelli furono incaricati di fondere la campana della rinascita della Abbazia di Montecassino. Si ascoltano le note delle campane di Agnone a Firenze, a Recanati, in Val di Fassa e a Santa Maria di Leuca. Rintoccano in Nicaragua, a Osaka, in Macedonia e in Eritrea. Giovanni Paolo II, nel 1995, venne in fonderia per benedire la colata di una nuova campana. I fratelli Marinelli hanno donato a papa Francesco la campana del Giubileo 2025. E hanno già mostrato a papa Leone XIV il modello di una campana a lui dedicata e la statua del suo busto, opera di Ettore Marinelli, ultimo erede della dinastia. Ci sono anche campane «laiche», fuse nei decenni: per onorare John Fitzgerald Kennedy e Diego Armando Maradona, Rudol’f Nureev e la vittoria italiana ai mondiali di calcio del 1982.
Devo credere ad Armando quando mi dice che questa fonderia potrebbe fabbricare una campana «anche senza elettricità»? Credo che sia vero, credo che seguano ancora le regole che Tommaso Marinelli, nel 1888, racchiuse in un prezioso manuale. Attraverso due stanze ricolme di calchi in gesso, entro in bottega, come i Marinelli chiamano lo stanzone, annerito dai decenni, dei forni fusori. Non c’è un solo computer, c’è la polvere, la sabbia, il nero del carbone, intrecci di catene, campane pronte per essere suonate, colpi metallici, rimbombi. La bottega si illumina di una luce spaziale e accecante al momento delle fusioni. Fabbricazione complessa, lunghissima, a fasi ben distinte: l’antica tecnica della cera persa, mattoni per costruire «l’anima», la «falsa campana», l’argilla per il «mantello», e la colata finale del bronzo fuso, le temperature che salgono a 1150 gradi. Il bronzo è una lega di rame (75%) e stagno (25%) che possiede il più alto numero di frequenze e ha straordinarie capacità vibranti. Per costruire una grande campana occorrono almeno tre mesi. I committenti devono abituarsi alla lentezza.
Tonino Delli Quadri, 88 anni, magister campanaro, cominciò a lavorare nella fonderia a 17 anni. Suo nonno e suo padre lo avevano preceduto. Fonditori di campane dalla fine dell’800. Tonino frequentò per due anni la scuola industriale, poi entrò al lavoro nella bottega. Una foto lo mostra, negli anni ’70, in equilibrio sul cornicione di un campanile mentre smonta una campana di due quintali. Se Tommaso Marinelli aveva già scritto che un maestro fonditore deve possedere «qualche elemento» di «aritmetica, geometria, disegno… senza trascurare i principi della musica», Tonino oggi mi parla, con sapienza, dei sol gravi e dei mi, cerca di spiegarmi i segreti del rapporto tra peso e note musicali, mi dice della necessità di coprire «tutti gli 88 tasti, bianchi e neri, del pianoforte». Appoggia un diapason sulla superficie di una campana e ascolta. Impercettibile il suo segno di assenso. Suona per noi visitatori una piccola melodia e so che ha suonato al concerto di trentatré campane della «sua» fonderia all’avvio di questo Anno Santo. Un fonditore deve davvero sapere di matematica e musica, fisica e metallurgia.
Il momento della fusione. Di una piccola statua. Divampa il rosso che si incendia in un bianco purissimo. Metallo fuso. I Marinelli si riuniscono, i due fratelli ed Ettore, il figlio scultore di Armando. Afferrano delle aste di ferro, delle tenaglie. Maneggiano il fuoco. Lo scolpiscono. Creano forme e storie. È una magia, una forza. Se fosse una campana, un sacerdote sarebbe qui a benedire. Oggi si sta creando una piccolo oggetto: i tre Marinelli, le due generazioni contemporanee, invocano il nome di Maria. Santa Maria. La fonderia diventa una chiesa, la parola dona il sacro al bronzo fuso.
Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!