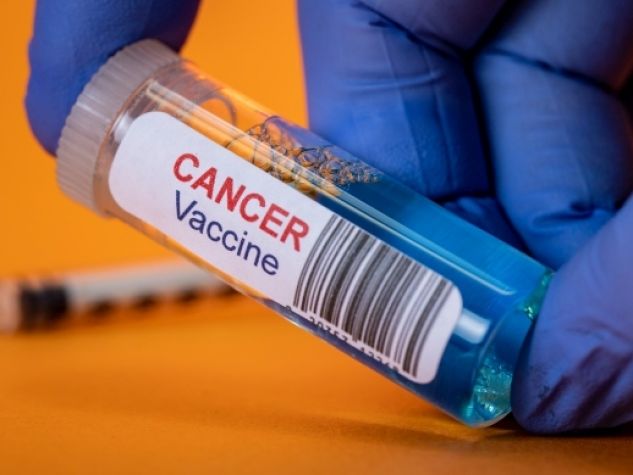Quando la luce inquina
«Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato...», recita il Salmo 8. Ma, oggi, ammirare il cielo notturno e scrutare le stelle dalle nostre latitudini è diventato sempre più difficile, perché – soprattutto nei nostri Paesi più antropizzati – siamo circondati da una cortina di luce. Artificiale. Secondo i dati del World atlas of artificial night sky brightness (l’Atlante mondiale dell’inquinamento luminoso, ndr), più dell’80% della popolazione mondiale vive in aree dove l’inquinamento luminoso è rilevante e soprattutto evidente. «Gli Stati Uniti e l’Europa vanno ancora peggio – aggiungono i ricercatori –, con il 99% degli abitanti che fanno esperienza di un cielo luminoso alla notte. Il genere umano ha avvolto il pianeta in una nuvola di luce che impedisce a gran parte della popolazione della Terra di osservare la nostra galassia. E questo ha un impatto potenziale sulla cultura di proporzioni mai sperimentate prima».
«Ai ritmi attuali, l’inquinamento luminoso raddoppia ogni dieci anni», segnala l’avvocato Mario Di Sora, direttore dell’Osservatorio astronomico di Campo Catino (Frosinone) e responsabile per l’Italia dell’International Dark Sky Association, l’organizzazione che intende tutelare il cielo notturno: secondo i dati dei ricercatori statunitensi, e le osservazioni della Nasa, l’area naturalmente buia si sta riducendo e dal 2011 al 2022 la notte è diventata mediamente più luminosa del 9,6%, il che equivale a raddoppiare la luminosità del cielo ancor più velocemente, addirittura ogni otto anni. Il passaggio alla tecnologia led, che consente risparmio energetico e in parallelo esalta la brillantezza e l’intensità della luce, ha accelerato il fenomeno. Le fotografie scattate dagli astronauti della stazione spaziale mostrano con evidenza questo tappeto di luce artificiale steso sui nostri territori: in Italia, per esempio, tutta la pianura padana (dall’hinterland di Milano fino al Triveneto e all’Emilia-Romagna, compresa la costa adriatica) è lucente nella notte, «perché si tratta di aree particolarmente urbanizzate, con un’elevata concentrazione di attività economiche, industriali e di abitazioni – osserva Di Sora –. Va meglio nelle zone di alta collina e di montagna, dove tuttavia all’orizzonte può essere visibile il bagliore. E anche nel Sud ci sono aree con alto inquinamento luminoso, dovuto all’utilizzo di corpi illuminanti di vecchia generazione, che proiettano luce verso l’alto e di fatto la disperdono».
Il giusto equilibrio
Ovviamente la luce è importante e gran parte della nostra vita sulla Terra è legata alla sua azione. Le piante, per esempio, non potrebbero attuare la fotosintesi clorofilliana se non ci fosse luce: durante questo processo, assorbono molecole di anidride carbonica e acqua e – grazie all’energia luminosa del sole – le trasformano in ossigeno. Per tutti gli esseri viventi la luce è fondamentale per la crescita e il benessere. Nel corpo umano è essenziale per la produzione di vitamina D che contribuisce alla salute delle ossa, inoltre stimola la serotonina (l’ormone della felicità) e regola i ritmi circadiani, ovvero l’alternanza tra il giorno e la notte, cioè il nostro orologio interno. A noi umani serve il giusto equilibrio di luce e di oscurità e, quando questo si spezza, il nostro fisico ne risente, prima di tutto con disturbi del sonno ma anche con altre gravi patologie. «La specie umana non è adatta ad attività notturne. I nostri sensi sono troppo limitati e, in più, il cervello ha bisogno di molte ore di sonno per elaborare impressioni ed eventi – scrive il biologo svedese Johan Eklöf nel suo saggio Elogio del buio (Corbaccio) –. La nostra inclinazione a essere attivi di giorno è comune anche alla maggior parte dei primati, ma per il resto siamo un caso più unico che raro tra i mammiferi. Nel mondo esistono quasi 6mila specie di mammiferi, e quasi tutte preferiscono muoversi all’alba e al tramonto, se non di notte».
Per tante specie viventi il buio è necessario al pari della luce. Gli scienziati, per esempio, ritengono che l’inquinamento luminoso sia responsabile ogni anno della morte di almeno 300 milioni di uccelli negli Stati Uniti: molte specie di volatili, infatti, migrano alla notte, sfruttando le tracce naturali nel cielo notturno per individuare il percorso, ma la luce artificiale li confonde, li disorienta, li rende più vulnerabili ai predatori. E si è calcolato pure che negli ultimi vent’anni in Inghilterra si è perso circa il 60% degli insetti: «Il light pollution, ovvero l’inquinamento luminoso, è stato uno dei fattori determinanti», sostengono i ricercatori. Gli insetti spesso si spostano cercando la luce, e anche le «trappole» che utilizziamo per catturare le zanzare in estate si basano su una fonte luminosa, ma l’eccesso di luce può creare situazioni quasi paradossali: nel 2019, dopo precipitazioni molto abbondanti, milioni di cavallette volarono dal deserto del Nevada verso Las Vegas, attratte dal Luxor Sky Beam, l’imponente, potentissimo fascio di luce (con 39 lampade da 7.000 watt l’una) sparato verso il cielo da un hotel. La città che non dorme mai, capitale del gioco d’azzardo, si trovò così invasa da sciami di insetti. Quasi come una piaga biblica.
Abbagliati da troppa luce
Buio e luce sono anche due simboli, due concetti filosofici. Lo rammenta con efficacia la professoressa Francesca Rigotti nel suo saggio Buio, edito da Il Mulino. «Buio – scrive – è divenuta una parola controtempo», oggi che il buio non c’è più, «scomparso, soppresso, vinto e battuto, divenuto un privilegio per ricchi raffinati che infatti vanno a cercarlo in località remote e incontaminate, mentre altri ricchi immergono in fasci di luce ogni angolo delle loro lussuose dimore». Eppure, aggiunge la filosofa, «il buio è bello, lo sappiamo tutti. Il buio dell’intimità, dell’introspezione, della meditazione. Il buio della calma serale e del riposo notturno. Se la luce alimenta la ragione, il buio abita nelle regioni dell’immaginazione». È pur vero che, soprattutto nella società di oggi, il buio si associa a una sensazione di insicurezza: in molte città non si passeggia volentieri di notte in una via poco illuminata, ed è pericoloso andare in bicicletta di notte, senza precauzioni, luci o giubbotti catarifrangenti, lungo una strada immersa nell’oscurità. «Tuttavia alcuni studi ci hanno fatto notare che la luce non è sempre così importante, perché l’illuminazione ci abbaglia, ci rende ciechi e, probabilmente, meno al sicuro di quanto crediamo – ha rimarcato Johan Eklöf –. È come mettere un cerotto sul ginocchio di un bambino. Magari non gli serve, ma lo fa stare comunque meglio».
A causa della troppa luce, anche gli astronomi faticano a puntare i loro telescopi verso le galassie: «Rischiamo di perdere per sempre il cielo stellato, protagonista indiscusso della letteratura, della musica, delle mitologie e religioni di ogni cultura e di ogni tempo, e con esso la consapevolezza ecologica del nostro ruolo nell’universo», avverte l’astrofisico Roberto Trotta della Sissa (Scuola internazionale di studi avanzati) che proprio di recente ha pubblicato Il cielo stellato sopra di noi. Storia dell’umanità senza gli astri (Il Saggiatore).
Per contrastare l’inquinamento luminoso, già dagli anni scorsi quasi tutte le regioni italiane hanno approvato specifiche leggi che introducono regole da rispettare sia per gli impianti di illuminazione pubblica che per quella privata. Avete mai pensato, per esempio, che un lampione a sfera spreca almeno la metà della luce che emette perché la proietta verso il cielo? Molto meglio avere un punto luce che indirizza le sue emissioni verso il basso, così da rischiarare dove effettivamente serve. Vanno quindi scelti i corpi illuminanti a norma, che devono anche essere montati correttamente, con la giusta inclinazione. Allo stesso modo si raccomanda di illuminare palazzi e monumenti dall’alto verso il basso: ancora oggi, infatti, si vedono edifici con fari che puntano verso l’alto per creare un effetto scenografico che tuttavia produce soltanto luce «inutile». Anche le insegne luminose non devono generare dispersione di luce o disturbo. Torna in mente quanto la famiglia di Marcovaldo, di Italo Calvino, riusciva a vedere dalla sua finestra: «La notte durava venti secondi, e venti secondi il Gnac – si legge nel racconto, pubblicato già nel 1963 –. Per venti secondi si vedeva il cielo azzurro variegato di nuvole nere, la falce della Luna crescente dorata, sottolineata da un impalpabile alone, e poi le stelle che più le si guardava più infittivano la loro pungente piccolezza, fino allo spolverio della Via Lattea. I venti secondi finivano subito e cominciava il Gnac. Il Gnac era una parte della scritta pubblicitaria Spaak-Cognac sul tetto di fronte, che stava venti secondi accesa e venti spenta, e quando era accesa non si vedeva nient’altro. La Luna improvvisamente sbiadiva e il cielo diventava uniformemente nero e piatto, le stelle perdevano il brillio».
Le leggi regionali prevedono anche aree di rispetto attorno agli osservatori astronomici: in alcuni territori si pensa poi a creare delle «riserve» certificate Dark Sky destinate ai «notturisti», cioè a coloro che cercano luoghi dove il cielo è ancora incontaminato. «Le norme esistono, ma spesso non vengono fatte rispettare e quindi il problema permane – annota l’avvocato Di Sora –. Mi piace segnalare il positivo esperimento portato avanti in diversi Comuni della provincia di Frosinone, dove abito, e anche nel Comune di Roma: nella capitale vengono effettuati controlli regolari e ogni anno vengono emesse centinaia di diffide per irregolarità. Accertamenti e sanzioni sono poi a cura della Polizia di Roma Capitale, con il supporto dell’osservatorio di Campo Catino e dell’Arpa Lazio». Un buon esempio è anche quello di Matera: qui lo scorso anno è stato inaugurato un sistema di illuminazione pubblica, alimentato da energia green, che «accarezza» le pietre dei Sassi, concentrandosi verso il basso.
La nostra parte
Ognuno di noi può dare il proprio contributo a ridurre l’inquinamento luminoso. «La regola d’oro dell’illuminazione amica del cielo stellato è questa: “Solo la luce che serve, quando serve” – dicono le associazioni internazionali –. Ogni lampada deve avere uno scopo, e un utilizzo soltanto estetico non è una valida ragione per tenerla accesa». Dunque, vanno evitate le dispersioni di luce, occorre ridurre la loro potenza, si possono installare dei timer per le insegne o dei sensori di movimento per illuminare soltanto al passaggio delle persone. E nella scelta delle lampadine, meglio optare per la luce più calda: «Le luci bianche, fredde e aggressive, che emettono molta luce blu, sono dannose per la salute umana, la fauna selvatica e il cielo notturno», ricorda un articolo di Sky at night magazine, rivista della Bbc.
Soprattutto, pur amando la luce, non bisogna demonizzare il buio. «Sarà molto difficile (ammesso che non sia già impossibile) fermare l’innalzamento delle temperature del pianeta, ripulire l’ambiente dalla plastica e dai veleni, evitare la diffusione di specie invasive, mentre è decisamente più semplice attenuare o spegnere le luci – conclude il biologo Eklöf –. Di tutti i problemi ambientali, l’inquinamento luminoso è il più facile da risolvere, tecnicamente. Se eliminassimo l’illuminazione superflua, gli effetti sarebbero immediati e non lascerebbero residui da smaltire». Fare luce sul problema, e averne consapevolezza, è già un primo passo.
Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!