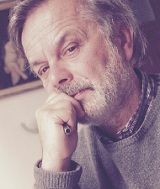Sant’Antioco, nel labirinto del bisso

Sulla scrivania di mio padre, oltre mezzo secolo fa, c’era una lunga conchiglia dai riflessi di madreperla e dai colori rosso pastello. Mi appariva immensa, misteriosa. Bellissima. Era un dono di mio zio a mio padre. Lo zio viveva all’isola d’Elba. Credo che l’avesse pescata lui. Ricordo mia nonna che, quando dormivo a casa sua, e mi doveva preparare il letto, diceva sempre: «Se avessi le lenzuola di bisso…». Mi convinsi che fosse un lusso che non poteva concedersi.
Immagini che riemergono da un’infanzia molto lontana. Sto passeggiando distrattamente per una strada di Sant’Antioco, il paese principale dell’isola-istmo sulla costa meridionale della Sardegna orientale, un’ora e mezza di macchina da Cagliari. Alcuni cartelli, scritti a mano, appesi con il nastro adesivo su una porta a vetri, mi incuriosiscono: «In questa stanza non si vende niente» e «La fretta non abita qui».
Giro la maniglia, entro e mi ritrovo nel locale, «museo», laboratorio, casa, di Chiara Vigo, una donna energica, di 70 anni, che si definisce «maestro» – al maschile – di bisso marino. Vestita di nero, ha lo sguardo accigliato e penetrante, e, soprattutto, con la mano destra impugna la conchiglia di mio padre. Non ne avevo mai rivista una simile. Mi siedo, affascinato, e ascolto, guardo. Non immaginavo di entrare nel ricordo dimenticato di quella fantastica conchiglia dei miei cinque anni e nel desiderio proibito di mia nonna. Non immaginavo di entrare in un labirinto di una storia intricata, quasi un racconto poliziesco, a volte surreale, attorcigliato come un ciuffetto dorato di bisso.
Quella «conchiglia», apparsa brevemente e subito scomparsa nella mia vita, apparteneva a un esemplare del più grande bivalve del Mediterraneo. Il solo mare dove lo si può trovare. Può superare il metro di lunghezza, vive sul fondo sabbioso del mare, conficcato in verticale, ancorato al fondale da una sorta di radice, formata da cheratina, sottilissima e resistente. Un intreccio di filamenti fibrosi, anzi, una barba di migliaia di piccoli fili, che, spesso avvinghiati alla posidonia, impediscono alle maree, alle onde, alle correnti di trascinare via la conchiglia e il suo abitante, un mollusco che può pesare anche un chilo. In italiano si chiama nacchera. Venne classificata, nel 1785, nel sistema linneano, come Pinna nobilis.
La nacchera è stata pescata per secoli per cibarsi del suo mollusco, per le piccole perle che è capace di produrre, per fabbricare oggetti di decoro (tessere di mosaico, bottoni…). E per «tagliare» quei fili così particolari che fuoriescono dalla sua «coda» e che sono conosciuti, al pari di quelli delle comuni cozze, come bisso. Chi fu il primo a capire che quei filamenti, incrostati di conchigliette, sabbia, pietruzze e frammenti di alghe marcite, potevano diventare la seta del Mediterraneo prima ancora che arrivasse dalla Cina? Le fonti si fanno confuse, terreno incerto, davvero non mi aspettavo di addentrarmi in un labirinto storico. Nella Bibbia, leggo, il bisso viene citato oltre quaranta volte. È un tessuto amato e preteso da sovrani e imperatori, storici o leggendari, realmente esistiti o frutto di fantasie. Conosciuto dai faraoni, commerciato da fenici e caldei. Leggo ancora: il più antico frammento tornato alla luce di bisso marino risale al IV secolo dopo Cristo. Un racconto favoloso narra che a Sant’Antioco la lavorazione del bisso sia stata fatta conoscere da una principessa mediorientale, Berenice di Cilicia, costretta all’esilio sull’isola dall’imperatore Tito, di cui era stata amante.
Il gioco degli equivoci attorno al bisso è colpa dell’ambiguità del suo nome. In fondo vi era caduta anche mia nonna. Leggo in internet una dotta ricostruzione linguistica compilata da Felicitas Maeder, 79 anni, una studiosa svizzera che da trent’anni si occupa di bisso: il termine deriverebbe da bus, parola ebraica che significa «lino fine». Ecco, cosa intendeva mia nonna: le leggere, fresche lenzuola di lino. Per i secoli dell’antichità i fili del bisso ottenuti dalla Pinna nobilis si sono confusi con il tessuto di lino. Solo nel 1555, il naturalista francese Guillaume Rondelet chiarisce che esiste un bisso marino e un bisso terrestre.
Nel frattempo, attorno al 550, trafugati dalla Cina, sono arrivati in Europa i primi bachi da seta, il nuovo, vero tessuto del lusso. La nuova industria tessile impiega secoli per affinarsi e affermarsi, ma è una vera rivoluzione. Solo nel XII secolo, in Sicilia, si comincia a coltivare il gelso, le cui foglie sono il cibo prediletto dei bachi: l’Italia diventa il più importante produttore di seta. La lavorazione del bisso marino, troppo complessa e ridotta, lentamente declina. In Italia, a fine ‘700, a leggere un naturalista tedesco, Johann Chemnitz, sopravvivono botteghe a Napoli, a Messina, in Sicilia. Ma Felicitas Maeder sostiene che non esistono testimonianze reali di una produzione siciliana. Come se il bisso, misteriosa fibra usata per ricami, si divertisse a ingannare chi ne vuole raccontare la storia. Quel che è certo è che solo a Taranto e in Sardegna si trovano, ancora nel ‘900, artigiane testarde, capaci di lavorare il bisso.
Nel 1914, un grande fotografo fiorentino, Vittorio Alinari, sbarca in Sardegna con le sue ingombranti macchine fotografiche e, a Sant’Antioco, viene colpito dalla lavorazione dei filamenti setacei prodotti da quella grande conchiglia. Scrive: «Ripulita, filata e tessuta… ne deriva una stoffa di un bel colore metallico, che si avvicina al rame, con la quale si confezionano delle sottovesti che, guernite di bottoni in filigrana d’oro…producono un bellissimo effetto». Per ogni sottoveste, precisa Alinari, occorrono almeno «900 code». Questo giustifica il prezzo molto alto. Le sue fotografie delle filatrici al lavoro sono splendide. Sull’isola, Alinari conosce un bravissimo artigiano, appassionato fin da bambino della lavorazione del bisso: si chiama Italo Diana, grande suonatore delle launeddas, straordinario strumento a fiato sardo.
Nel 1923 Italo Diana aprì una scuola di tessitura destinata a diventare celebre: è considerato il maestro di tutte le donne che, nel corso del ‘900, hanno tessuto la impalpabile «seta di mare». Le sue allieve si chiamano, tra le altre, Assunta Cabras, Emanuela Vacca, Jolanda Sitzia, Leonilde Mereu, Raffaela Schiru, Raffaela Lusci. Nomi riveriti sull’isola. «L’ultima a frequentare la scuola» fu Efisia Murroni, morta centenaria nel 2013: ho letto che confezionò in bisso una tunica per una statua di san Francesco ad Assisi.
Nel 1992, la Pinna Nobilis, decimata da una pesca eccessiva, viene dichiarata specie in via di estinzione. Da allora ne è proibita la raccolta. Le artigiane che ancora filano il bisso sostengono di utilizzare piccoli depositi di filamenti risalenti alla prima metà del secolo scorso, eredità di vecchie tessitrici, delle nonne, se non delle riserve dello stesso Italo Diana.
Posso interrompere qui questa lunga storia? Ho ritrovato e messo a fuoco due ricordi di bambino e sono uscito incuriosito e contento dal laboratorio di Chiara Vigo. Lei si definisce «l’ultimo maestro» dell’arte di lavorare il bisso. Ha riconoscimenti, targhe, libri, una importante rassegna di articoli a lei dedicata, fama internazionale. I giornalisti ne hanno scritto molto. Nel 2008, il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, le ha conferito l’onorificenza di «commendatore». Chiara è nipote di Leonilde Mereu, una delle allieve di Italo Diana. La nonna le ha passato i segreti della lavorazione del bisso. Lei racconta che, prima di rivelarglieli, le impose il Giuramento dell’Acqua. Le insegnò le preghiere da mormorare al vento ogni giorno. Ho ascoltato Chiara intonare un canto «sciamanico» mentre lavora un invisibile ciuffetto di bisso.
A sera ho cominciato a chiedere informazioni agli amici dell’isola. Mi hanno prestato un elegante libro su Chiara. Poi ho cominciato a leggere decine e decine di pagine sul web attorno al bisso. Così, ho saputo dell’esistenza delle sorelle Pes, Assuntina e Giuseppina, allieve di Efisia Murroni: hanno un loro laboratorio di tessitura a Sant’Antioco. Ho scoperto Arianna Pintus, giovane tessitrice di San Giovanni Suergiu, paese dell’entroterra del Sulcis: lei, da otto anni, tesse con il bisso prodotto da un altro bivalve mediterraneo, l’Atrina pectinata. Sono tutte artigiane di grande qualità. In alcune foto su internet mostrano con orgoglio bioccoli di bisso dai riflessi lucenti.
Ma sul web non c’è pace. E la lavorazione del bisso diventa una sorta di contesa tra i tifosi di una artigiana o dell’altra. Una disputa di paese. Ognuno racconta la «vera storia» di questo fragile filamento. Ognuno ha la sua versione, i suoi ricordi, la sua tradizione. La piccola storia del bisso diventa un copione per un noir. Il sito di Felicitas Maeder, www.muschelseide.ch/it/, mi è apparso il più puntiglioso e preciso. La studiosa svizzera dedica poche, gelide, parole a Chiara Vigo, mentre sul web è lei la «protagonista» del bisso.
Sono importanti questi litigi? Nell’epoca di internet lasciano tracce virtuali, quasi incancellabili, ma «inutili». Credo che le Pinne nobilis siano indifferenti ai post contrapposti. A loro preme aver cura del proprio mollusco e della loro bellezza. Ospitano tra le loro valve altri invisibili esseri marini. Sono preoccupate per la loro sopravvivenza: l’inquinamento dei mari, la distruzione dei loro ambienti sono, assieme a un pericoloso parassita, una minaccia vera. Queste conchiglie sono grate alla forza fragile del bisso che le trattiene ancorate in uno dei più bei mari del mondo.
E raccontano anche una piccola e importante storia moderna. È una cronaca laterale, segno di un’attenzione particolare dopo una tragedia. Nel gennaio del 2012, per una stoltezza arrogante del suo comandante, la nave da crociera Costa Concordia affondò davanti agli scogli dell’isola del Giglio. Morirono 32 persone. La nave si adagiò sul fondale, il suo scafo gigantesco incombeva su una colonia di duecento Pinne nobilis: mi raccontano che una pattuglia di sub e biologi dell’università di Roma non accettò il triste destino di questi meravigliosi bivalvi e cercò di salvarne il più possibile. Per «ripiantarli» in una zona più sicura. Non so se il salvataggio di queste conchiglie, ad anni di distanza, sia andato a buon fine.
Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!