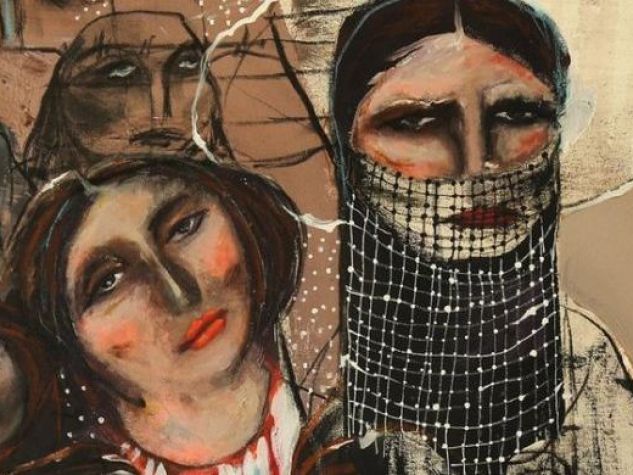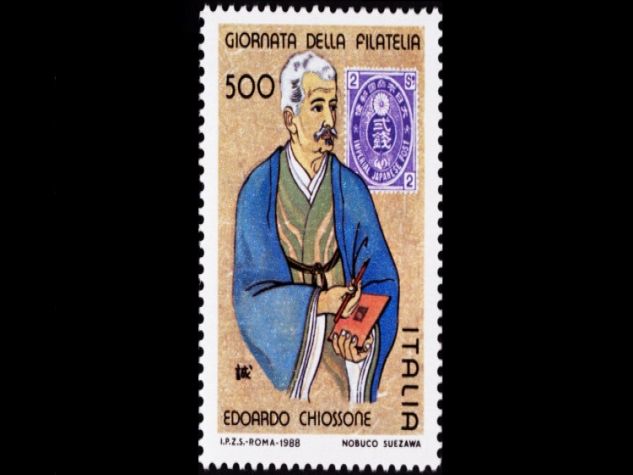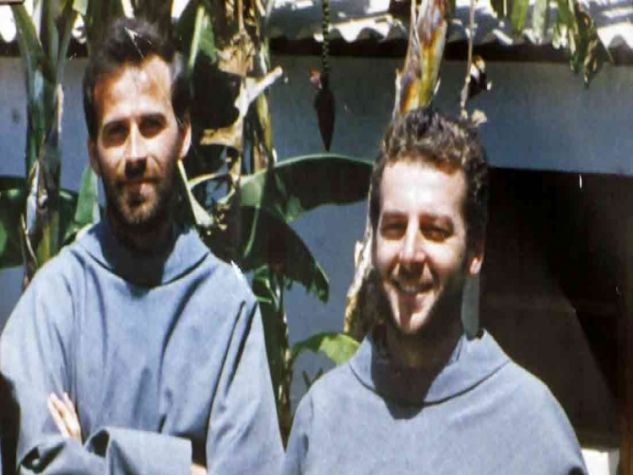Se ci fosse luce

Federica Storace, insegnante genovese di Lettere e Filosofia, da tempo impegnata nel volontariato in campo educativo, ci consegna un libro intenso, scritto con lo stile brioso che contraddistingue tutte le sue pagine (sempre pensate anche per un utilizzo in ambito educativo), uno di quei testi che lasciano il segno. Dopo le sue opere dedicate alla famiglia, al mondo della scuola, alle relazioni con il mondo religioso, agli adolescenti, questa volta al centro delle sue pagine troviamo gli anni di piombo e in particolare tre figure di uomini che, nel clima di tensione e di violenza di quegli anni, vennero uccisi dai terroristi. Due di essi, Guido Rossa, sindacalista, e Francesco Coco, magistrato, sono genovesi come l’autrice; il terzo, Aldo Moro, non è accomunato all’autrice dalla città di provenienza ma da uno sguardo sulla vita forgiato nel rapporto con i giovani (Aldo Moro fu a lungo docente). I tre uomini vengono presentati ai lettori da Storace attraverso il racconto di chi era loro vicino: per Guido Rossa è Giordano Bruschi, ex partigiano, all’epoca dei fatti impegnato nella segreteria del Pci genovese e attivo nel sindacato; per Francesco Coco è il figlio Massimo; per Aldo Moro l’allievo, e poi giornalista, Lucio Brunelli.
È la stessa autrice a spiegare, nel corso di una presentazione del volume a Padova, i motivi che l’hanno condotta a scegliere proprio queste tre figure: «Di Guido Rossa, freddato sotto casa il 24 gennaio del 1979, mi ha colpito il suo essere un uomo semplice. Era un operaio comunista. Ed era una persona che aveva sofferto molto: aveva perso un bambino a causa di un avvelenamento da monossido di carbonio. Aveva tante fatiche, ma anche innumerevoli passioni, come quella per la montagna (partecipò a spedizioni in Tibet e in Nepal, dove venne a contatto con la povertà più estrema e questa esperienza lo segnò moltissimo) o la fotografia. Era delegato Fiom-CGIL, eppure non esitò un attimo a denunciare un collega brigatista: sapeva il rischio che stava correndo, eppure non si tirò indietro proprio per marcare la differenza tra politica e terrorismo, tra operai e brigatisti».
La seconda figura presentata nel libro, Aldo Moro, «l’ho scelta – continua Federica Storace – perché mi interessava restituire ai lettori quel suo essere insegnante sempre disponibile ad ascoltare, a dialogare e a confrontarsi con i suoi allievi, una dote fondamentale. Ho voluto rimarcare che, seppure in quegli anni ci siano stati anche dei “cattivi maestri” che hanno inciso in modo negativo sui propri allievi, un buon insegnante può fare la differenza, trasmettendo con il suo esempio, ancor prima che con le sue parole, i valori fondanti del vivere civile».
La terza, Francesco Coco, ucciso l’8 giugno del 1976, «ho invece voluto inserirla nel libro per quel suo essere persona sensibile ma rigorosissima quando si trattava di non cedere davanti alla violenza. Da magistrato impedì lo scambio tra Mario Sossi (primo magistrato rapito dalle Br) e alcuni brigatisti arrestati: non voleva in alcun modo che lo Stato venisse a patti con le Br. E questo lo condannò. “Un magistrato può anche morire pur di rispettare la legge” diceva a chi gli chiedeva se era consapevole del rischio. Infine, mi ha colpito moltissimo l’omertà che ha circondato la sua uccisione, avvenuta in un luogo di Genova molto frequentato e in cui molti avevano visto chi aveva sparato, eppure nessuno denunciò per paura».
«In questi tre uomini, poi, al di là delle grandi differenze che li caratterizzavano - conclude l'autrice -, ho ritrovato un elemento comune: erano persone rette, in un momento in cui la rettitudine rappresentava una colpa grave. E questo è forse l’elemento che più contribuisce a fare di queste pagine, pagine di speranza. Perché solo la rettitudine può contribuire a creare dialogo, e quindi a costruire ponti e non muri». E forse, alla fine, è proprio questo il messaggio più profondo che ci restituisce questo libro.
Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!