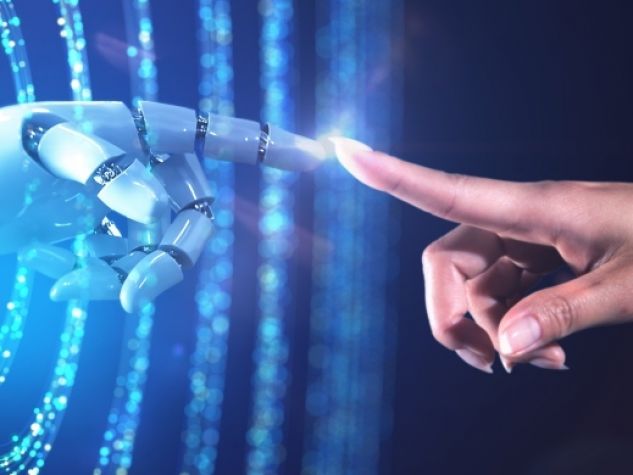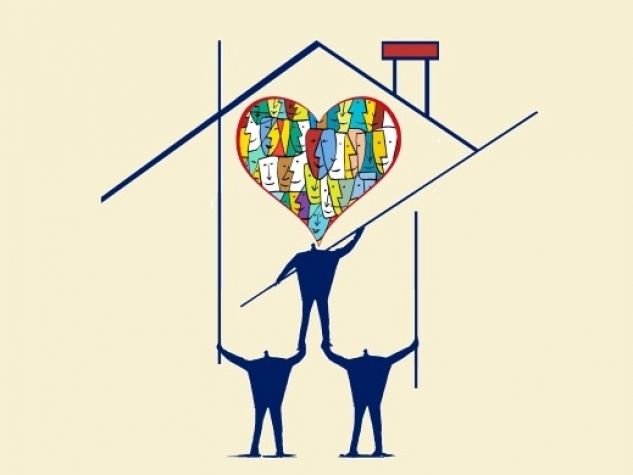Terapia del conflitto (II^ parte)
La violenza è sempre più diffusa nel mondo degli adolescenti, un po' perché è uno dei codici accettati del nostro tempo, ma soprattutto perché gli adulti hanno abdicato al loro ruolo di educatori, non mettendo più al centro le esigenze di crescita dei più giovani. Il cambio di atteggiamento verso i ragazzi si affianca ad altri errori sociali, inasprendo le divisioni e rendendo ancora più complicato il processo educativo. Il primo di questi errori è aver confuso il conflitto con la guerra: «Tre anni di bombardamento mediatico hanno fatto diventare sinonimi i due termini. Ma usare parole sbagliate crea, soprattutto nei ragazzi, immaginari sbagliati». Il conflitto non è la guerra, «è un normale confronto con un amico, un compagno, tua moglie, tuo marito, il vicino di casa; la guerra, invece, è quando cerchi il nemico per ucciderlo, per annientarlo». Tale confusione è devastante, perché la persona con cui litighi diventa il nemico irriducibile, mentre il conflitto, che è un’esperienza assolutamente normale della vita, diventa inaccettabile. «Non a caso i ragazzi al minimo accenno di criticità nelle loro relazioni, si azzuffano».
L’altro errore a livello sociale è aver messo da parte la capacità di confronto con chi la pensa in modo diverso, per dare sfogo alle pulsioni irrazionali ed emotive, fenomeno che domina soprattutto il linguaggio della politica. «Dal punto di vista scientifico – spiega Novara a riguardo – chi parla alla pancia vince, ma al contempo tira fuori il peggio delle persone; in particolare, nei ragazzi non aiuta il ragionamento, né l’apprendimento, né un clima che favorisca il benessere e la relazione». Si finisce preda dei propri pregiudizi. A peggiorare ulteriormente la chiusura nel proprio punto di vista, secondo molti psicologi dell’età evolutiva, è l’uso inconsapevole delle nuove tecnologie. Se da un lato gli smarphone aiutano la connettività e sono così centrali nella vita sociale dei ragazzi, dall’altro ostacolano l’interazione diretta, rischiando di attenuare nell’adolescente l’abilità di leggere le espressioni del corpo e i sentimenti dell’altro, di rispecchiarsi in lui, di entrare in empatia. Una mancanza che indebolisce la reciproca comprensione, rende più superficiali le relazioni, liquida eventuali conflitti invece di affrontarli.
Il terzo errore che ostacola il dialogo e accresce l’aggressività è aver allentato il principio di realtà, la capacità di distinguere il vero dal falso, il giusto dallo sbagliato, come se ogni concetto e ogni azione avessero lo stesso valore: «Se tutto è sullo stesso piano, è ancora possibile educare? – è la domanda provocatoria del pedagogista –. Davvero Mussolini equivale a Pertini? La scuola aiuta a valutare, a sollecitare il pensiero critico, a spronare il dibattito? O continua solo a pretendere ascolto, ascolto e ancora ascolto?».
Per uscire da questo tunnel educativo e trasformare al contempo la cultura della violenza in cultura della pace, Daniele Novara individua le due leve principali su cui la società dovrebbe investire: i genitori e la scuola. I genitori, in particolare, sono oggi la parte più debole nel processo educativo: «Avrebbero bisogno di avere delle linee guida, delle informazioni educative fin dalla nascita dei figli. Del tipo: che cosa succede nel bambino a 3 anni? Qual è il ruolo della madre e del padre? Quali sono i tempi del distacco? E via dicendo – afferma Novara –. E invece sono lasciati a loro stessi, in balìa degli influencer o degli psicologi che tendono a patologizzare le difficoltà dei figli. Ma l’adolescenza, lo dico sempre, non è una malattia». Una carenza non da poco, visto che la famiglia è il primo nucleo in cui s’imparano le relazioni, si educano le emozioni e si gestiscono i conflitti: «La politica – denuncia Novara – in questo campo è completamente assente. E così, per esempio, le esperienze più collaudate e scientifiche di scuola per genitori, come quelle proposte dal nostro centro, non hanno mai trovato un appoggio e un’organizzazione istituzionale e sono appese all’iniziativa di alcuni comuni più sensibili».
Il disinvestimento sui genitori fa il doppio con quello sugli insegnanti: «Purtroppo la formazione pedagogica degli insegnanti, che dovrebbe essere la base della professione, oggi in Italia sembra ancora un’utopia. Siamo fermi alla sola conoscenza della materia, come fosse l’unica cosa che conta, ma il vero problema è saper organizzare un processo di apprendimento dentro un gruppo classe e per farlo bisogna avere un metodo didattico, bisogna saper gestire le emozioni e i conflitti e saper collaborare con i colleghi. Non è affatto scontato».
Il conflitto che salva
Disinvestimenti che dimostrano come la nostra società abbia smesso di puntare sulle capacità basilari della convivenza, rischiando di aumentare la disgregazione e la violenza. «Chiunque è capace di stare con gli altri in un centro termale, ovvero quando tutto va bene, ma la vera capacità di relazione è stare con gli altri quando ci sono contrarietà, quando l’altro non è d’accordo con te, non ti dà ragione, vuole le tue stesse cose e cerca di farle sue. È, invece, fondamentale riscoprire l’importanza del conflitto come esperienza normale della vita. Anzi, dove c’è vita c’è conflitto. L’importante è non evitarlo, ma imparare a gestirlo fin da quando si è bambini».
Tuttavia, per educare alla gestione dei conflitti, questa sì concreto moltiplicatore di relazioni di pace e di nonviolenza, è importante che gli educatori, e prima di tutti i genitori, si dotino di un metodo. Uno dei più famosi ed efficaci per i bambini più piccoli è il metodo «Litigare Bene», sviluppato proprio da Daniele Novara e utilizzato ormai in molte scuole: «Nella vecchia cultura un bambino che litigava veniva punito. L’adulto interveniva e stabiliva chi aveva torto o ragione. Quindi il litigio era un’area di colpevolezza. Oggi, grazie a decenni di ricerche scientifiche, sappiamo che il litigio è indice di relazione e di interesse reciproco. È un luogo per mettersi alla prova, un modo per conoscersi». In estrema sintesi, il metodo ribalta il discorso della colpa, punta a far interagire i litiganti senza l’intervento adulto, li sprona a condividere le rispettive visioni dei fatti. L’adulto diventa un mediatore neutro, non cerca il colpevole, non giudica, non fornisce soluzioni: «Abbiamo constatato sul campo che questo metodo rafforza le competenze relazionali dei bambini, la loro autostima e la capacità di autoregolamentazione emotiva». Si costruisce così, litigio dopo litigio, la capacità di gestire i conflitti da soli, apprendimento che resterà per tutta la vita, come ogni abilità allenata da bambini.
Ma anche chi ha a che fare con un adolescente deve darsi un metodo: «Molti genitori pensano che l’adolescenza del figlio sia un prolungamento dell’infanzia. Continuano a iperproteggerlo, diventano amiconi. Vogliono ricreare l’intimità perduta attraverso il famoso mito del dialogo, ma quando il bravo bambino diventa un ribelle irriconoscibile e irriconoscente rimangono spiazzati». Il conflitto è normale, perché ogni adolescente ha il viscerale desiderio di autonomia e libertà, di volare fuori dal nido, ma il genitore, in particolare la madre, non l’accetta, si sente tradito, quasi offeso. «Anche in quel caso il conflitto inevitabile è una grande opportunità di crescita personale e sociale se i genitori sono in grado di coglierla, imparando a tenere la giusta distanza».
La violenza che oggi notiamo nelle giovani generazioni ha molteplici ragioni di natura educativa e sociale, il positivo è che oggi ci sono le conoscenze scientifiche e i mezzi pedagogici per prevenire il disagio dei ragazzi e delle ragazze e aiutare genitori e insegnanti a essere educatori efficaci. «La pace che tanto agogniamo – conclude Novara – ha le radici nella capacità di vivere i conflitti come area di comunicazione».
Puoi leggere il dossier completo nel numero di aprile del «Messaggero di sant'Antonio» o nella versione digitale della rivista. Provala ora!