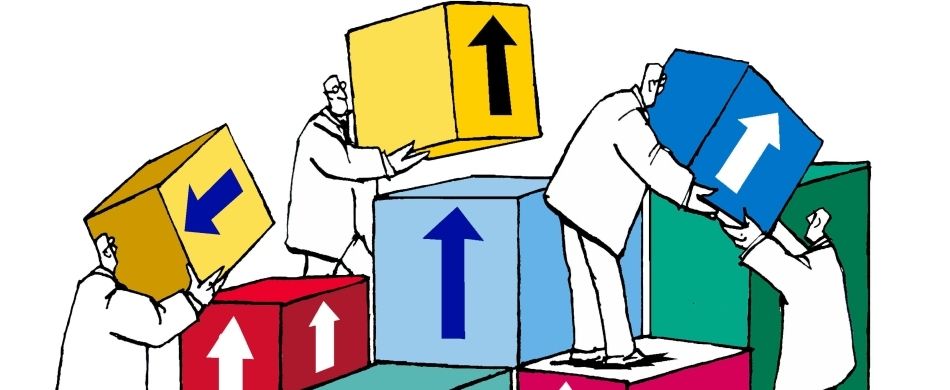Chi fa da sé fa per tre
A chi di noi non è capitato di dire qualche volta: «Chi fa da sé fa per tre»? Specialmente quando abbiamo fretta di risolvere un problema e quelli che ci stanno intorno ci fanno perdere tempo o ci complicano le cose. Ma abbiamo altresì sperimentato molte più volte che senza la collaborazione di altre persone non saremmo venuti a capo di una situazione complicata. L’ho sperimentato proprio di recente: la mattina in cui dovevamo ripartire dalle Dolomiti per tornare a Firenze. Alle sei del mattino, tutti pronti per partire; peccato che la batteria della macchina fosse completamente scarica. Di domenica mattina, alle sei, senza anima viva per le strade e le officine chiuse, non ce l’avremmo fatta da soli a ripartire senza l’aiuto di persone gentili e disponibili.
Viviamo in un tempo di forte individualismo, dove l’indipendenza e l’autosufficienza sono esaltate a norma assiologica. Il poeta Edgard Lee Masters, in un verso prodigioso, apre spiragli di luce: «Perché questo è il dolore della vita: che per essere felici bisogna essere in due». Beh, almeno in due. Da soli non si può essere felici. Eppure ai giorni nostri c’è chi si sposa con se stesso, con tanto di abito nuziale, foto ricordo, rito e formule varie. È il fenomeno che si sta diffondendo anche da noi della «sologamia».
Il proverbio ha comunque la sua ragion d’essere, come tutti i proverbi. Riflette l’importanza dell’autonomia e della capacità individuale di gestire situazioni e problemi. L’idea di essere autosufficienti è stata a lungo considerata un segno di forza e resilienza, soprattutto in contesti in cui le risorse erano limitate. E dovevi imparare a farcela da solo. Sviluppare delle buone capacità di autonomia, imparare a cavarsela, evitare di essere sempre dipendenti dagli altri, talvolta in maniera patologica, ha la sua importanza nella crescita di un essere umano, specialmente in età evolutiva. Insomma, aiuta a diventare protagonisti e responsabili della propria vita e ad affrontarla con coraggio e resilienza.
C’è un altro celebre proverbio che sembra contraddire il nostro: «L’unione fa la forza». In realtà non credo che si contraddicano: mi sembrano due facce della stessa medaglia. Nel mondo moderno, caratterizzato da una crescente interdipendenza e condivisione delle risorse, l’autonomia può essere sfidata. Molte sfide richiedono soluzioni collaborative e la capacità di lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni. Tuttavia, l’indipendenza personale rimane un aspetto importante, specialmente nell’affrontare decisioni individuali e responsabilità personali. In contesti complessi, in ambito sociale e professionale, la collaborazione può portare a risultati più efficaci nel raggiungimento di obiettivi; in questo caso la condivisione di idee, competenze e risorse spesso porta a soluzioni più innovative e sostenibili.
Occorre trovare un equilibrio tra autonomia e collaborazione, un approccio flessibile che consenta di adattarsi meglio alle diverse sfide della modernità. Come sempre, occorre saggezza e discernimento; se fare da soli diventa un assoluto, se l’autonomia diventa un idolo, si cade, magari senza accorgersene, in una forma di presunzione che conduce all’isolamento e alla dogmatica e sterile convinzione di non aver bisogno di nessuno. Imparare a collaborare e a fare le cose insieme agli altri richiede umiltà e misura, nonché la consapevolezza che da soli è più triste e talvolta anche impossibile: un chirurgo che fa da sé non fa per tre, rischia di ammazzare il paziente; così come non è possibile fare un figlio da soli, se non ricorrendo a mezzi non naturali. Farsi aiutare è un’arte difficile perché in qualche modo espone la nostra vulnerabilità, ci mette a nudo di fronte all’altro, ma ci fa anche gustare la bellezza della condivisione.
Se ci pensate bene, ogni felicità è sempre condivisione. Anche la fede, pur essendo un’esperienza personale, non si vive da soli: è personale ma non individuale. Si ha bisogno di una comunità di persone con cui condividere, gioire, piangere, pregare, celebrare la vita. Solo così si può fare fraternità e vincere la nostra paura più grande: la solitudine. Quella profonda, tetra, sterile, dove nessuno sa la tua storia né ti chiama per nome. C’è un passo di un libro sapienziale che mi ha sempre colpito e interrogato: «Meglio essere in due che uno solo, perché otterranno migliore compenso per la loro fatica. Infatti, se cadono, l’uno rialza l’altro. Guai invece a chi è solo: se cade, non ha nessuno che lo rialzi. Inoltre, se si dorme in due, si sta caldi; ma uno solo come fa a riscaldarsi?» (Qoèlet 4,9-11).
L’uomo tecnologico, nucleare e informatico ha sconfitto quasi tutto meno che la propria paura e la tentazione dell’autosufficienza, di bastare a se stesso. Si è strutturata una società basata prevalentemente sulla paura: paura di chiedere, di dare, di amare, di provare, di sbagliare, di sentire. Direi soprattutto: paura di amare e di donarsi. Negli ultimi decenni, come forse non era mai avvenuto nella storia dell’umanità, è stata barattata un’enorme quantità di valori e di sentimenti in cambio del benessere materiale e dell’alienazione della nostra fragilità, della nostra mortalità. Il progresso ha consentito di fare miracoli in campo sanitario e culturale, ma nello stesso tempo la tecnologia e l’esigenza della produzione hanno estraniato l’uomo dai suoi veri bisogni, che sono e rimangono bisogni di vicinanza, intimità, conferma, riconoscimento e condivisione.
La verità è che per vivere bene abbiamo bisogno degli altri. L’arte di vivere umanamente consiste nell’imparare ad amare veramente. Isolati si muore. Amati si vive! L’uomo è bisogno di amore. Da soli, forse, si va più veloci, ma insieme si va più lontano.
Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!