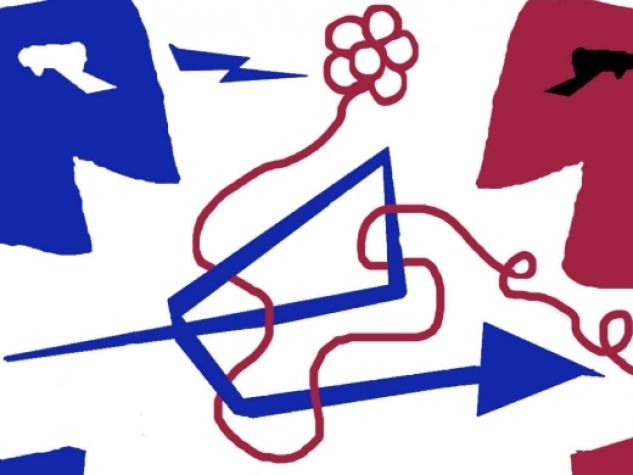Disarmare l’inutile strage
Da due anni a questa parte la guerra ci è piombata addosso. Il conflitto tra Russia e Ucraina, prima, e quello tra Hamas e Israele, poi, ci hanno messo di fronte all’evidenza che la guerra sporca, bruta, sanguinaria non ha chiuso i battenti con il ’900 e riguarda anche noi Paesi «avanzati». Ci ha costretto a fare i conti con aggrediti e aggressori, a cercare di capire che cosa è vero e che cosa è falso nelle opposte propagande, a chiederci se rispondere alla guerra con la guerra sia giusto, opportuno, efficace, anche a fronte di migliaia di vittime e, nel caso di Gaza, di una catastrofe umanitaria. Ci ha indotto a riflettere su quale grado di coinvolgimento sia giusto accettare, rispetto a quali valori e in quali modi. E ci ha spesso diviso in opposte fazioni: guerrafondai e pacifisti da divano.
Insomma un ginepraio difficile da districare. In Italia, in particolare, benché le statistiche rivelino che la maggior parte degli italiani sia contraria alla guerra, la guerra sembra essersi imposta come unica soluzione razionale, organizzata ed efficiente per affrontare i conflitti tra Paesi. E mentre ogni sforzo diplomatico risulta inefficace, qualsiasi proposta pacifista appare sbiadita, inconcludente, ingenua. Dobbiamo allora rassegnarci alla guerra, accettarla come ineluttabile sciagura per arrivare alla pace?
Anna Bravo, storica e saggista, ha scritto un celebre libro, La conta dei salvati (Ed. Laterza), in cui afferma che siamo così intrisi di cultura di guerra da non vedere l’altra parte della realtà, ovvero che sono più i salvati da milioni di azioni anonime fatte per evitare i conflitti o sabotare un potere ingiusto che quelli uccisi dalle guerre; solo che i salvataggi sono poco raccontati, meno glamour, e spesso confusi con la normalità, mentre le guerre riempiono le pagine dei libri di storia. Semplificando: è la nonviolenza, intesa non tanto in questo caso come movimento ma come volontà umana di evitare o limitare il sangue, che alla lunga vince, ma non sempre abbiamo gli occhi per vederlo. È malsano pensare – scriveva Anna Bravo – che quando c’è guerra c’è storia e quando c’è pace no; sarebbe invece importante «descrivere come avviene che un conflitto non deflagri o che resti limitato».
Chi ha cercato vie alternative alla guerra è stato ed è il movimento pacifista e nonviolento, che in Italia in particolare ha tanti approcci e tante anime, da quella cattolica a quella di sinistra, da quella liberale a quella radicale. Una via che in passato ha prodotto i suoi frutti, costruendo una diffusa cultura della pace e contribuendo a far raggiungere alcuni risultati concreti, come la legge 185/90 che regola le esportazioni militari o la riforma della legge sull’obiezione di coscienza, solo per citarne alcuni. Una via che però oggi non sembra più avere presa sull’opinione pubblica.
Pacifismo e nonviolenza, termini che noi usiamo indifferentemente, in realtà non sarebbero la stessa cosa. A spiegarlo è Massimo Valpiana, presidente del Movimento Nonviolento e direttore della storica rivista «Azione nonviolenta», fondata nel 1964 da Aldo Capitini, tra i primi a teorizzare il pensiero nonviolento di Gandhi in Italia: «Il pacifismo è un generico no alle armi e alla violenza, che richiede ad altri di non iniziare il conflitto o di fermarlo. La nonviolenza è un’evoluzione del pacifismo, perché è un mettersi in gioco, un entrare nel conflitto per capirlo e cercare soluzioni».
Anche per Alberto Zorloni, attivista, autore di Pacifismi (Infinito edizioni), la nonviolenza potrebbe essere una via percorribile, tuttavia per costituire una valida alternativa alla guerra è necessario dimostrare all’opinione pubblica che questo metodo di lotta funziona. «Oggi è necessario un pacifismo che non si limiti alle marce e alle petizioni, che non si chiuda nel proprio orticello, ma che sappia proporre una risposta unitaria, organizzata, misurabile, presentandosi come un’azione efficace e pragmatica, esattamente come fa la guerra. Ma questo al momento non sta accadendo».
Meno pessimista Valpiana, secondo il quale il passaggio dal pacifismo alla nonviolenza è un percorso evolutivo, che necessita di tempo: «La caduta del muro di Berlino ha fatto da spartiacque. Prima vigeva un pacifismo ideologico, che si esprimeva per lo più in manifestazioni – afferma –. Due anni dopo la caduta del muro, l’illusione di una nuova era di pace per l’umanità è svanita con lo scoppio della guerra del Golfo prima e di quella nella ex Jugoslavia dopo. Il pacifismo, grazie al contributo di Alex Langer, storico attivista ed europarlamentare, è diventato più concreto. I gruppi di pacifisti hanno iniziato ad andare nei luoghi del conflitto, per entrare in contatto con le vittime dell’una e dell’altra parte, capire le ragioni sociali, economiche, culturali della guerra e cercare soluzioni che coinvolgessero gli avversari».
Dalla parte delle vittime
A togliere credibilità alla nonviolenza oggi è il fatto che l’opinione pubblica la confonde con la passività e la sottomissione all’aggressore. Ma così non è. Gandhi per primo, infatti, afferma che di fronte a una vittima inerme meglio della codardia è la violenza. Ma la sua scelta d’elezione è la nonviolenza, una forma di lotta tutt’altro che passiva, anzi, ostinata, faticosa, rischiosa fino alla morte, se serve. Il Mahatma, per descriverla, ha coniato un termine apposito satyagraha, che letteralmente significa «la forza della verità», fondendo insieme due concetti molto dinamici. Nei fatti si tratta di una resistenza all’oppressione tramite la disobbedienza civile di massa, una forma di lotta che è riuscita a portare l’India all’indipendenza dall’Inghilterra e che ha dato al mondo un nuovo strumento per affrontare i conflitti.
«Gandhi non è l’inventore della nonviolenza, che è sempre esistita – specifica Valpiana –, ma è colui che ha trasformato la nonviolenza in uno strumento politico». Questo tipo di lotta non s’improvvisa, ha bisogno di tempo, di conoscenze, di strategie, di esercitazioni e di mezzi adeguati, proprio come un dispositivo militare: «Agisce soprattutto a livello preventivo, mentre è meno efficace a guerra ormai scoppiata». Come la guerra, ha un vero e proprio «armamentario». Gene Sharp, filosofo e politologo americano, non a caso chiamato «il Machiavelli della nonviolenza», ha individuato 198 tecniche sperimentate: dal boicottaggio allo sciopero, alla non collaborazione attiva; dall’istituzione di organi di governo paralleli alla disobbedienza civile.
Per capire come funzionano, può essere utile ricordare il caso della Danimarca durante l’occupazione nazista. Il 9 aprile del 1940 la Germania invade il Paese. Il monarca, Cristiano X, scende a patti con Hitler, consapevole che una resistenza armata sarebbe stata un’inutile strage. Negozia con il nemico, ottenendo qualche margine di libertà, che gli consente di organizzare una resistenza popolare nonviolenta. Cominciano una serie di azioni a diversi livelli, che confondono il nemico. Tra le prime, la marina danese fugge nella vicina e neutrale Svezia, dopo aver affondato la flotta. I lavoratori attuano una serie di scioperi e sabotaggi di massa che riescono addirittura a fermare la produzione bellica.
Ma il fiore all’occhiello è il rifiuto di attuare le leggi razziali e il salvataggio di quasi tutti gli ebrei danesi. La non collaborazione avviene anche nelle azioni di tutti i giorni, come far finta di non capire il tedesco o uscire dai luoghi pubblici in presenza di un soldato della Wehrmacht. Tra la popolazione circola un vero e proprio decalogo che va dal «lavorare male per i tedeschi» al «distruggere tutto ciò che può essere utile per i tedeschi», al «boicottare i loro beni», fino alla protezione degli oppressi e all’intimidazione dei possibili collaborazionisti del regime. Un caso che ha fatto storia.
Nonviolenza batte guerra
Gli studiosi contemporanei stanno facendo emergere dall’oblio molti casi di resistenza nonviolenta in tutto il mondo. Una ricerca della politologa statunitense Erica Chenoweth, tradotta in italiano nel volume Come risolvere i conflitti, senza armi e senza odio con la resistenza civile (Sonda, 2023), contraddice il pensiero corrente dell’inevitabilità della guerra. Il libro ha alle spalle dieci anni di ricerca, condotta insieme a Maria Stephan, sull’efficacia delle lotte nonviolente nel mondo dal 1900 ai giorni nostri. La ricerca censisce 627 campagne di lotta di massa, di cui 303 hanno utilizzato prevalentemente la violenza e 324 si sono affidate alla resistenza nonviolenta. Solo il 26 per cento delle lotte violente ha raggiunto gli obiettivi, contro il 50 per cento delle lotte nonviolente.
L’altro tema da tener presente è il rapporto costi-benefici di ciascuna forma di lotta. «In guerra si spendono cifre abnormi per ottenere spesso risultati modesti o addirittura controproducenti, che generano ulteriori odi e conflitti» afferma Alberto Zorloni. Ne è esempio lampante la guerra in Afghanistan, costata 140 mila morti tra gli afghani e 3.500 tra i soldati della coalizione anti-fondamentalista. La spesa militare è stata vertiginosa, «33 volte più alta di quanto i Paesi Ocse destinano ogni anno per gli aiuti allo sviluppo». Una guerra finita con un nulla di fatto, con il ritorno dei talebani a capo del Paese, il giorno dopo il ritiro dell’ultimo contingente americano, il 31 agosto del 2021.
Cifre mostruose e numero spropositato di morti anche nelle guerre in corso: «La guerra tra Russia e Ucraina – rilancia Valpiana – doveva durare poche settimane, ma a due anni di distanza non se ne vede la fine. Il problema è che si investe molto in armamenti e poco o niente in nonviolenza, la quale può funzionare solo se è preparata, equipaggiata, organizzata. Se, per esempio, i Paesi avessero investito adeguatamente nelle Nazioni Unite, queste avrebbero potuto creare la forza di polizia autonoma, prevista dalla carta fondativa, che avrebbe avuto autorevolezza e preparazione per intervenire nei teatri di guerra. Questa polizia, per esempio, avrebbe potuto essere utilizzata nel Donbass nel 2014, prevenendo l’attuale guerra in Ucraina».
Se la nonviolenza funziona meglio e conviene da ogni punto di vista, perché non viene utilizzata? Lasciando da parte gli indubbi interessi di lobby economiche e politiche, la ragione di fondo è culturale. Siamo immersi in un clima di violenza anche nella vita quotidiana, dai rapporti sociali e lavorativi all’informazione, dalla dialettica politica al linguaggio. Nonostante ciò, il pacifismo tenta vie alternative: «Nei due conflitti in corso – esemplifica Valpiana – il pacifismo sta cercando di stringere più rapporti possibili con le persone coinvolte nei conflitti, vittime in testa. Teniamo relazioni con gruppi di pacifisti ucraini, russi, ebrei e palestinesi, anche se nei Paesi non democratici questo lavoro è molto difficile, a volte impossibile. Questa logica ci porta a sostenere i gruppi misti, quelli che già stanno cercando la via per superare il conflitto.
L’altra azione concreta è sostenere gli obiettori di coscienza, i disertori, i transfughi ma non traditori della propria parte che già stanno dialogando tra di loro. Li accogliamo, li ascoltiamo, se serve sosteniamo la difesa legale». Un’istanza politica che il pacifismo sta portando avanti è quella di chiedere all’Europa di concedere lo status di rifugiato politico ai giovani disertori ucraini, russi, bielorussi, israeliani e palestinesi. «Non è un’utopia – conclude Valpiana –, è già successo in Italia nel 1992, quando un decreto governativo ha offerto accoglienza ai giovani che fuggivano dalla guerra nell’ex Jugoslavia. Secondo noi questi sono i modi più efficaci oggi per indebolire gli aggressori e sostenere il processo di pace». Non passività, quindi, ma azione su più fronti e valorizzazione delle minoranze nonviolente, che già stanno cercando soluzioni condivise. Parafrasando Anna Bravo, mentre qualcuno trama la guerra, è bene che altri tramino la pace.
Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!