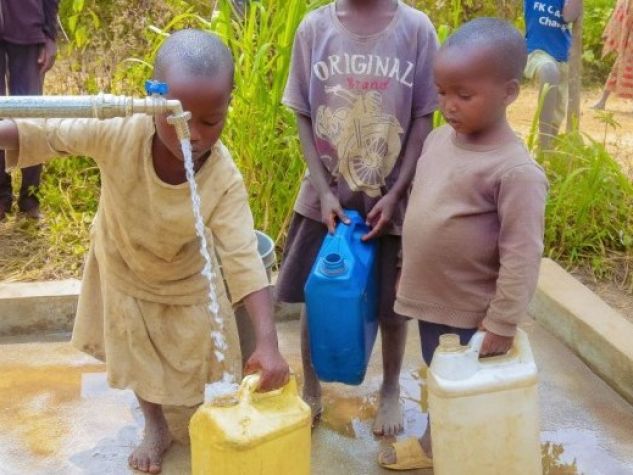Il buio nella Chiesa
È scomodo l’ultimo romanzo di Mariapia Veladiano, Dio della polvere (Guanda), scomodo ma necessario. Perché il volume della scrittrice e teologa vicentina affronta con parresia e con coraggio il tema degli abusi sessuali nella Chiesa e del silenzio colpevole che spesso li ha accompagnati. Lo fa con uno stile sobrio e uno sguardo empatico, che non permette giudizi facili e che non cede mai alla morbosità, ma che comunque non fa sconti. La vicenda ruota attorno a Chiara Camilliani, una fisioterapista che entra in conflitto con l’autorità ecclesiastica – rappresentata nel libro da un vescovo – per salvare la vita di una sua paziente, gravemente malata proprio a causa degli abusi subiti, quando era una ragazzina, da parte di un prete. Il romanzo è un lunghissimo dialogo carico di tensione emotiva, e rappresenta una sorta di chiamata collettiva alla responsabilità, alla verità e alla speranza, attorno a un tema spinosissimo.
Msa. La prima domanda è d’obbligo: come mai una scrittrice, una teologa, una donna di fede a un certo punto decide di misurarsi con un tema così difficile?
Veladiano. Perché a mio avviso era necessario. Ho passato la mia vita quasi interamente nel mondo della Chiesa. Ho studiato teologia per dieci anni, tra Roma, Milano e Vicenza. Scrivo per una rivista teologica, «Il Regno» che, unica in Italia, si è sempre occupata del tema della pedofilia, con competenza e senza scandalismi, pubblicando documenti, inchieste e così via. Collaboro con altre riviste cattoliche: oltre al «Messaggero di sant’Antonio», «L’Osservatore Romano» per esempio. Ho, dunque, sempre mantenuto uno stretto rapporto con il mondo ecclesiastico e spesso ho incrociato questo tema, restando allibita di come esso venisse via via affrontato in tanti Paesi del mondo, come gli Stati Uniti, la Germania, la Francia (dove, per esempio, è stato pubblicato un documentatissimo rapporto sul tema, il Rapporto Sauvé, ordinato dalla Conferenza episcopale francese però a un organismo totalmente indipendente), l’Irlanda (dove si è incrociato con quello altrettanto scottante degli istituti femminili cattolici nei quali venivano rinchiuse giovani ragazze madri o semplicemente ragazzine un po’ bizzarre, affidate a suore abusanti), mentre in Italia non se ne parlava. E allora, dopo essermi a lungo informata, leggendo atti dei processi, documenti, inchieste, ascoltando podcast sul tema, ho cominciato a chiedermi il perché di questo silenzio nel nostro Paese…
Ecco, appunto: perché?
Ho trovato più di una possibile risposta. Innanzitutto, che da noi non esiste un vero e proprio giornalismo di inchiesta indipendente, come invece c’è, ad esempio, negli Stati Uniti. Quel giornalismo in altri Paesi ha fatto emergere o si è occupato ampiamente del problema. Poi, che spesso i giornalisti che si muovono in ambito cattolico, anche bravi, fanno riferimento alle diocesi e non si sentono del tutto liberi di indagare questo tema. Ma ciò non toglie che il problema esiste. Da quando il libro è uscito, continuo a essere avvicinata da persone che in qualche modo hanno avuto a che fare con gli abusi, o perché conoscono qualcuno a cui è capitato, o perché ne hanno sentito parlare indirettamente. E allora ho voluto tentare di colmare questa lacuna. Io non faccio la giornalista, non sono una saggista, così ho deciso di scrivere un romanzo che parlasse di abusi sessuali e di pedofilia nella Chiesa. Il problema era il come parlarne, perché non volevo creare una storia morbosa. La morbosità non serve a nessuno: dopo il primo momento di sdegno, infatti, non aiuta il pensiero. Così alla fine ho trovato questa forma di dialogo tra un vescovo e una donna, una fisioterapista, che non è l’abusata, ma una donna che parla in nome di un’altra, una sua paziente che rimane sullo sfondo della storia. Un dialogo che, proprio perché non coinvolge la diretta interessata, è estremamente onesto, scevro dal dubbio di esprimere interessi personali, perché ha l’unico obiettivo di ottenere giustizia per una donna che si sta lasciando morire a seguito degli abusi subiti.
Nel volume tu tratti molti temi che in qualche modo si collegano a quello degli abusi sessuali nella Chiesa. Temi che per la loro presenza o, al contrario, per la loro assenza, hanno favorito il diffondersi di atteggiamenti e comportamenti abusanti. Uno di questi temi è senza dubbio quello della responsabilità. Chiara, la protagonista del libro ne parla ampiamente…
Sì, la questione della responsabilità è davvero importante. Dalle documentazioni che noi possediamo rispetto ai casi di abuso all’estero, emerge che per ogni persona che viene abusata ce ne sono almeno dieci che hanno taciuto. E allora è evidente che c’è una responsabilità collettiva. Perché chi sapeva ha taciuto? Per mille ragioni. Intanto, perché parlare è «tirarsi nei guai», come si dice, ed è già questo un bel problema. Poi, perché c’è nel cattolicesimo un’idea, a mio avviso, malata, una sorta di acquiescenza, in base alla quale il silenzio apparterrebbe al buon fedele: «Vedo delle cose che non vanno, però le affido al Signore». E poi c’entra il nostro modo di guardare ai preti. Mi spiego. Nella nostra religione, in riferimento ai preti c’è un termine che ritorna spesso: elezione. È una parola presente sin dal rito dell’ordinazione, dove ritorna in modo quasi ossessivo, e rimane poi ad aleggiare su di loro anche dopo. Bene, se noi guardiamo a un sacerdote come a un eletto, è difficile ammettere che compia degli abusi. C’è tutto un mondo, quindi, che ci educa a non vedere. Anche la stessa parola «abuso» è sbagliata, perché abuso presuppone che ci sia un «uso corretto», ma non c’è un uso corretto della sessualità su un bambino piccolo... Quindi meglio chiamarla violenza, per dirne subito la gravità: bisogna usare meglio anche le parole.
Ma, tornando alla responsabilità, questo è davvero un tema fondante, perché qui non siamo dinanzi a una singola mela marcia: c’è spesso una intera comunità che non si assume la responsabilità di difendere i bambini che subiscono violenza. In quasi tutti i casi che noi conosciamo, infatti, erano in tanti a sapere, eppure nessuno è mai intervenuto. E invece tutti dovremmo sentirci responsabili. Chiara, la protagonista del romanzo, questa responsabilità la assume su di sé e cerca per la sua paziente un riconoscimento, una forma di giustizia.
Perché Chiara insiste nel dire che c’è bisogno che le vittime ottengano giustizia?
Perché la giustizia è importante. Nello studio di Chiara arriva questa paziente che si sta lasciando morire, e lei intuisce, manipolando, da fisioterapista, il corpo di questa giovane, che la malattia in realtà serve a coprire una ferita profonda. E capisce che c’è solo una cosa che potrebbe salvarle la vita: la giustizia. Non il perdono, la giustizia. Perché la giustizia mette a posto le cose: dice chiaramente chi è la vittima e chi il colpevole. Troppe volte chi subisce violenza sviluppa un immotivato senso di colpa. La giustizia lo cancella. Poi, certo, anche il perdono è importante, ci mancherebbe. Ma se arriva, deve arrivare dopo un percorso di giustizia, perché non si può passare immediatamente dal dire «sì, quel prete è stato pedofilo», al perdono. Se in mezzo non c’è la giustizia, manca l’anello che ripara e che riconosce. Quindi Chiara lotta per questo, per avere giustizia per la sua paziente. La sua idea di giustizia è che il violentatore vada in prigione. Chi conosce i miei libri sa che non sono mai «tagliati con l’accetta», ci sono tante sfumature e tante possibilità quando si parla dell’essere umano. Io credo che possano esserci anche altre soluzioni giuste, oltre al carcere. Ma di certo esse non possono includere, subito, il perdono. Perché il perdono può venire solo in un secondo momento. Talvolta può anche non arrivare mai, perché possono esserci faccende che solo il Signore può perdonare. Chiara nel libro lo dice apertamente: troppe volte la Chiesa ha chiamato questi reati, peccati. E invece sono prima di tutto dei reati (poi, solo poi, per chi crede sono anche peccati) ed è giusto che chi li compie venga riconosciuto colpevole. Dobbiamo stare attenti: a volte anche il perdono può essere abusante. Nel romanzo, a un certo punto Chiara lo dice al vescovo: troppe volte voi prendete le vittime, non date loro giustizia, le portate in una chiesa, in una sorta di cerimonia di richiesta di perdono, e le usate strumentalmente per mostrarvi buoni. Ma perché una vittima si presta a questo? Perché ha bisogno di essere riconosciuta, ha bisogno di sentirsi non l’oggetto del potere e del piacere di un prete, ma un essere umano. Quindi meglio questo che nulla. Però il perdono in questo caso è un perdono abusante. Un grande studioso di questi fenomeni, Hans Zollner, un gesuita tedesco, dice che molte delle inchieste che la Chiesa italiana sta facendo sulla pedofilia ecclesiale, sono «inchieste elemosina», le ha definite così. Cioè rappresentano una buona azione, come la monetina che si dà a un povero, ma non sono risolutive di una situazione, non rendono cioè giustizia alle vittime.
C’è un altro tema su cui il libro si sofferma: l’obbedienza. Don Tonino Bello, nel suo libro Maria Donna dei nostri giorni, scriveva che obbedire deriva da ob-audire, cioè ascoltare stando davanti, nulla a che vedere quindi con una sottomissione forzata, bensì con un ascolto attento e soprattutto consapevole. Nel tuo libro, invece, emerge un’altra realtà. Anche se c’è una splendida figura di religiosa, suor Mary Ann, che sa disobbedire se è il caso, per sciogliere i nodi irrisolti…
Sì, Chiara lo sottolinea in modo molto forte. C’è un’enfasi tutta cattolica sull’obbedienza che, in genere, è gettata addosso alle donne. Credo che ancora una volta siamo dinanzi a un problema di potere maschile sul femminile. È vero che anche nelle Regole degli ordini maschili si parla di obbedienza, ma non è paragonabile all’obbedienza che ci si aspetta dalle donne religiose, un’obbedienza quasi cieca. C’è una frase di Hannah Arendt che a Bolzano brilla a lettere luminose nella piazza del tribunale, ed è meravigliosa: «Non abbiamo il diritto all’obbedienza», cioè non abbiamo il diritto di abdicare così tanto al nostro cervello da obbedire in modo cieco, perché l’obbedienza non può essere la scusa per non pensare. L’obbedienza è importante, ma non può essere una deroga al pensiero e alla responsabilità personale. Tanto più rispetto al tema delle violenze e degli abusi.
Ci sono dei casi particolarmente virtuosi in Italia, sulla lotta alla pedofilia nella Chiesa?
Quello della diocesi di Bolzano-Bressanone, che ha ordinato, attraverso il suo vescovo, Ivo Muser, un’indagine indipendente all’istituto tedesco che se n’è occupato per la Germania. I risultati sono stati pubblicati a marzo 2025 e sono anche stati messi a disposizione, in chiaro, tutti gli archivi. Il vescovo ha chiesto scusa per gli errori commessi e per non aver capito prima la gravità di quanto era successo. Non solo. Ha anche comunicato che da ora in poi il servizio di tutela minori della diocesi sarà affiancato da una serie di esperti indipendenti.
Il vescovo del libro a un certo punto, dinanzi alla rivelazione degli abusi, chiede a Chiara come faccia a credere ancora, visto che è così arrabbiata con i preti. E lei dà una risposta secca…
Sì, Chiara gli dice letteralmente: «Non siete così importanti sa, vescovo. Non così importanti da togliermi la fede. Il sonno sì, ma la fede no». E forse sono le uniche parole che da credenti, dinanzi agli abusi e alle violenze nella Chiesa, dopo aver ottenuto giustizia per le vittime, possiamo pronunciare anche noi.
Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!