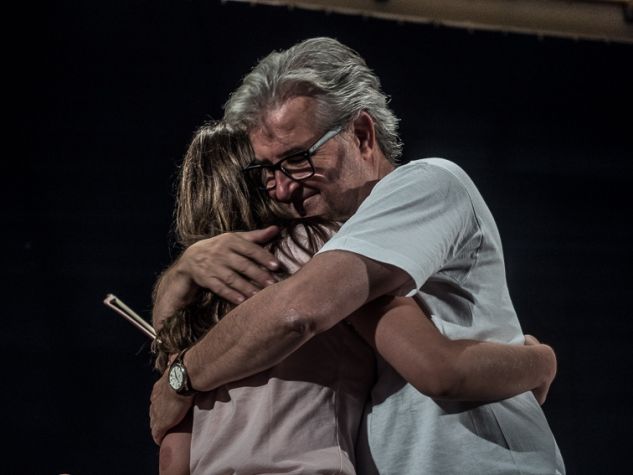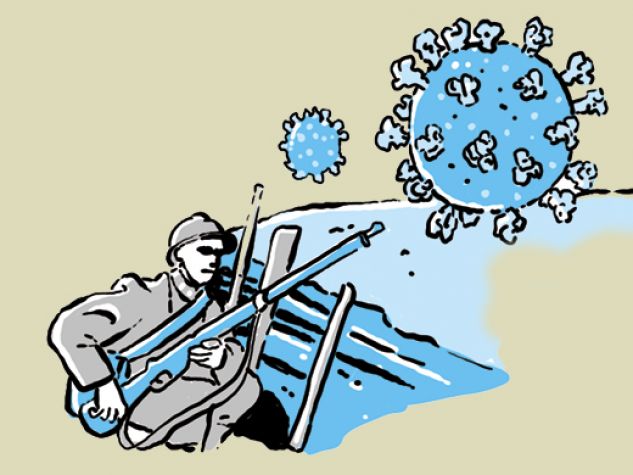Rider, l’altra faccia del lavoro
Il giovane uomo sulla trentina a cavallo della bici ha il sacchetto del sushi in mano e una grande borsa arancio sulle spalle. Il tempo di un breve saluto, il sacchetto passa di mano, esala un tenue profumo speziato e l’umido caldo della tempura. Al grazie del cliente, il ragazzo ha già inforcato la bici, per sparire dietro l’angolo sovrastato dalla grande borsa arancio, che segue il ritmo della pedalata. Una scena vista decine di volte, che si è moltiplicata durante la pandemia. Le consegne dei fattorini delle piattaforme del cibo (food delivery), ma anche quelle dei supermercati o di Amazon, scandivano giornate di clausura o di smartworking, mettendo in luce finalmente quei lavoratori atipici che fino a quel momento erano rimasti invisibili dietro le merci.
Chi sono? Studenti svegli che si guadagnano un gruzzoletto? Lavoratori che arrotondano gli stipendi? Gente senza competenze che così trova il modo di fare qualche soldo? Ipotesi possibili, visto che l’economia che comprende le consegne di cibo a domicilio si chiama gig economy, che significa «economia dei lavoretti», cioè di quei lavori precari e saltuari, poco pagati ma facili da trovare, che non si presentano come un lavoro vero e proprio, ma come una possibilità di integrare il salario, quando si ha un po’ di tempo a disposizione.
Di questa galassia di «lavoretti», quella dei rider, termine inglese che offre una patina di brillantina al meno roboante termine italiano «ciclo-fattorini» si è notevolmente accresciuta nell’ultimo anno di pandemia. Non è facile sapere quanti siano: c’è chi parla di 60 mila e chi scommette che siano molti di più. Tuttavia, una ricerca pre-pandemia, realizzata dall’Università di Milano per tracciare un profilo socio-economico dei rider della città aveva già messo in chiaro un aspetto fondamentale: per molti rider non si tratta di un «lavoretto», ma di lavoro a tempo pieno, spesso unica fonte di reddito, in un periodo storico in cui il lavoro garantito e contrattualizzato è sempre più un miraggio.
All’epoca della ricerca (effettuata tra novembre 2018 e gennaio 2019), il 61 per cento dei rider milanesi era di origine extra UE, il restante di origine italiana o europea. Il 50 per cento aveva una scolarità elevata, diploma o laurea (14 per cento). Difficile ora dire, dopo quasi un anno e mezzo di pandemia e di crisi occupazionale, come sia cambiato questo identikit.
Ma da dove viene l’economia dei lavoretti? C’è una risposta semplice e una un po’ più complessa. Quella semplice è che questi lavori sono frutto di internet e delle continue innovazioni tecnologiche, che hanno permesso la creazione di piattaforme digitali, capaci di far incontrare in tempo reale la domanda e l’offerta, ovvero chi vuole un menu di sushi e il ristorante che può prepararlo. La piattaforma in molti casi è anche in grado di gestire chi può andarlo a prendere al ristorante e consegnarlo al cliente, calcolando i tempi dell’intera operazione, che va dall’ordine al ciclo-fattorino di fronte a casa con il sacchetto di sushi in mano. Ciò che permette una gestione così orchestrata è un algoritmo, termine informatico che descrive una serie di istruzioni per organizzare dati, al fine di risolvere un problema nel modo più rapido ed efficiente, in questo caso portarci il cibo a casa, appena fatto, all’orario stabilito.
Fin qui la spiegazione facile ci fa capire che, grazie alle innovazioni, noi abbiamo la possibilità di accedere o comprare beni e servizi dal nostro smartphone, con facilità e immediatezza e ciò aumenta di molto le nostre possibilità di scelta e comodità. Vantaggio anche per i ristoratori, i quali, abbattendo il limite del luogo fisico, hanno una platea di clienti potenzialmente molto più vasta. E, sempre grazie a queste innovazioni, in teoria chi ha un po’ di tempo può accedere a un lavoretto in proprio che aiuta ad arrotondare. La spiegazione complessa guasta un po’ la festa, precede quella semplice e mostra il lato oscuro di tutte queste nuove possibilità. Il nocciolo della spiegazione sta nella risposta ad alcune domande: chi controlla le piattaforme? Chi le regola? Chi decide le istruzioni per far funzionare gli algoritmi?
I dati che ci rendono merce
Il nostro cellulare è diventato un po’ la scatola nera di tutto quello che facciamo e… pensiamo. Siamo continuamente collegati e dallo smartphone spesso organizziamo gran parte della vita: dalla spesa on line alla prenotazione per una visita medica, alla scelta dell’hotel per le vacanze, fino alla chiamata del taxi o, appunto, alla cena a domicilio. Tanti vantaggi che hanno però alcune ricadute poco chiare: ogni nostra azione genera una scia di dati, per esempio luoghi visitati, tipo di merce comprata, tipo di post commentati sui social, tutti dati che poi vanno a identificare i nostri gusti, tendenze, disponibilità di spesa, facendoci diventare, nostro malgrado, un libro aperto per i grandi imperi digitali che usano questi stessi dati e li vendono per i loro affari.
Non a caso, tra i dieci uomini più ricchi del mondo nella classifica 2021 di «Forbes», ci sono i magnati, quasi tutti americani, dell’economia digitale e delle piattaforme che più comunemente usiamo: da Jeff Bezos, l’inventore di Amazon, che si trova al primo posto, a Bill Gates, il patron della Microsoft, al quarto, fino a Mark Zuckerberg, il creatore di Facebook, al quinto, e i fondatori di Google, Larry Page e Sergey Brin, all’ottavo e nono. «Immense fortune concentrate in pochi uomini, che tra l’altro hanno accesso a tutti i nostri dati, sono la spia rossa che qualcosa non va – afferma Roberto Reale, giornalista, già vicedirettore del TG3 e di Rainews24, studioso dei nuovi media e degli effetti della tecnologia sulla società –: se pochi hanno molto e sanno molto, mentre molti hanno poco e sanno sempre meno, il rischio è quello di alimentare un meccanismo che aggrava ogni giorno di più le diseguaglianze a livello planetario e che fa in modo che altri decidano per noi, sotto la patina di una falsa libertà di scelta».
Le piattaforme del cibo attecchiscono in questo ambiente digitale avanzato e diseguale a partire dalla prima decade del 2000, nei Paesi anglosassoni, cogliendo l’esigenza diffusa tra la gente di poter accedere velocemente a pasti pronti, in contesti in cui c’è sempre meno tempo e voglia di cucinare. Pochi sanno che l’idea all’origine del food delivery nasce in India, ma è solo in Inghilterra che trova le condizioni per diventare un grande business digitale. In Italia le grandi compagnie atterrano in maniera più consistente dal 2015. Le diverse piattaforme, da Just Eat a Deliveroo, da Foodora a Glovo, da Uber Eats a MyMenù, si contendono un mercato in continua crescita, che ha avuto un boom nel 2020 proprio a causa della pandemia.
Secondo l’ultimo rapporto di Just Eat, oggi il comparto rappresenta in Italia dal 20 al 25 per cento dell’intero settore del domicilio, con un giro d’affari annuo che va dai 700 agli 800 milioni di euro. Un mercato dal grande potenziale, che tuttavia soffre di una spietata concorrenza che ha al centro proprio la figura del rider. «Diventare rider è piuttosto semplice – racconta Giovanni, 20 anni, studente di statistica –, non ti scelgono per curriculum. Entri nella piattaforma, ti iscrivi, ti vengono chiesti carta d’identità, eventuale permesso di soggiorno, la proprietà di uno smartphone e di un mezzo, bici, moto o auto che sia. Pochi giorni dopo, nel caso delle aziende più grandi, ricevi l’attrezzatura: la borsa termica, giacca catarifrangente antivento e antipioggia, i pantaloni impermeabili, caschetto e supporto per la bici».
Puoi leggere il resto del dossier nel numero di giugno del «Messaggero di sant'Antonio» o nella versione digitale della rivista. Provala ora!