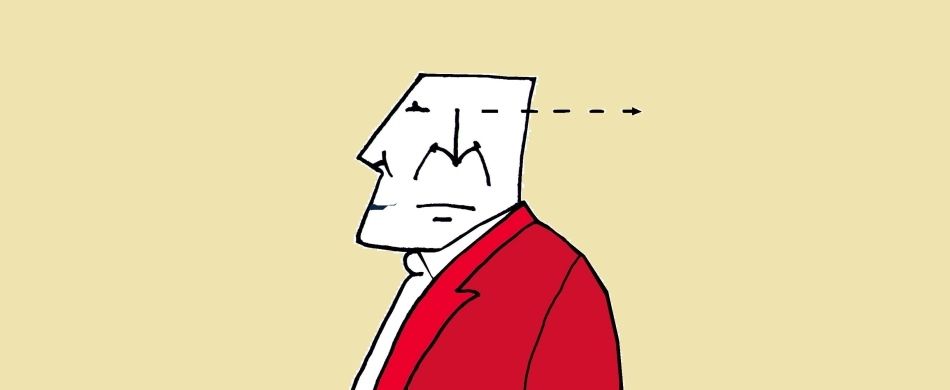Si stava meglio quando si stava peggio
C’è un mito che aleggia e intramontabile si riaffaccia costantemente nella sensibilità collettiva tutte le volte che percepiamo una situazione di crisi sociale ed economica: quello della degenerazione dei tempi, con i vari «Si stava meglio quando si stava peggio!», «Gli uomini di oggi non hanno più valori» o «I giovani non sono più quelli di una volta». E via di questo passo, con una retorica avvilente che scoraggia ogni cambiamento e chiude la porte al futuro.
Si legge in un frammento di argilla babilonese risalente a 3 mila anni fa: «Questa generazione è guasta fino al midollo; è cattiva, irreligiosa e pigra. Non sarà mai come la gioventù di una volta. Non riuscirà a conservare la nostra cultura». E in un papiro egizio di 5 mila anni fa: «I tempi non sono più quelli di una volta. I figli non seguono più i genitori». Nel 700 a.C. Esiodo scriveva: «Non nutro più alcuna speranza per il futuro del nostro popolo, se deve dipendere dalla gioventù superficiale di oggi, perché questa gioventù è senza dubbio insopportabile, irriguardosa e saputa. Quando ero ancora giovane mi sono state insegnate le buone maniere e il rispetto dei genitori. La gioventù di oggi invece vuole sempre dire la sua ed è sfacciata» (Cfr. S. Olianti, Fai fiorire la vita. Tracce per educare lo sguardo, EMP). Avete mai sentito lamentele come queste? Come si vede, niente di nuovo sotto il sole. Ma davvero il passato talvolta era migliore di quanto pensavamo? Chissà, ma questa percezione oggi riecheggia nella nostra mente specialmente perché gli anni passati non torneranno e la nostalgia della gioventù andata è forte per ciascuno di noi. Certi luoghi comuni che sono ardui da sfatare rappresentano il primo segnale di una senilità precoce della speranza e del desiderio, che porta a favoleggiare antiche età dell’oro che non sono mai esistite.
Indietro non si torna, questo è certo. Non possiamo nutrirci di quell’ambrosia drogata che è la nostalgia: il dolore di non poter tornare indietro nel tempo. Un medico del XVII secolo coniò questo efficace neologismo per descrivere la sofferenza che spingeva i soldati svizzeri, in una guerra lontano da casa, a disertare dopo aver ascoltato i canti della propria terra. Allora congiunse la parola nostos, che in greco significa ritorno, a un’altra parola greca che in medicina si usa per indicare il dolore, algos, coniando un termine che designava il dolore provocato dal desiderio dl ritorno: nostalgia, appunto (cfr. A. D’Avenia, Resisti cuore. L’Odissea e l’arte di essere mortali, Mondadori).
La nostalgia del passato è profondamente radicata nella natura umana e nei meccanismi della psiche. Credo, dopo tanti anni passati ad accompagnare le persone che ristagnano in crisi da cui fanno fatica a uscire, che uno degli elementi chiave che alimenta questo sentimento sia la nostra pervicace resistenza al cambiamento, che è paura del nuovo, di ciò che non conosciamo. L’uomo è un essere abitudinario ed è in genere molto sospettoso verso quelle strade che non sono mai state battute. Inoltre, il desiderio di ritornare a un passato idealizzato può essere alimentato dalla percezione di un mondo come quello in cui viviamo, complesso e frenetico, dove la rapidità dei cambiamenti sociali, tecnologici ed economici può generare un senso di smarrimento e di perdita di controllo. Allora la nostalgia diventa una via di fuga, una scappatoia verso un passato idealizzato in cui le cose sembravano più semplici e meno traumatiche.
Se avessi una bacchetta magica e dessi a qualcuno la possibilità di vivere nel passato, chi lo accetterebbe? Chi tornerebbe a vivere nel tempo in cui, prima della scoperta della penicillina e degli antibiotici, bastava un’infezione per andare all’altro mondo? Quando si doveva fare i conti ogni giorno con carestie, guerre e pestilenze, e la mortalità infantile falcidiava quasi tutte le famiglie? Non credo che lo faremmo a cuor leggero. Se c’è una nostalgia che dovremmo alimentare è quella del futuro. «La nostalgia del futuro non è il dolore di una perdita, ma l’inquietudine del “non ancora”, che mi induce a non accontentarmi delle cose come stanno, come il passato me le ha consegnate. La nostalgia del futuro è la chiamata a non accontentarmi: mi fa vivere per inquietudine e non per abitudine» (D’Avenia, Ivi). Insomma, finché si è inquieti, si può stare tranquilli. La vita diventa invivibile solo quando è tetra ripetizione ed è bella quando è novità che si schiude alla speranza. Ma bisogna venire a patti con l’inevitabile e imparare ad accogliere l’incertezza.
Chi impara ad amare l’incertezza trova la chiave per la serenità. E la serenità, a differenza della felicità – che è uno stato d’animo passeggero e vulnerabile a troppi fattori esterni e che non dipendono da noi –, è uno stato d’animo più stabile e duraturo, ma soprattutto che dipende da noi, dal nostro modo di scegliere che cosa fare con quello che ci accade e dalla cura che mettiamo nel coltivare il nostro mondo interiore. Che sia questo uno dei segreti per la saggezza del cuore?
Tempus fugit, dicevano i romani: il tempo ci scorre tra le mani come sabbia e nessuno ce lo restituirà alla fine della vita, per questo è saggio imparare a vivere bene e con gusto ogni attimo donato. Questa è la consapevolezza: stare qui, ora, senza scappare. C’è forse tristezza peggiore che arrivare alla fine della vita e accorgersi di non aver vissuto? La cosa più preziosa che abbiamo è il tempo che ci è donato: non sprechiamolo a lamentarci di come si stava meglio quando si stava peggio, annegando nei rimpianti e nell’inverno del nostro scontento. Non si diventa vecchi perché passano gli anni, semmai si diventa più anziani: si è vecchi davvero solo quando i rimpianti superano i sogni. Accogliamo allora l’esortazione perentoria di Seneca: protinus vive, «vivi subito», immediatamente, senza indugio (cfr. La brevità della vita, IX, 1). Che la vita non ti passi accanto senza che tu te ne accorga.
Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!