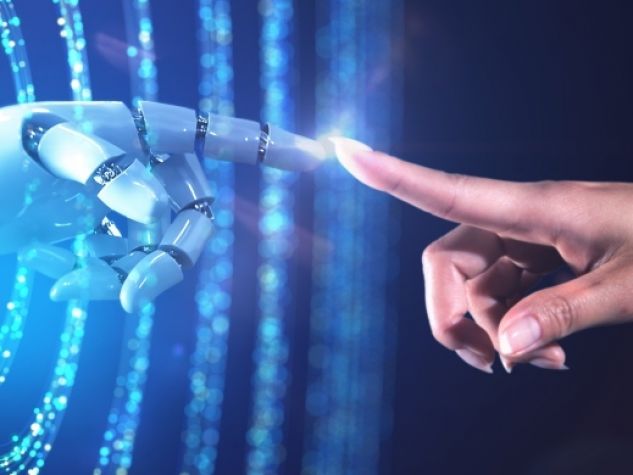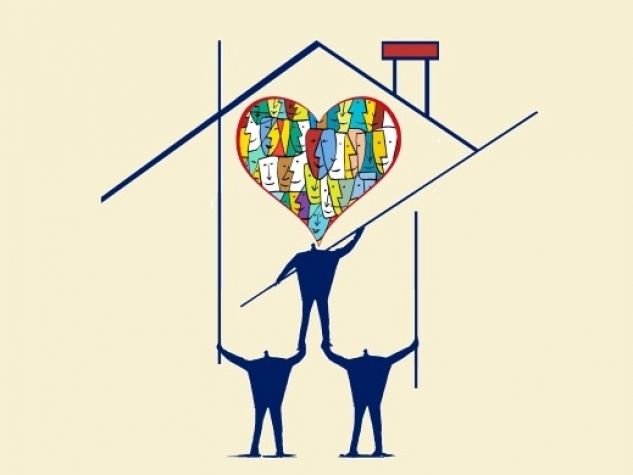Terapia del conflitto (I^ parte)
Adolescenti sempre più violenti, cinici, privi di empatia. È il mondo dei giovanissimi visto con gli occhiali della cronaca: dal quindicenne di Piacenza, accusato di aver gettato dal 7° piano la fidanzatina di 13 anni prima di andare a scuola, alla baby gang di ragazzine che bullizza le coetanee nel centro di Bologna, dai violentatori minorenni della 15enne di Anzio (RM) al diciassettenne di Paderno Dugnano, affascinato dal nazifascismo, che ha sterminato la famiglia perché «voleva essere immortale e vivere in modo libero». A rincarare la dose il Rapporto ESPAD Italia del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, condotto su giovani in età compresa tra i 15 e i 19 anni, testimonianza di una violenza più diffusa, che trascende i casi più eclatanti. ll 40 % (rispetto al 33% del 2019) dei ragazzi ha partecipato a zuffe o risse nel 2023 e il 12% ha preso parte a violenze di gruppo. Il dato insolito è che la violenza riguarda anche le ragazze, coinvolte sempre più spesso in danneggiamenti di oggetti e atti di violenza fisica. Aumentano anche i comportamenti più estremi: il 6,2% degli adolescenti ha danneggiato beni pubblici o privati e il 5,8% ha provocato gravi ferite ad altre persone. Un trend in progressiva ascesa dal 2021, ovvero dall’epoca covid. Ma è davvero questa la piega che ha preso il mondo degli adolescenti? Per capirlo e, soprattutto, per individuare possibili vie d’uscita, abbiamo chiesto l’aiuto del pedagogista Daniele Novara, fondatore del Centro Psicopedagogico per l’Educazione e la Gestione dei Conflitti.
Il primo rilievo mosso da Novara è che questi fatti e questi numeri non descrivono tutto il mondo dell’adolescenza, le sue variabili e le sue potenzialità: «Fatti violenti, eccezionali, ci sono sempre stati, come il caso di Pietro Maso nel 1991 o il delitto di Novi Ligure nel 2001» eppure non sono diventati il marchio di una generazione. A fare da contraltare a questa visione degli adolescenti, c’è un’altra indagine condotta ormai annualmente dall’impresa sociale Con i Bambini e Demopolis: gli intervistati, dai 14 ai 17 anni, mettono ai primi posti tra le cose più importanti la famiglia (80%), l’amicizia (68%), l’amore (60%) e il benessere psicologico (59%), temi che almeno sulla carta smentiscono l’immagine dell’adolescente apatico e insensibile.
Violenza codice dell’oggi
La violenza c’è, monta tra gli adolescenti, ma più che essere un tratto specifico dell’età è una cifra della nostra epoca, «è stata sdoganata in tutti gli ambiti della vita, film, canzoni, videogiochi, linguaggio dei social media e della politica» afferma Novara. Come se non bastasse, gli eventi bellici in Ucraina e a Gaza hanno ulteriormente avvelenato il clima: «Sono tre anni che siamo immersi nella retorica di guerra, che va ad aggiungersi e a rafforzare la normalizzazione della violenza. Come pensare che i ragazzi e le ragazze non ne vengano travolti? Che qualcuno non capisca male?». Una violenza sempre più diffusa e accettata, benché alcuni studiosi non la interpretino tanto come voglia di distruggere quanto «come modo di urlare un dolore che chiede aiuto, riconoscimento, relazione», come affermato dalla Fondazione Patrizio Poletti.
Un urlo che spesso cade nel vuoto, vittima di quella crisi educativa – «voragine» la ribattezza Novara – che inghiotte ormai da decenni il ruolo educativo degli adulti, lasciando gli adolescenti senza punti di riferimento significativi. La prova provata di questo vuoto è il progressivo disinteresse della società verso i temi educativi: «Non fanno audience in tv – spiega Novara – , non sono dentro l’agenda politica. L’ultimo piano politico a favore delle nuove generazioni si colloca tra il 1997 e il 2002 ed è la Legge Turco (la n. 285), che metteva a disposizione dei territori risorse a favore di progetti in sostegno dei diritti dei bambini e delle bambine». Da allora le linee di finanziamento hanno riguardato solo due aspetti, continua il pedagogista: il primo è la «sanitarizzazione dell’infanzia», con l’aumento esponenziale delle neuro certificazioni, per esempio per i disturbi di apprendimento e, il secondo, è la digitalizzazione delle scuole, «che però si è ridotta a una mera introduzione di strumenti digitali nelle classi senza alcuna formazione pedagogica degli insegnanti all’uso di questi strumenti».
Scelte eloquenti, che dimostrano come bambini e adolescenti non abbiano voce in questa società, non abbiano un posto in cui collocarsi, «saltano alla ribalta solo quando commettono qualcosa di grave» commenta il pedagogista. Eppure non è sempre stato così: «L’Italia ha una grande tradizione educativa – continua Novara –, che ha sempre anteposto l’ascolto e l’educazione al giudizio e alla punizione. Oggi invece prevale un atteggiamento securitario, che tende al controllo e alla criminalizzazione, rischiando di indebolire ancora di più i ragazzi e di spingerli verso la devianza». A cosa si deve questa disattenzione verso gli adolescenti e come possiamo riequilibrarla? (Continua...)
Puoi leggere il dossier completo nel numero di aprile del «Messaggero di sant'Antonio» o nella versione digitale della rivista. Provala ora!