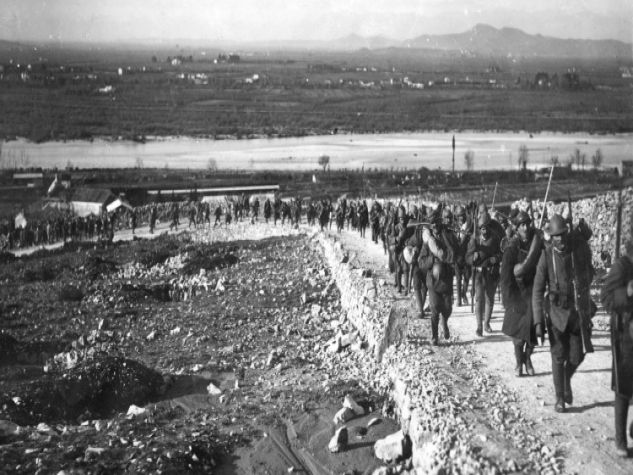Covid 19, un lustro di rimozioni
Cinque anni sono tanti o sono pochi? Una volta, per indicarli usavamo la parola lustro che richiama un rito di purificazione dell’antica Roma. Oggi questo termine suona desueto, ma la saggezza del passato qualcosa, comunque, ci tramanda: un lustro può essere un tempo ragionevole per fare il bilancio di un’esperienza. Cinque anni fa eravamo sottoposti a una prova durissima, sconvolti da una terribile pandemia che solo nel nostro Paese ha mietuto ufficialmente 197mila vittime, forse di più in base al calcolo della cosiddetta mortalità in eccesso. Eravamo chiusi nelle nostre case, alle prese con divieti difficili da accettare, alcuni distrutti da lutti familiari, tutti segnati da paura e inquietudine. Dovevamo fare i conti con una malattia misteriosa, il covid-19, di cui poche settimane prima non immaginavamo nemmeno l’esistenza. Ma oggi, nel 2025, siamo riusciti a farlo questo bilancio?
Al netto di encomiabili eccezioni, possiamo pacatamente dire di no. Non c’è stato un vero dibattito pubblico che abbia coinvolto la cittadinanza. L’elaborazione del trauma non è avvenuta. Si sa che i meccanismi della rimozione sono potenti, qualcuno ha i ricordi «totalmente annebbiati», quasi che la vicenda fosse solo un incubo da allontanare. Personalmente avrei voluto saperne di più su quanto accaduto ad esempio nelle case di riposo, dove talvolta è deceduto il 50% degli ospiti, avere poi maggiori informazioni sulle persone colpite dal Long covid, dai danni fisici (in alcuni casi invalidanti) rimasti dopo la fase acuta della malattia. Ma i grandi media non se ne sono mai occupati.
Una cosa su tutte mi pare doveroso segnalare. Com’è stata ripagata l’abnegazione degli operatori sanitari, quelli che cinque anni fa erano in «prima linea»? Li chiamavamo eroi per il loro coraggio e impegno totale. Oggi molti di loro parlano di una «sanità pubblica finita nell’oblio», di «promesse infrante», si sentono dimenticati. D’altronde per la spesa sanitaria trovare fondi sembra sempre più difficile, siamo intorno al 6,2% del Pil, sotto la media dei Paesi occidentali e lontani dalla soglia minima del 7%. In poche parole, la lezione è stata disattesa, non ne siamo «usciti migliori».
E quando si ragiona sulla salute o sulle potenziali epidemie, non ci sono solo le cure a richiedere attenzione. Al di là del numero di letti nelle terapie intensive, ci sono da considerare ricerca scientifica e sistemi di sorveglianza. Qui le notizie più inquietanti arrivano dagli Stati Uniti che per molti decenni hanno svolto un ruolo guida in campo biomedico, attirando ricercatori da tutto il mondo. Ora tutto questo sta bruscamente finendo. L’amministrazione Trump sta operando tagli draconiani ai finanziamenti pubblici agli Istituti nazionali di Sanità, alle Università, ai singoli Stati dell’Unione per un ammontare di decine di miliardi di dollari. Dietro queste operazioni ci sono esigenze di bilancio unite a scelte politico-ideologiche. Il mondo scientifico, trattato come un nemico e falcidiato dai licenziamenti, ha reagito mobilitandosi. In prima fila la rivista «Nature» che ha anche chiesto a 1.600 ricercatori che cosa intendessero fare. Tre su quattro si sono detti pronti a lasciare gli Stati Uniti. Da questa «fuga» potrebbe venire un’opportunità importante per l’Europa, se riuscirà a leggere la sfida per il futuro in termini di sviluppo civile e non solo militare.
Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!