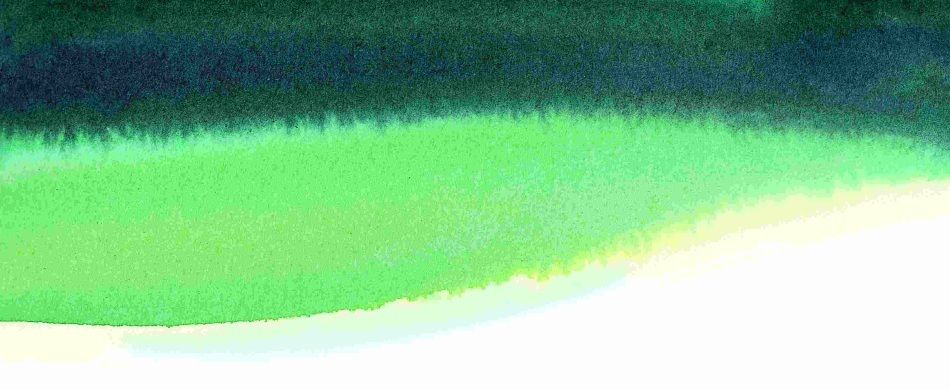L’incontro che vivifica
Di suor Marzia Ceschia
È in una notte di tormenti, tra il 1225 e il 1226, negli ultimi anni della sua vita, che sorge la celebre e luminosa lauda di Francesco d’Assisi. La Compilazione d’Assisi (FF 1614 ss.) ci dà notizia del contesto esistenziale in cui il santo, «a lode di lui [di Dio] e a mia consolazione» (FF 1615), modula questo straordinario canto che ricompone in armonia terra e cielo, creature familiari tra loro, l’uomo e Dio, superando con una totale apertura alla positività dell’universo la disarmonia a cui può tentare la lacerazione del cuore. Francesco in quel tempo è ospite in una celletta a San Damiano, provato nel fisico e nello spirito, tanto da sentire pietà di se stesso. È una profonda consapevolezza a intonare la melodia: il Signore è di più, è superlativo in altezza e potenza, è oltre le nostre definizioni e immaginazioni e l’essere umano non ha facoltà di rinchiuderlo nelle proprie parole. Non è degno di nominarlo, dice Francesco. Soprattutto perché talora accade che lo nomini invano, appropriandosi del nome di «Dio» per ottenere una lode e una gloria che non gli competono.
Sul rischio di un abuso delle parole religiose l’Assisiate mette in guardia i suoi fratelli, ad esempio nella settima ammonizione: «Sono uccisi dalla lettera quei religiosi che non vogliono seguire lo spirito della divina Scrittura, ma piuttosto bramano sapere le sole parole e spiegarle agli altri. E sono vivificati dallo spirito della divina Scrittura coloro che ogni scienza, che sanno e desiderano sapere, non l’attribuiscono al proprio io carnale, ma la restituiscono con la parola e con l’esempio all’altissimo Signore Dio, al quale appartiene ogni bene» (FF 156). Si può saper parlare di Dio, si possono modulare affascinanti discorsi su di lui, compiacendosi anche delle proprie abilità oratorie, ma non essere esistenzialmente toccati dall’averlo incontrato. Si può essere aderenti alla lettera, senza lasciarsi trasformare dallo Spirito. Il santo utilizza toni duri: ne fa una questione di morte e di vita, anzi di «vivificazione», di una vita cioè continuamente alimentata «dall’alto».
Il Dio «Altissimo» di Francesco è tanto più incommensurabile quanto più umile nella sua attitudine a discendere, a chinarsi: riconoscerne l’altezza è, insieme, percepirne la smisurata carità nei confronti delle creature e dell’essere umano in particolare. Dinanzi alle «dimensioni» di Dio l’uomo ridiventa cosciente della sua giusta collocazione e si apre all’esperienza della gratuità e della gratitudine, nella cui espressione – vedremo – culmina il Cantico di frate Sole. L’uomo, che cerca lodi, gloria, onori, davanti all’Altissimo assume altri criteri di valutazione e di valore: qual è infatti la potenza del Signore? In che modo si manifesta la sua bontà? Qual è la sua gloria? Francesco ha soprattutto davanti allo sguardo interiore l’«Alto e glorioso Dio» (FF 276) contemplato sulla Croce.
La meditazione del volto di Dio ha accompagnato tutto il cammino di Francesco – anche lui in gioventù ambizioso di illusorie grandezze – convertito dall’esperienza di essere raggiunto dal Signore in pura carità e misericordia. È «lo stesso Altissimo», ricorda nel suo Testamento (FF 116), che gli rivela «che dovevo vivere secondo la forma del santo Vangelo». «Dall’alto» tutto assume un’altra consistenza, un’altra solidità, perché «dall’alto» si nasce per vedere il Regno di Dio, ha detto Gesù a Nicodemo (cf. Gv 3,1-21). È l’Altissimo a garantire l’amore, la bontà, la bellezza, la giustizia – tutti gli attributi che Francesco riconosce al Signore nelle Lodi di Dio Altissimo (FF 261) – disinteressate, stabili, incondizionate.
«Dal basso» l’uomo facilmente pensa secondo le proprie convenienze, cercando più che il dono l’appagamento, stimando spesso il buono e il giusto secondo i suoi bisogni. Dall’Altissimo si spalanca un universo nel quale non può cessare di donarsi e di donare e di attirare l’uomo in questo dinamismo, in questo modo di essere, di agire, di vedere. «Ogni giorno – riconosce Francesco, prima di intonare il Cantico – usiamo delle creature e senza di loro non possiamo vivere, e in esse il genere umano molto offende il Creatore. E ogni giorno ci mostriamo ingrati per questo grande beneficio, e non ne diamo lode, come dovremmo, al nostro Creatore e datore di ogni bene» (FF 1615). Il mondo è lo spartito della carità di Dio: Francesco lo canta e ne fa continua memoria, quasi a ricordare che sta a noi non soffocare nei nostri egoismi la possibilità di ascoltarne la voce e degnamente di risponderle.
Chi parla?
La voce del Cantico è la voce più propria, più espressiva e connotante la personalità unica di Francesco. Ma, al tempo stesso, è voce del mondo intero, della creazione.
di Davide Rondoni
Di chi è la voce che parla, che inizia con questo strapiombo, questo precipizio... Altissimu... Con tale «U» che unisce il dialetto umbro e particolare all’abisso dei cieli e dei cuori, abisso universale in cui l’essere umano si perde e si ritrova... Chi parla nella voce del Cantico di Francesco ? Lui, certo, il minore, il piccolino, il faccia a terra che si sente sovrastare da tutto, e dal Tutto che è Lui, l’Altissimu. Francesco, è noto, aveva talenti e doti, oltre che ricchezza. E orgoglio. E sognava, dunque, anche per questi segni, di diventare ancora piu grande e ricco e forte. Un principe. Un uomo che sale in altezza. E invece sprofonda, si spoglia, si denuda e diviene terra, tremore della terra. Ma non lo fa per banale umiliazione, per quella forza di disprezzo di se stessi che è terribile e speculare e simile al peggiore orgoglio... Lo fa perché a un certo punto della vita, per conversione e non solo per deduzione, comprende che la grandezza umana, la vera grandezza umana sta nell’indicare Chi è l’Altissimu. Chi è il Re. E dunque come un vero principe del vero Re, Francesco diventa grande, così grande, stragrande che la sua voce non si distingue più da quella di tutto il mondo, dell’universo intero. Altissimu, mormora il poeta santo umbro, e con lui e in lui l’universo che riconosce, attraverso il suo Principe il suo vero Re.
Non si capisce nulla, nulla di Francesco, senza avvertire il precipizio, senza sentire nelle vertebre e nel cuore la differenza di potenziale che fa scoccare anche la scintilla del Cantico. Ma domandiamoci ancora: chi parla nella voce che dice «Altissimu» e a tale ente riconosce che le lodi (quelle che si fanno ad altri, ad altro, magari al medesimo Francesco) in realtà sono «sue», come sua è ogni gloria e benedizione? Quale voce lega la «A» dell’apertura iniziale, dalla vocalità stessa, la «A» di alba, di amore, di andiamo, a quella finale e infinita «U» dell’abisso, abisso dei cieli e del segreto? Dalla «A» che è apertura del mondo, del vivente, alla «U» che è la tenebrosa e lucente prospettiva del mistero... La voce del Cantico è quella di un «Io» preciso, storico, esperienziale, limitato, puntuale. Ma al tempo stesso la sua perentoria uscita dal silenzio, la sua forza trascinante, barbara e cristiana, latina e italica, mette in scena la Voce del creato intero, dell’Universo mondo. Questa è la proprietà della voce poetica quando è espressa al massimo livello. E indubbiamente, Francesco ha una forza estetica e poetica che gli viene dalla cultura e da quei canti e poesie che certamente gli recitava la madre, la francese, (e da qui il suo stesso nome, figlio della francese), proveniente dalla terra dei Trovatori.
Lui stesso, dicono le biografie, canticchiava in francese e non a caso amava le allodole, les alouettes, simbolo dell’anima che canta nascosta nel crepuscolo dell’alba, simbolo della poesia stessa nella tradizione trobadorica. Da quei poeti che cantavano l’amore altissimo e lontano, l’amore struggente per una donna non in loro possesso (perché l’amore non è possesso, ma povertà), Francesco assume probabilmente una vocazione poetica – non una vocazione alla dottrina o alla cultura libresca che infatti guarda sempre con un certo sospetto –. Tale vocazione fa in modo che la prosa ritmica e cantabile del Cantico, che dunque è poesia latu sensu, sia tutt’altro che un’opera ingenua e casuale.
L’avvio, ecco, ad esempio, ci offre già la dimostrazione di uno dei paradossi attraverso cui costruisce il suo senso. La poesia, al suo massimo grado di realizzazione, infatti, dice Ungaretti è «un grido unanime». La voce del poeta dice la vita, o meglio, la fa parlare, attraverso gli elementi della sua biografia ovviamente, ma depurati da ciò è parziale o privo di valore che tende all’universale. Perciò la voce del Cantico è al tempo stesso la voce più propria, più espressiva e connotante la personalità unica di Francesco, ma, al tempo stesso, è voce del mondo intero, della creazione. Non a caso lui consegna tale testo cantabile ai suoi frati, perché lo cantino sempre, sua eredità e dono al mondo. E lo fa proprio mentre anch’egli diventa terra, mentre, morendo, diviene anche materiale del mondo non solo anima in cielo. Sta facendo corpo col mondo. Corpo e voce. Risorgeranno quel corpo e quella voce unica, ma intanto cantano, vibranti nella intera creazione. E quel’Altissimo che nessun uomo può, biblicamente, menzionare a vanvera, diventa così la prima parola del mondo, come a rispondere alla parola, al Verbo, che lo ha generato.
In lode alle erbe spontanee
«E andando, passò davanti alla sua vigna; e già dal di fuori potè subito argomentare in che stato la fosse. […] se qualcosa si vedeva, era tutta roba venuta in sua assenza. S’affacciò all’apertura […]; diede un’occhiata in giro: povera vigna!» (Alessandro Manzoni, I promessi sposi, cap. XXXIII)
«[…] E ordina che l’ortolano lasci incolti i confini attorno all’orto, affinché a suo tempo il verde delle erbe e lo splendore dei fiori cantino quanto è bello il Padre di tutto il creato». (da Vita Seconda di Tommaso da Celano, FF 750)
Laudato si’, Signore mio, per l’erbe Che tutt’intorno all’orto stan crescendo Spontanee, così che le coltivi – E che la varietà possa stupire –, Signore. Vorrei quasi dedicare Un fazzoletto d’orto per codeste
Che son qui per incantare, Signore, Son qui per dimostrar che cosa nasce Se non restiamo ad ordinar le cose, In vece di ridare a questa vigna La sterile bellezza del Giardino: Lasciare che il selvatico dilaghi
E d’ogni velenosa pianta il nome Conoscere per farle un posto in cuore. Laudato si’, Signore, per quest’erbe Che dànno cognizione di Natura – E dai sistemi c’è liberazione… –, Laudato, sì, davvero, mio Signore.
Paolo Pera
Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!