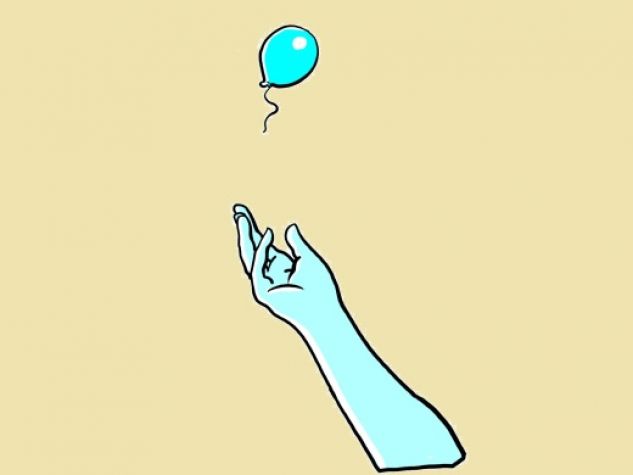Mortali eppure empatici
L’uomo è l’unico animale che sa di dover morire, avendo preso le distanze dalla specie per valorizzare l’individualità. Per questo egli sta, davanti alla morte, nel turbamento e nell’orrore, sia per la decomposizione dei corpi, sia soprattutto per la perdita dell’io. Edgar Morin, in L’uomo e la morte, parla a tal proposito di un trauma che accompagna la consapevolezza umana della morte. L’uomo prova quindi un fondamentale «disadattamento» di fronte alla morte, che lo ha sempre obbligato, nel corso dei secoli, a cercare strategie di adattamento, anche se sempre parziali e non del tutto appaganti.
Benché l’orrore e lo sgomento siano dati antropologici, si può verificare che, quando la dimensione collettiva prende il sopravvento sull’individuo, si attenui anche la paura di morire. È il caso della guerra, che provoca un mutamento nella coscienza della morte. È come se la società in guerra tornasse a essere una specie biologica: fuso nel suo gruppo in pericolo o in marcia, il combattente, l’assediato, il crociato, hanno meno paura. Se tale mitigazione dell’angoscia di morte non ci fosse, sarebbero tutti dei disertori. La guerra – scrive Morin – induce una «regressione generale della coscienza» che affievolisce la paura. Tuttavia, ogni volta che riesce a riemergere la dimensione dell’io, anche durante una guerra, la coscienza della morte e il dolore che l’accompagna tornano ad acuirsi. Viene in mente Erich Maria Remarque e il suo Niente di nuovo sul fronte occidentale. Quando il protagonista arriva a casa per una licenza, e riprende a sentirsi uomo e individuo, qualcosa si spezza dentro di lui. «Non avrei mai dovuto venire qui. Laggiù ero indifferente, spesso senza speranza: non potrò mai più sentirmi così. Ero un soldato, e ora sono solo un grumo di dolore: per me, per mia madre, per tutta questa desolazione senza fine. Non avrei mai dovuto venire in licenza».
Da queste brevi riflessioni emerge un quesito che vale la pena porsi, per quanto arduo: la consapevolezza della morte, l’angoscia esistenziale, la comprensione della fragilità dell’uomo, la compassione nei confronti propri e altrui, possono essere seme di pace, possono indurre una repulsione della violenza? E di conseguenza: val la pena lavorare per costruire una cultura che faciliti il dialogo sulla mortalità e un linguaggio condiviso per poter elaborare nuove interpretazioni e pensieri?
Il rapporto dell’uomo con la morte è estremamente complesso: a volte, in modo semplificatorio, si parla di rimozione a proposito della nostra cultura. Indubbiamente vi sono stati, nel corso del Novecento, una serie di fattori storici e culturali che hanno modificato la nostra relazione con il morire. L’aspettativa di vita è notevolmente aumentata, la medicina ha fatto progressi inediti, ha salvato vite, così che nella maggior parte dei casi la morte, quando era inesorabile, è sopraggiunta in ospedale, lontana dalle case e dalle comunità, con il controllo della medicina, che abbiamo delegato a gestire la morte. È quindi accaduto che l’interpretazione biomedica della morte, come evento biologico e istantaneo (il decesso) abbia offuscato la complessità del processo del morire, che è al contempo fisico, psicologico, sociale, culturale e spirituale. E noi abbiamo interiorizzato tale lettura, perdendo i saperi e le parole che ci aiutavano a fronteggiare la morte. Il filosofo esistenzialista Vladimir Jankélévitch scrive infatti che il pensiero non può concentrarsi sull’istante dell’exitus, perché «il pensiero del nulla è un nulla del pensiero».
Oggi, attraverso la cultura delle cure palliative, lentamente (perché conosciute ancora da una minoranza degli italiani) si sta però recuperando parte di quella competenza che avevamo perduto. Dire che la morte fa parte della vita, che è un processo naturale e che è possibile vivere il proprio morire (con il giusto accompagnamento), permette alle persone di lambire con il pensiero la propria morte senza che il pensiero venga per questo annichilito. Il nostro morire non coincide con il momento del decesso: tornare a riflettere sul processo complesso che ci conduce alla morte amplifica anzi la nostra dimensione spirituale.
Ma, soprattutto, in ogni momento della vita, occorre fare i conti con la mortalità, la finitezza. Tale compito ha un risvolto etico rilevante. Se gli uomini fossero immortali, infatti, le azioni di ciascuno avrebbero conseguenze trascurabili rispetto alla totalità dei tempi. In un tempo infinito, come scriveva Borges nel racconto L’immortale, a ogni uomo accadrebbero tutte le cose. La nostra mortalità, il limite, invece, ci rende responsabili per ogni gesto che compiamo. Se offendiamo, se feriamo, se siamo aggressivi, modifichiamo la nostra vita e quella del prossimo, come ben sanno gli orientali quando parlano di karma. Le azioni hanno conseguenze nelle nostre fragili vite. Solo con la consapevolezza della mortalità e della vulnerabilità, nostra e altrui, possiamo orientarci verso la solidarietà e non verso la violenza.
Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!