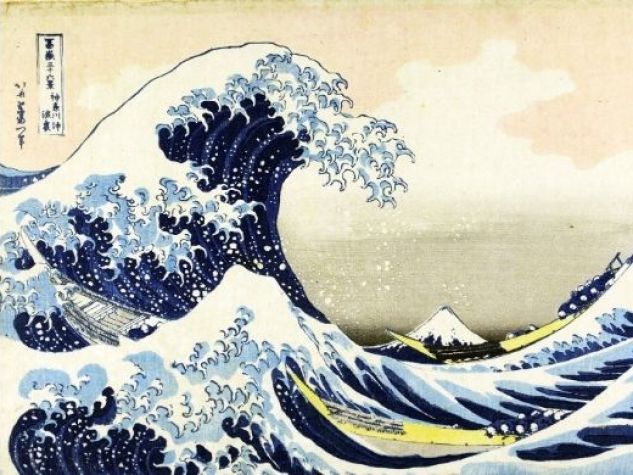Simone Veil, la donna del secolo
Da Auschwitz ai vertici della politica europea: è il percorso di Simone Veil, nata nel 1927 da una famiglia ebrea, sopravvissuta al campo di concentramento ed eletta prima presidente donna del Parlamento europeo dal 1979 al 1982. Ma chi era veramente Simone Veil? E perché la sua figura è divenuta un’icona dei nostri giorni? Lo abbiamo chiesto a Olivier Dahan, regista del biopic dedicato proprio alla statista (Simone Veil – La donna del secolo, interpretato da Elsa Zylberstein e in uscita nelle sale italiane il 30 gennaio), uno che di donne straordinarie se ne intende (ha diretto Marion Cotillard in La Vie en rose nel 2007 e Nicole Kidman in Grace di Monaco nel 2014)...
Msa. Edith Piaf, Grâce di Monaco e ora Simone Veil. Nella sua carriera artistica ha raccontato la storia di donne straordinarie che, ognuna a modo suo e in campi diversi, hanno lasciato il segno. Secondo lei, cosa rende Simone Veil così eccezionale?
Dahn. Simone Veil è eccezionale per la sua resilienza di fronte alla tragedia, per il suo spirito combattivo di fronte all'ingiustizia. Non era una politica, ma ha usato la politica per restituire umanità e dignità alle persone. Il mio film non si limita a ritrarre una donna, ma parla del XX secolo e di una parte della storia francese ed europea.
Come è riuscito a rendere attuale una figura del passato, avvicinandola alle nuove generazioni?
Parlando di oggi! Parlando di cose universali come il rapporto con la madre, la resistenza alle ingiustizie, parlando del fatto che la politica dovrebbe essere al servizio del popolo e non di chi la fa. Parlando di trasmissione, di memoria... essendo sincero nel mio proposito.
Sull'Olocausto sono stati realizzati tantissimi film, come si fa a parlarne senza correre il rischio di risultare «ripetitivi»?
In Francia c'è sempre la tendenza a «censurare» questo argomento. Ho dovuto lottare per mantenere alcune scene dei campi di concentramento, ad esempio. La stampa francese mi ha accusato di aver rappresentato la Shoah in modo troppo diretto... in realtà non è la forma a disturbare, ma il contenuto. Mia nonna non aveva paura dei nazisti, ma della polizia francese e del silenzio del dopoguerra sul tema dei campi. Come non essere ripetitivi sull'Olocausto è una domanda che non ci si pone per nessun altro soggetto cinematografico. Il fastidio di alcune persone per «l'ennesimo film sulla Shoah» è indicativo dei loro sentimenti sull'argomento. Detto questo, il mio film non parla dell'Olocausto, ma delle conseguenze del trauma e soprattutto del passaggio dalla storia familiare alla Storia. Una volta che gli ultimi sopravvissuti sono invecchiati e morti, l'affetto personale svanisce e la Storia se ne occupa in modo più freddo. Il che è normale, perché noi non viviamo nel passato. Cinquecento anni dopo, nessuno piange i morti (della strage) di San Bartolomeo. Questa è la Storia.
Come si è preparato alla realizzazione del film?
Facendo ricerche e ascoltando le mie intuizioni.
In che misura gli eventi attuali, in particolare le guerre in Ucraina e in Medio Oriente, hanno influenzato la creazione del suo film?
Ho realizzato il film prima di queste due guerre (anche se in Italia la pellicola esce nelle sale il 30 gennaio, in Francia è uscita nel 2022, ndr). Non so come l'avrei fatto dopo. In modo diverso su alcuni punti, credo. Ma non nell’essenziale. Il film evoca le guerre in Jugoslavia e in Algeria. Le guerre, indipendentemente dalle ragioni politiche, sono sempre della stessa natura.
Qual è stata la difficoltà maggiore che ha incontrato durante le riprese?
Lo scorrere del tempo. Alcune volte abbiamo esaurito il tempo a disposizione. Ma questo vale per tutti i film. Per me la cosa più importante non sono le riprese, ma il montaggio. È lì che bisogna porsi le domande. Le riprese sono una sorta di copia dell'arte teatrale. Il montaggio è una grammatica, un linguaggio universale. È il cuore del cinema. La sua singolarità.
Che ruolo ha la fede nella vita di Simone Veil e nel suo film?
La fede negli esseri umani ha avuto un ruolo fondamentale nella sua vita, credo. Una fede senza cecità.
In questo anno giubilare, cosa significa per lei il termine speranza? E per la protagonista del suo film? Possiamo definire Simone Veil un'ambasciatrice di speranza?
La speranza deve essere azione. Non attesa. Veil combatte sperando di avere successo. È stata un'ambasciatrice della lotta... e quindi della speranza.
Ha qualche nuovo progetto in cantiere?
Nana di Emile Zola, in una versione che tratterà della sottomissione delle donne e, più in generale, dello sfruttamento delle classi sociali più povere.
Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!