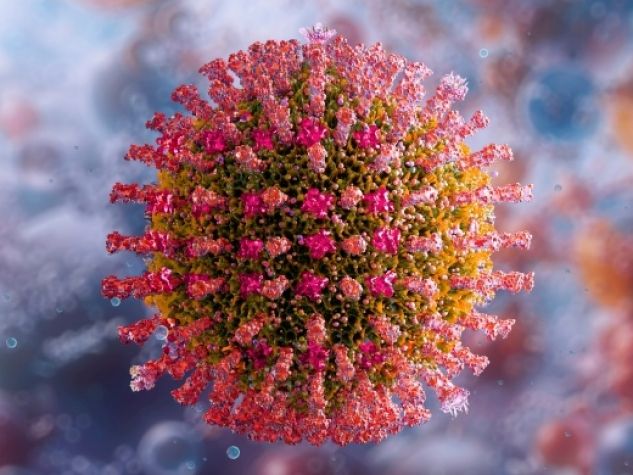«Produci, Consuma, Crepa»
Quando, nel 2019, lessi questa scritta su un muro scalcinato di Firenze, la mia città, provai un certo sbigottimento, un’inquietudine che mi avvolse come una nebbia maligna. Certo, l’autore voleva provocare una reazione, e forse senza neanche essere così consapevole della portata di questa provocazione. Su di me ebbe un forte impatto e mi suscitò non pochi interrogativi. Veniamo al mondo senza averlo chiesto e senza sapere perché, vivacchiamo senza farci troppe domande e moriamo spesso senza accorgerci di aver vissuto. Ma la vita è tutta qui? Davvero siamo al mondo solo per produrre, consumare e crepare? Credo che ognuno di noi provi un’istintiva avversione per questo oscuro presagio. La verità è che non siamo fatti per così poco, per vivere solo di briciole e di qualche sporadico contentino.
Credo che siamo arrivati a un bivio della storia: da un lato ci sono coloro che credono che nulla abbia senso, dall’altro quelli che intravedono un senso in ogni parola, in ogni gesto, in ogni accadimento quotidiano. Al momento i seguaci del nulla sembrano più numerosi. Di fatto siamo sommersi da forme di nichilismo pratico e accidioso che propagano un veleno molto contagioso: il veleno dell’insensatezza, dell’impotenza e del cinismo, ben rappresentato dalla scritta anonima sul muro, più scalcinato dei nostri sogni. Questa cultura nichilista e accidiosa, dove accidia è soprattutto incapacità di abitare la propria vita – quello che Montale, con un verso prodigioso, riassumerebbe in «spesso il male di vivere ho incontrato» –, ha tutto l’interesse che gli uomini non pensino, non riflettano sulla loro precarietà e mortalità e passino piuttosto il tempo ad alienarsi nei grandi centri commerciali. Perché farsi domande sul senso della vita? Meglio chiedersi qual è la compagnia telefonica più conveniente o intontirsi davanti alle vetrine dei negozi. Questa cultura nichilista ha bisogno di esseri umani tristi, depressi e famelici. Perché questa configurazione antropologica è la più funzionale al consumo: più sei triste e angosciato, e quindi famelico, e più compri. Perché la pancia dell’anima la devi riempire con qualcosa, dal momento che la fame resta (Cfr. S. Olianti, Di fronte alla morte impara la vita. Per un’etica della speranza, Emp).
Noi occidentali passiamo gran parte della vita ad accumulare beni, conoscenze e, da quando esiste internet, anche relazioni. Facciamo a gara a chi ha di più: a chi possiede più soldi, più prestigio e più potere, più like. I saggi, i santi dell’Oriente e dell’Occidente hanno sempre fatto a gara, invece, a chi aveva di meno: volevano «essere». Solamente «essere» e pienamente consapevoli di «essere vivi». Cercavano la privazione, il distacco, la decostruzione dell’ego per vivere la libertà interiore che questi atteggiamenti potevano concedere. Accumulare, volere sempre di più non è solo quel peccato grave che san Paolo chiama pleonexia, ma anche una patologia, un disturbo psichico di tipo ossessivo compulsivo. Anch’io devo confessare che ho passato gran parte della mia vita ad accumulare, soprattutto cose che per me hanno un valore emotivo: libri, oggetti regalati da persone a cui sono affezionato, vestiti che ho indossato per anni e che mi ricordano incontri, esperienze e persone amate.
Eppure, se non si è capaci di potare non può nascere il nuovo. Tanti anni di pratica meditativa mi hanno insegnato che l’attaccamento genera solo sofferenza e che bisogna imparare a lasciar andare, ad andare nella direzione del «meno», della leggerezza: meno arrovellamenti, meno attaccamento, meno bisogno di controllare tutto. Bisogna svuotarsi per essere riempiti, farsi cavità per ricevere. Questa povertà di cose, questa semplicità nell’affrontare la vita ci apre alla novità, all’imprevedibile che talvolta ci stupisce e ci rinfranca. La diminuzione dei bisogni, e il rendere essenziale solo ciò che serve, permette di dare un valore diverso alle piccole cose quotidiane e ci rende più sensibili alla gratitudine. Credere di possedere ci espone al rischio di essere posseduti. Bisogna vigilare molto su di sé per non perdere la libertà interiore.
Spesso, quando mi capita di essere divorato da un impulso di sfrenata avidità, mi chiedo: che cosa mi manca davvero, qui e adesso? Non ci mancano molte cose in fin dei conti, eppure la nostra immaginazione ci porta sempre a focalizzare ciò che non c’è o ciò che potremmo fare per avere di più. Il fatto è che il di più non ci basta mai. Liberarci dai lacci dell’ego, subdoli e persistenti: non è forse questo uno degli aspetti più importanti della crescita umana e spirituale? Eppure, in nessun manuale di pedagogia ho trovato scritto quanto sia importante educare alla semplificazione, parola che ha una radice etimologica molto bella: togliere pieghe alla realtà.
Quanto importante è saper potare, per far fiorire la vita! Prendersi cura della nostra formazione spirituale e ascetica, incrementando qualità come la sobrietà, la vigilanza, l’altruismo, la compassione. Quale genitore si sognerebbe di educare il proprio figlio alla povertà? Non alla miseria, che umilia e mortifica i sogni, ma alla povertà, alla sobrietà, alla condivisione con chi ha meno? Eppure la pace comincia da qui: dal non voler accumulare. Come ci ricorda Gandhi, in questo meraviglioso pianeta ci sono abbastanza risorse per i bisogni di tutti, non per l’ingordigia di tutti. Nessun bene materiale, per quanto importante, potrà mai soddisfare le aspirazioni del cuore. La semplicità interiore è una delle virtù cardinali nella pratica spirituale; la povertà di spirito, una condizione essenziale per entrare nel regno dei cieli (Cfr. S. Olianti, Fai fiorire la vita, Emp).
In questi tempi convulsi e frenetici abbiamo smesso di cantare il Te Deum, il canto di gratitudine a chi ci ha donato la vita, per arrovellarci in uno sterile e puerile Me deum. Facciamo nostro, allora, il motto di H. D. Thoreau: «Semplificare, semplificare, semplificare». Perché la felicità non la si incontra nell’accumulare e nel consumare senza freni, ma solo nella condivisione e nella gioia del dono.
Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!