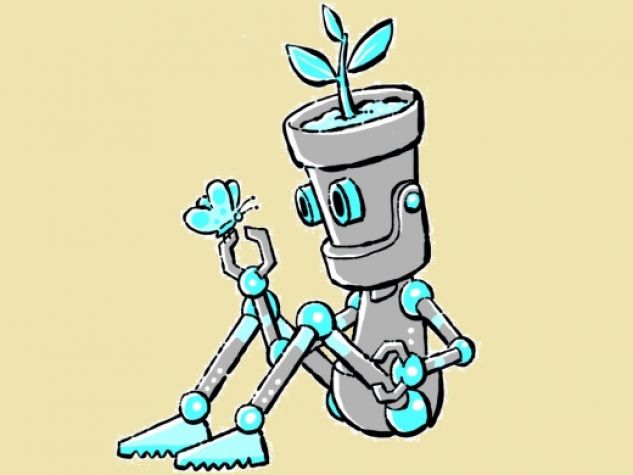Cioccolato ed emozioni
Arturo Brachetti è il più grande trasformista al mondo. Lo spettacolo dal titolo «Solo», il cui tour si appresta a varcare i confini nazionali (www.brachetti.com), è un varietà magico e surreale, molto autobiografico, in cui porta in scena il Peter Pan che è in lui, che vuole continuare a volare mentre la sua ombra, interpretata da Kevin Michael Moore, vuole tenerlo a terra. Nello spettacolo, dal ritmo incalzante, ogni venti secondi c’è una sorpresa. «C’è il trasformismo, ma anche le ombre cinesi, una lotta con i raggi laser, il disegno sulla sabbia; poi volo, tutto in 90 minuti, non c’è la possibilità di annoiarsi», assicura Brachetti. «In scena porto più di 60 personaggi. Dalle fiabe alle serie tv, fino ai grandi miti della musica pop. Un po’ un viaggio nella mia storia, ma anche in quella del pubblico».
Msa. Cos’ha fatto scattare in lei la molla per cui ha intrapreso la carriera di attore e di trasformista? E perché è stato determinante don Silvio Mantelli nella sua formazione?
Brachetti. Da ragazzo i miei genitori mi mandarono in seminario perché ero un bambino buono e timido. Lì incontrai don Silvio Mantelli, il «Mago Sales», che mi insegnò i primi giochi di prestigio e mi aprì un mondo. Mi diede la chiave della sua stanza dei trucchi, e io passavo ore a leggere e cercare di imparare, finché non mi regalò un libro su Fregoli. Quello fu il punto di svolta perché capii che indossando altri abiti riuscivo a sconfiggere la timidezza. Inoltre, avevo un potere speciale: quello di stupire le persone. Mi resi conto di non avere la vocazione, e lo confidai a don Silvio. Lui mi rassicurò dicendomi: «Non è importante avere “la” vocazione, ma è importante avere “una” vocazione». È un messaggio che non ho più dimenticato, e che tutt’oggi mi guida perché ancora adesso vivo il mio lavoro come una missione. Ho 65 anni. Non fumo, non bevo, faccio la dieta e vado in palestra. Niente dolci, solo il cioccolato fondente. Sono sacrifici, ma la mia missione è trasmettere emozioni.
Quando disse ai suoi familiari: «Da grande farò l’attore», come la presero?
Mio padre sperava per me un futuro diverso, forse da sacerdote o, al massimo, in linea con la storia della famiglia: mio nonno era operaio alla Fiat, mio papà impiegato alla Fiat. Mia mamma, invece, mi ha sempre supportato. Fu lei ad aiutarmi a cucire i primi costumi. Ancora oggi mi sostiene, mi accompagna in qualche data del tour, mi incoraggia, dialoga con i miei fan sui social. È scatenatissima a 86 anni, è una vera forza.
Quali valori sono sempre stati per lei un punto di riferimento nella sua vita e nel suo lavoro, in un mondo come quello dello spettacolo in cui, talvolta, successo, fama e denaro sono spesso traguardi raggiunti in modo esasperato?
Credo che rispetto al mondo dello spettacolo ci siano molti luoghi comuni. Il mondo dello spettacolo è un lavoro, un settore professionale a tutti gli effetti, fatto di professionisti e gente capace e, come in tutti gli ambiti, anche di persone meno competenti. C’è tanta gavetta, lavoro, fatica, passione. Vuol dire anche fare le prove di notte in teatri non riscaldati in pieno inverno, o percorrere chilometri per un provino, per esempio. Limitarsi a parlare di mondo dello spettacolo in termini di successo facile, è estremamente pericoloso perché restituisce un’immagine non veritiera. Mentre è un settore produttivo esattamente come gli altri.
I ragazzi di oggi sognano di diventare influencer dal guadagno facile, o di sfondare nel mondo dello spettacolo, magari senza fare gavetta, oppure sperano di diventare dei campioni multimilionari dello sport. Che adulti rischiamo di ritrovarci?
I giovani, come in ogni epoca, non sono tutti uguali. Ci sono quelli che cercano il successo facile, ma ci sono quelli che si preparano, studiano e discutono. Certamente la tecnologia ci ha cambiati, non solo i giovani, ma un po’ tutti. Abbiamo il mondo a portata di mano in un telefono, rischiamo di non stimolare la nostra curiosità.
Che consiglio darebbe a un giovane che volesse intraprendere la sua carriera?
A tutti i ragazzi dico sempre di leggere, studiare e non fermarsi ai video su internet. A volte vengono dei giovani illusionisti in camerino e mi mostrano un trucco che già si faceva duecento anni fa, solo che non si sono presi la briga di documentarsi. La nostra testa è come un giardino, dobbiamo continuamente piantare dei semi se vogliamo che fiorisca. E i semi sono le cose che vediamo, le mostre che visitiamo, i libri, ecc. Se piantiamo tanti semi, prima o poi germoglieranno.
È vero che il successo la deprime? Si dice che i più grandi artisti siano tendenzialmente malinconici.
La mia esperienza personale è legata a un momento di grande successo. Ero a Parigi, teatri sempre pieni, lunghi applausi, ma io la notte dormivo male e mi rendevo conto di essere agitato. Sono andato da uno psicologo che mi ha spiegato che il mio malessere era dovuto al fatto di aver raggiunto la mia meta. Dovevo scendere dalla cima della montagna e trovare un’altra meta da raggiungere. Così ho fatto, e ancora oggi mi pongo sempre nuovi traguardi. Per esempio, di recente mi sono cimentato nell’opera, un ambito che non avevo mai realmente esplorato. Dopo il tour andrò a Montecarlo per lavorare con Cecilia Bartoli al Barbiere di Siviglia che abbiamo già portato in scena a Salisburgo, l’estate scorsa, con grandissimo successo. Una bellissima regia di Rolando Villazón.
Prima di entrare in scena, fa qualche gesto «scaramantico» particolare oppure un innocuo «rito propiziatorio»?
Non sono superstizioso. Ho la mia routine prima di prepararmi, ma non ha nulla a che fare con la scaramanzia, è solo il tempo necessario per prepararsi e proporre al pubblico solo il meglio, ogni sera.
Per un trasformista, nulla o quasi può essere lasciato al caso. E lo spettacolo diventa come un sofisticato congegno in cui ogni azione scenica deve essere precisa e calibrata.
Lo spettacolo ha un ritmo frenetico, gli assistenti che mi toccano nei cambi d’abito sono due, e spesso ci diamo anche delle grandi gomitate senza farlo apposta. Esattamente come capita in un cambio di gomme nel box di una Ferrari. Piccoli incidenti sul palcoscenico accadono di frequente. Non sempre il pubblico se ne accorge, magari manca un dettaglio e devo ancora finire di vestirmi, ma mezzo corpo è già in scena. Una volta sono caduto nella buca dell’orchestra e mi sono rotto un braccio. Volevano tenermi fermo per due mesi, ma ho trovato un chirurgo bravissimo che mi ha messo due viti, e dopo dieci giorni ero già di nuovo in teatro.
C’è un aneddoto, un imprevisto, un’inattesa soddisfazione oppure un incontro eccezionale che può raccontarci?
Sarebbero tantissimi. Mi piace ricordare uno degli ultimi spettacoli prima della pandemia, in Inghilterra, nel secondo teatro più grande del Regno Unito. Enorme. È stato un grandissimo successo, con repliche da tutto esaurito e un pubblico che ancora oggi mi scrive per ringraziarmi delle emozioni di quelle serate.
Qual è il pubblico più esigente che ha dovuto affrontare?
A differenza di quello che si pensa, più si va a Nord, più il pubblico è partecipe, forse perché più controllato nella vita quotidiana, per cui poi quando va a teatro si rilassa e si diverte. Il pubblico più difficile si trova in quelle città in cui il varietà è nella vita quotidiana, e niente può stupire: Napoli, per esempio, che è una città che amo tantissimo. Il suo pubblico è davvero difficile da stupire.
Che sentimenti prova, a fine spettacolo, quando cala il sipario e lei ritorna in camerino?
Mi fa sempre molto piacere quando il pubblico viene in camerino per ringraziarmi. I momenti più belli sono quando mi dicono che gli ho restituito due ore della loro infanzia.
Si sente davvero come Peter Pan?
Sì, ma nel corpo di un 65enne. Cerco di vivere la vita con curiosità, ma non mi stupisco più di nulla. Però mi piace vedere lo stupore negli occhi degli altri.
Il suo sogno nel cassetto?
Tantissimi, il meglio deve ancora venire!
Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!