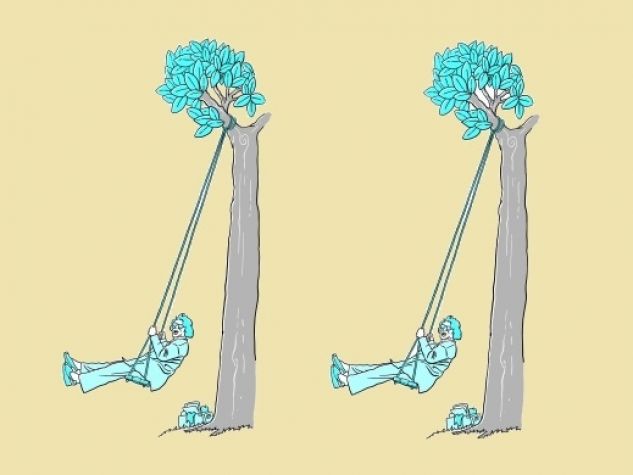Nuovi viaggiatori
C’è un brutto termine che descrive il turismo quando diventa eccessivo, quando stravolge i luoghi e la vita degli abitanti. Il termine è «turistificazione», che suona molto simile a «desertificazione»; e in un certo senso lo è, perché una località presa d’assedio dal turismo di massa si trasforma radicalmente per venire incontro alle esigenze turistiche e a quelle degli stakeholder, cioè di chi ha interesse a vario titolo nello sviluppo dell’attività turistica. Il rischio, però, come vedremo, è perdere «l’anima» e, con il tempo, se non si pongono rimedi, anche il business. Come ogni grande fenomeno, la turistificazione ha dimensioni planetarie, anche se ogni luogo ha la sua, e, come ogni fenomeno complesso, non è classificabile come un bene o un male in assoluto, perché in mezzo ci sono tutta una serie di variabili e di contraddizioni al pari di una matassa spettinata. Uno dei bandoli di questa matassa è capire se il turista, ovvero ciascuno di noi, può ancora permettersi un viaggio che coniughi il rispetto dei luoghi e degli abitanti con l’esperienza dell’autenticità. E ammesso che questa sintesi sia possibile, che tipo di «viaggio» dovremmo ricercare e che turisti dovremmo diventare?
Innanzitutto serve un pizzico di storia. Il turismo è il frutto di una buona notizia e risale a quando viaggiare ha smesso di essere un privilegio per ricchi e aristocratici, come lo era all’epoca del Grand Tour, per diventare una possibilità alla portata di sempre più persone, a partire soprattutto dagli anni ’60. Il turismo «libera» lo spostamento, lo rende democratico, però, man mano che si allarga, rivela anche i lati deteriori: diventa un fenomeno di massa, un business, una merce in un grande mercato, solleticando gli appetiti degli speculatori. Da quella trasformazione alla degenerazione che vediamo oggi, il passo è breve: il turismo è diventato sempre più standard, più incline a sfruttare i territori invece che a valorizzarli, sempre meno attento alle popolazioni locali e alla salvaguardia dei luoghi.
I centri storici di molte città d’arte hanno perso gli abitanti, i negozi di prossimità, le relazioni che plasmavano la vita del posto, per diventare luoghi a misura di turista, con le grandi catene del commercio che si contendono gli edifici storici, con i ristoranti di tendenza, i B&B, i finti negozi di prelibatezze locali. Non va meglio in certe amene località di provincia, prima minacciate dallo spopolamento, oggi spopolate per davvero allo scopo di approfittare del momento di fama, magari creato da un influencer, per far largo agli affitti brevi, alle attività artigiane ricostruite per turisti, al ristorante stellato con prodotti tipici e a chilometro zero, incistato nella vecchia taverna. Archeologia di una vita che fu.
Turisti o viaggiatori
Qualcuno può obiettare che il turista non è il viaggiatore, nell’illusione che il primo solo consuma, mentre il secondo è un cultore dei luoghi; il primo passa, perché ci passano tutti, il secondo passa perché spera che non ci passi nessuno. «In realtà, questi due modi di viaggiare coesistono, a volte addirittura nella vita della stessa persona – afferma Paolo Casetti, geografo e docente di turismo –. Sono anche espressioni del carattere e della formazione delle persone: c’è chi preferisce le mete di massa, perché sono collaudate e confortevoli; al contrario, il viaggiatore che rifugge le masse cerca l’incontro con i luoghi, lo sconosciuto e l’insolito. Una sete di autentico, che spesso autentico non è».
In effetti c’è un problema di fondo, anche per chi si sforza di essere il miglior viaggiatore possibile: «Quando un luogo decide di aprirsi al turismo, anche un piccolo borgo – spiega Casetti – è come se salisse sul palcoscenico, e, mentre lo fa, inevitabilmente cambia, recita una parte, si adegua ai nuovi ospiti. Il turismo esperienziale e sostenibile esiste, nella misura in cui, però, pensiamo alla sostenibilità non come a un calcolo matematico, ma come a un’aspirazione a cui tendere. Una ricerca costante di equilibrio tra sostenibilità economica, ambientale e sociale». Ciò non significa che questo «mettersi in scena» non abbia i suoi lati positivi.
Se la volontà di diventare destinazione turistica è espressione di una partecipazione comunitaria, essa può avere delle ricadute inattese: «Il turismo è un volano economico, ma può anche aiutare le comunità dei borghi e dei luoghi più periferici a scoprire nuove motivazioni per stare insieme, addirittura rispolverando tradizioni e vocazioni locali che altrimenti andrebbero perdute. Per cui, mettendosi in mostra, il borgo si trasforma, ma, trasformandosi, salva la sua identità». Autentico e inautentico diventano permeabili e il turista riesce ad avere un’esperienza sostenibile, il più vicino possibile all’autenticità.
Al contrario, se la ragione economica diventa priorità, trascurando tutti gli altri aspetti, l’incanto del luogo rischia di spezzarsi. È successo a Varenna, un piccolo borgo affacciato sul lago di Como: «Ha avuto un boom improvviso di turisti grazie a un influencer di viaggio. Un fenomeno sempre più diffuso. Così un paese di appena 700 abitanti e 12 km quadrati di estensione ha avuto più di 150mila presenze in un anno. Una popolarità che ha portato il 60, 70% dei residenti ad abbandonare le case per utilizzarle come B&B o come alloggi per affitti brevi. Il risultato è che il turista che va nel borgo in cerca di autenticità trova un via vai di trolley».
Come uscirne? Come sempre se ne esce insieme o non se ne esce affatto, soprattutto in un tempo in cui il turismo mondiale cresce a un ritmo del 5% ogni anno (Organizzazione Mondiale del Turismo). «Innanzitutto è necessaria una gestione locale del turismo – spiega Casetti –. L’amministrazione deve avere un quadro d’insieme e saper prendere le decisioni giuste per regolare i flussi e mantenere la sostenibilità del borgo, per esempio limitando il numero degli alloggi per affitti brevi o gestendo un sistema di prenotazioni. Può non piacere, ma non ci sono molte alternative». Occorre però anche agire sulla comunità: «Come già spiegava Butler nel 1980, ogni destinazione turistica ha un ciclo di vita: se la comunità non sa rinnovare la sua vocazione turistica con nuove idee e iniziative, la destinazione è condannata alla decadenza».
La città ritrovata
Rischio analogo hanno le città d’arte, prese d’assedio nei loro centri storici, ma praticamente ignorate in altre parti ugualmente significative, dove ancora si respira un alto grado di autenticità. Ne dà un esempio eloquente l’associazione Ottavo Colle di Roma. Irene Ranaldi, la fondatrice, prima di essere una guida turistica è una sociologa urbana che ha deciso di rendere visibile l’altra Roma: i quartieri operai come Testaccio, Garbatella, Ostiense, con la loro archeologia industriale, le borgate storiche, istituite durante il fascismo o, ancora, il Quadraro o Tor Marancia, i luoghi della street art: «La mia è una formazione rivolta soprattutto agli abitanti e poi anche ai visitatori. Racconto gli aspetti turistici, ma il vero obiettivo è far incontrare le persone con i locali, le associazioni, i comitati ma anche l’ultima pasticceria antica, ancora in funzione, simbolo di un’eredità. Poi amo raccontare i monumenti umani, non solo quelli di pietra, come don Sardelli, il prete dei baraccati, o don Di Liegro, primo direttore della Caritas diocesana di Roma. È un tentativo di resistere alla gentrificazione e alla turistificazione».
Sulla via della sostenibilità ci sono almeno due ostacoli. Il primo è da parte dei turisti «che tendono a fermarsi agli itinerari più classici o a seguire i suggerimenti degli influencer, che li portano a fare tutti le stesse cose» continua la sociologa urbana. E così si creano file interminabili di fronte alla mostra del Caravaggio o si acquista uno slot di mezz’ora nel ristorante finto tipico, giusto per farsi un selfie. «Chi ha pochi giorni è logico che faccia il tour della Roma classica ma ritagliarsi qualche ora per visitare un quartiere semiperiferico come Garbatella, dove è nato il barocchetto romano, o la città Giardino, completerebbe la visita e la trasformerebbe in un’esperienza» spiega Ranaldi.
L’altro ostacolo a una più sostenibile fruizione dei luoghi è anche la mancanza di un’offerta adeguata, nonostante, soprattutto dopo il covid, sia cresciuta tra i turisti l’esigenza di esperienze alternative e più autentiche. «Spesso l’offerta turistica è tarata sullo standard del turista medio – continua Ranaldi –, abitudinario e un po’ “tonto”. Pochi mesi fa un tour operator di Sorrento mi ha chiamata per accompagnare una scolaresca di Bologna a Scampia, sapendo che io la frequento e che sono un’esperta di questi quartieri popolari, nati come un’utopia nelle periferie delle città italiane. Significa che nel luogo non c’erano possibilità. Una scelta azzeccata, perché Scampia è collegata al Corviale di Roma, allo Zen di Palermo; fanno tutti parte di un sistema nazionale di rigenerazione urbana che ci fu nel dopoguerra. Quindi, se vai a scoprire uno di questi quartieri, sei in un luogo, ma sei dentro una storia più grande». Quest’Italia delle periferie ricche di storia, cultura, umanità è una delle «Italie» possibili: ce ne sono tante, tutte da scoprire, che arricchirebbero l’esperienza turistica di contenuti e decongestionerebbero le città d’arte e i luoghi più sfruttati.
L’identikit del nuovo viaggiatore
Per smuovere le acque un compito importante ce l’ha anche il turista stesso, che dev’essere più attivo nella ricerca. «L’offerta turistica in verità ha cominciato a diversificarsi, sia nelle tipologie che nella stagionalità – conferma Paolo Casetti –. Le proposte cercano di cogliere il desiderio sempre più forte di vivere un’esperienza, di coltivare una passione, di creare un contatto più autentico possibile con i luoghi. È la nuova tendenza».
Ma non basta. Un turista accorto deve anche imparare a vagliare la sostenibilità, «scegliendo più spesso proposte frutto della collaborazione di una comunità, che avvantaggiano il territorio e che permettono un incontro con le persone». Ma il turista deve anche saper entrare in punta di piedi «senza accampare diritti, solo perché porta soldi; deve essere curioso senza essere invadente, deve saper rispettare la natura, ma anche le usanze e la cultura delle popolazioni» continua Casetti, sottolineando che l’educazione al viaggio non è affatto scontata.
Per chi vuole evitare la folla, restando nella variegata provincia italiana, una delle risorse più interessanti sono le associazioni: «Le Bandiere Arancioni del Touring Club, i Borghi più belli d’Italia, i Borghi Autentici sono una miriade di comuni stupendi, divisi per regione, che rispettano criteri di valorizzazione, di salvaguardia dell’ambiente, di sostenibilità. Questi criteri sono periodicamente controllati, pena la perdita di promozione, e sono una garanzia di qualità» conclude Casetti. Un’Italia minore, di grande bellezza, ricca di buone pratiche, una piccola grande risorsa, per cambiare il volto del turismo del Bel Paese. Segni concreti che un’alternativa alla turistificazione è possibile, sia nelle città che in provincia. E che possiamo contribuire a costruirla anche noi, ogni volta che scegliamo un viaggio.
Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!