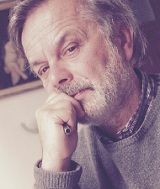Trentatremila chilometri di cammini

La mia finestra si apre sugli ultimi metri del Cammino Materano che conduce, in sette giorni, da Bari alla città lucana. È un arrivo bello: l’altopiano della Murgia davanti agli occhi, e, all’improvviso, spunta la meraviglia di Matera. È la Via Peuceta, dal nome di un’antica popolazione indoeuropea che si stabilì in quella che oggi è la Puglia. In questa primavera, ogni giorno, passano pattuglie di camminatori, zaino in spalla, abiti tecnici, bastoncini, che si fermano felici di fronte al paesaggio dei Sassi. Ho percorso più volte alcuni tratti dei cammini che conducono a Matera: sono almeno sei percorsi che partono dalla Puglia e ora si spingono fino a Paestum. Sono felice del loro successo. L’Italia è diventata un paese di camminatori. Facile titolo per giornali, blog e pagine web che registrano lo straordinario aumento di chi si mette in cammino. La vittoria del «turismo lento».
Ogni anno, alla vigilia della primavera, Terre di Mezzo, preziosa casa editrice, specializzata da un quarto di secolo, in libri sull’andare a piedi, pubblica, da sette anni, un dossier sui cammini italiani. Nel 2023, le «credenziali» rilasciate ai viandanti che hanno affrontato un cammino hanno superato per la prima volta quota centomila. Solo sei anni fa non arrivavano a 18 mila. E oltre 57 mila sono stati i testimonium, le certificazioni che spettano a chi ha completato almeno un lungo percorso. Un incremento del 25 % rispetto all’anno precedente. Oltre i cammini materani, hanno successo i tratti siciliani della Via Francigena, i percorsi toscani di San Benedetto e San Jacopo e quelli che, da diverse direzioni, conducono al santuario di Oropa. E il cammino minerario di Santa Barbara in Sardegna. Sono diminuite le presenze lungo la Via degli Dei, uno dei primi cammini italiani, tra Bologna e Firenze. Lo hanno percorso già in tanti, in moltissimi.
A scorrere le pagine del dossier di Terre di Mezzo si passa il dito sui 33641 chilometri di percorsi italiani. 1891 tappe. Come se la penisola fosse attraversata da una fitta ragnatela di cammini. Molti non chiedono le «credenziali» e allora si stima che siano almeno 150 mila le donne e gli uomini che, lo scorso anno, sono partiti a piedi per il loro viaggio. E la maggioranza (il 57 % sono donne). Un terzo di questi camminatori/trici è solitario. E il 12 % ha camminato, nell’anno, per più di cinquanta giorni. Questa è economia: un milione e trecento cinquantamila pernottamenti in ostelli, B&B, rifugi, albergues, sorti nei luoghi di passaggio dei camminatori. Una spesa non indifferente: tra i 40 e i 50 euro al giorno per almeno la metà di questi viandanti contemporanei. Fate voi i conti.
Nell’ultima domenica di aprile ho contato almeno venti persone sedute ai tavoli di una masseria tra Santeramo e Altamura: questa azienda familiare ha avuto la fortuna di vivere e lavorare esattamente a metà strada di questa tappa pugliese del cammino Bari-Matera. Vi si arriva all’ora del pranzo. Un reddito prezioso per chi vive di campagna. A Nord, il Cammino francescano di Sant’Antonio è ormai una realtà consolidata: in undici tappe unisce Gemona a Padova e, dalla parte opposta, risale la penisola da Cassino fino alla città del Santo. Ora si lavora per unire la Sicilia all’itinerario francescano.
Non ho trovato statistiche sull’età di chi si mette in cammino. Mi interesserebbero. Impressionanti i numeri di coloro che si incamminano verso Santiago di Compostela, il pellegrinaggio più celebre del mondo: nel 2023 sono stati 446 mila i pellegrini diretti alla città galiziana. E ben 28 mila erano italiani. E dagli Stati Uniti ne sono arrivati ben più di trentamila. Passione incoraggiata dal film The Way (Il cammino per Santiago), struggente film del regista newyorchese Emilio Estévez attorno a un padre che si mette in cammino dopo la perdita del figlio avvenuta sui Pirenei.
La mia osteria, qui a Matera, ha un tavolo che, da quando vivo qui, è «riservato» agli «amici». Una sorta di spazio a disposizione di chi viene qui abitualmente per passare un po’ di tempo. In questi mesi di primavera a volte capita che questo tavolo venga occupato da pattuglie sempre più numerose di camminatori. Hanno abbigliamenti tecnici e comportamenti perfettamente riconoscibili, quasi un segno di appartenenza a una tribù. Di nuovo: sono felice di questo successo, dell’abitudine a camminare di sempre più donne e uomini. Un piccolo tarlo, però, mi rode: «Sono troppi, questi camminatori? Hanno conquistato uno spazio che credevo riservato a poche persone?». Ho una domanda ingenerosa: «Camminare è diventata moda?». Cancello questi pensieri, li rinnego, non sono io. Certo è che adesso è bene prenotare il luogo dove dormire, altrimenti si rischia di non trovare un letto dove riposare il proprio corpo. È solo una sorta di rimpianto di chi ha nostalgia della sua gioventù?
Chiedo a Riccardo Carnovalini, pioniere dei cammini, tra i «costruttori» del Sentiero Italia, forse il più lungo percorso al mondo. «Hai ragione: camminare è diventato una moda. Ma è una bella moda. Adesso nasce un cammino a settimana, prima o poi ci sarà un filtro. Alcuni moriranno, i camminatori più attenti cercheranno altri percorsi, meno affollati, magari più faticosi». Riccardo abita in una valle piemontese, a poca distanza dalla GTA, la Grande Traversata Alpina: «Qua non passa tanta gente. Ci sono forti dislivelli. Vedo passare stranieri, pochi camminatori italiani».
E poi chiedo a Paolo Piacentini, camminatore, scrittore, tra i fondatori di Federtrek e tra i creatori della Giornata Nazionale del Camminare: «Certo, va di moda camminare. Ne sono contento, ma bisogna fare attenzione alle distorsioni, agli errori già provocati dal turismo privo di rispetto dei luoghi. Vero e bello: le piccole comunità stanno avendo benefici da chi arriva nei loro paesi camminando. Si mettono in moto economie, riaprono bar, si creano B&B, c’è uno scambio fra i paesani e i camminatori. Ma se questo viene distorto, se l’arrivo dei camminato modifica la vita della comunità, si rischia molto. Camminare deve essere alla portata di tutti, ci vogliono luoghi di accoglienza (palestre comunali, sale parrocchiali…) per chi non può permettersi una spesa a volte eccessiva. San Francesco camminava, ma, come viandante, aveva cura dei luoghi che attraversava. Ecco, questo è necessario: il camminatore deve avere cura, attenzione ai paesi e ai boschi che attraversa».
Buoni cammini. Abbiatene davvero cura.
Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!