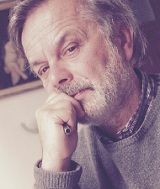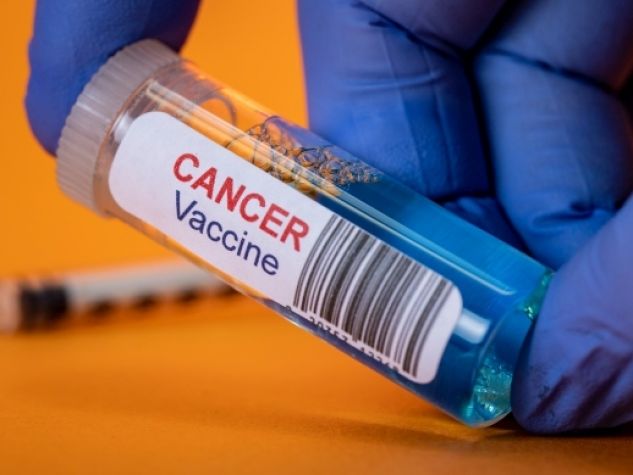Carloforte, la Madonna degli Schiavi

Un parroco coraggioso, don Nicolò, non volle che fosse dimenticato il racconto di Nicola Moretto, un suo compaesano. Gli aveva appena narrato del ritrovamento sulla spiaggia di Nabeul, in Tunisia, di una strana e piccola statua di una Madonna, legno di tiglio, corroso dalla salsedine e dalla sabbia. Probabilmente era quanto rimaneva della polena di nave. Era «sospesa» tra due alberi, Nicola raccontò che la Madonna stava «guardando il cielo». Dal mare stava soffiando una leggera brezza. Sento il cuore del ragazzo aumentare i suoi battiti. Nicola, uno schiavo della corte del bey di Tunisi, nascose la statua tra i suoi vestiti e la mostrò solo ai suoi compagni di prigionia. Si convinse che quello era il segnale in cui aveva sperato da due anni, da quando, dopo una incursione, i corsari tunisini non lo avevano catturato assieme agli abitanti della sua isola, appena al largo delle coste della Sardegna meridionale. No, fu certo, Nicola: la Madonna non si era dimenticata di loro. E don Nicolò scrisse un puntiglioso resoconto del racconto di Nicola.
Questo avveniva nell’autunno del 1800. Ma la storia degli uomini e delle donne dell’isola degli Sparvieri (conosciuta anche come isola di San Pietro) è molto più lunga. A metà del ‘500, una potente famiglia genovese, i Lomellini, banchieri e commercianti di corallo, ottenne dall’imperatore Carlo V la concessione dell’isola di Tabarca, sulla costa settentrionale della Tunisia. I suoi fondali erano ricchi di corallo. I Lomellini organizzarono una vera e propria migrazione: trecento famiglie, per lo più di Pegli, vennero inviate nell’isola tunisina. Erano pescatori e raccoglitori di corallo. Per due secoli arricchirono i Lomellini. Poi l’insicurezza delle rotte mediterranee e l’esaurimento del corallo convinse quella comunità ligure, conosciuta come i «tabarchini», a emigrare nuovamente. Nel 1720, i Savoia erano entrati in possesso della Sardegna e progettavano il popolamento dell’isola. Carlo Emanuele III, sovrano sabaudo, accettò la supplica dei «tabarchini» di poter vivere in quella piccola isola a ridosso delle coste sarde: il 22 febbraio del 1738 sbarcarono in Sardegna i primi 86 coloni.
L’isola sarda cambiò il suo nome: in onore di un sovrano piemontese, divenne Carloforte, la prima colonia sabauda in Sardegna. Ma il Mediterraneo era un mare inquieto. Alla fine del secolo, al termine dell’estate del 1798, la flotta del bey di Tunisi aggredì l’isola, il villaggio venne saccheggiato e quasi tutti i suoi abitanti, 830 persone, furono fatti prigionieri e portati in catene in Tunisia. Tra di loro il giovane Nicola Moretto e il parroco don Nicolò Segni, che aveva scelto di non abbandonare la sua gente. Il bey di Tunisi decise di non vendere i suoi nuovi schiavi e pretesero invece un riscatto dai Savoia. La trattativa si incagliò per cinque anni. I «tabarchini» avevano perso quasi ogni speranza fino a quando non apparve quella polena con le forme e il volto di una Madonna. Nel 1803, Carlo Emanuele IV, con l’aiuto di altri regni europei, pagò il riscatto e ottenne la liberazione dei prigionieri. I «tabarchini» tornarono nella loro isola e portarono con loro quella Madonna di legno che, ne erano certi, li aveva aiutati a ritrovare la libertà. Da allora è conosciuta come la Madonna degli Schiavi. Don Nicola, come ringraziamento, avviò la costruzione di una piccola cappella, che gli abitanti di Carloforte ribattezzarono la Gexxeta du Previn, la Chiesetta del Pretino. Non stupitevi del nome della nuova chiesa: i «tabarchini» avevano conservato la loro lingua anche in Nord Africa, un dialetto ligure, molto simile a un genovese antico. Ancora oggi, Carloforte è un’isola linguistica di diecimila uomini e donne. E la Madonna degli Schiavi veglia ancora su questa comunità.
Non conoscevo questa storia quando sono sbarcato a Carloforte. Non avevo letto niente. Non ero preparato, anche se da sempre volevo conoscere questa isola e la sua «gemella», Sant’Antioco. Capii subito che parlavano una lingua curiosa. Un accento che conoscevo, mi sembrava di essere al porto di Genova. Quanto vi ho raccontato mi è stato narrato una mattina da un vecchio falegname, Luigi Pomata. Che strano nome. Barba bianca, tuta da lavoro bianca. Stava lavorando all’aperto attorno a un modello perfetto della chiesa del paese. La sua bottega, in una stretta via del centro di Carloforte, è tappezzata di bigliettini, di piccole palme di balsa, di grandi e fedeli ricostruzioni dei monumenti del paese, di cassetti e attrezzi, di schizzi di progetti. Attorno a sé gli amici quotidiani. Ogni mattina, immagino, si ritrovano qui e chiacchierano per ore. E la prima cosa che mi dicono: «Vai a vedere la Madonna. Dicono che dobbiamo a Lei se oggi viviamo qui».
Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!