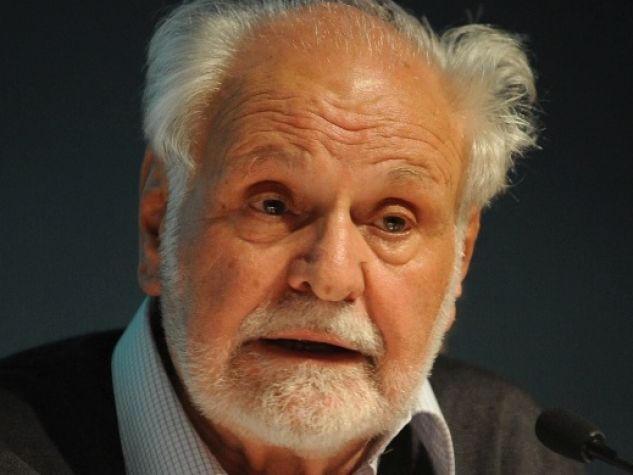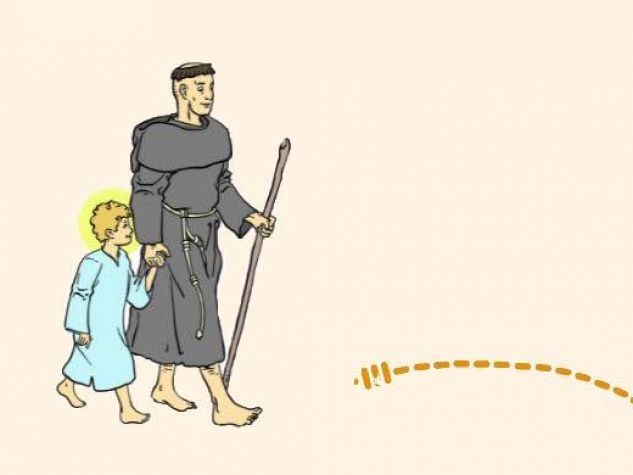Vicini per riconoscerci fratelli
Qualche anno fa, a un convegno di psicoanalisti, un magistrato impegnato nei percorsi di giustizia riparativa ha detto: «La giustizia riparativa è controintuitiva perché, invece di segregare colui che ha offeso, lo porta vicino a chi è stato da lui offeso». La frase è un piccolo modello di parole insieme esatte e nonviolente. Non si parla di delinquenti, assassini o prepotenti. Il verbo offendere (dal latino ob, cioè «verso» e fendere, cioè «colpire»), dichiara che c’è stata una vicinanza sventurata, che ha colpito e ferito. Chi la subisce è stato leso, forse menomato, di sicuro soffre nello spirito e il corpo registra, patisce l’evento. La giustizia riparativa accade quando la vicinanza dei corpi può avvenire in una forma nuova e appropriata. Non subito, senza precipitazione o forzature. E questo permette di tornare a vivere, lo permette a entrambe le parti, anche a chi è stato offeso, perché a volte il dolore congela la vita e la rabbia insieme al dolore si trasforma in giorni senza movimento. Si torna a vivere perché ci si riconosce appartenenti alla comune umanità.
Gli etologi, cioè gli studiosi del comportamento degli animali, osservano che nella lotta corpo a corpo tra due individui della stessa specie, chi sta soccombendo può mostrare la parte debole di sé, come il collo o la pancia, per significare la resa e aver salva la vita. Anche tra gli uomini capita. C’è una letteratura che racconta come vedere l’avversario da vicino, in guerra ad esempio, annienti l’ostilità, permetta di riconoscersi uniti dal comune desiderio di vivere. Infatti, ai soldati era vietato avvicinarsi, anche solo per parlare amichevolmente, al nemico, per evitare il pericolo di «fraternizzare» (bellissimo verbo), cosa che avrebbe impedito loro di uccidere.
Le armi moderne hanno progressivamente allontanato l’avversario, e hanno reso sempre più facile uccidere. La distanza di uno sparo non permette segni di resa e blocca il riconoscimento della comune umanità. La bomba non si sa nemmeno dove cada. In questa progressione sciagurata oggi si producono quelli che vengono chiamati «sistemi di armi autonome letali», cioè programmati ad agire sulla base di algoritmi che non richiedono la valutazione finale dell’uomo. La Chiesa ha ben visto il pericolo grave di queste armi e la Santa Sede ha ripetutamente chiesto, durante incontri ufficiali, che le nazioni si obblighino a garantire «un’adeguata, significativa e coerente supervisione umana sui sistemi d’arme» (Sesta conferenza di revisione della Convenzione CCW, Ginevra 2021), ovvero a far sì che l’uso delle armi non escluda mai quella complessiva valutazione del contesto concreto che solo la persona dotata di responsabilità morale può avere.
Questo bisogno del corpo vicino per poter continuare la vita è così limpidamente evangelica che è immediato pensare a Gesù che prende per mano la figlia, già morta, di Giàiro e le parla, Talità kum, e lei si alza; oppure tocca l’uomo «coperto di lebbra», doppia follia, perché era proibito e perché era contagioso, e lo guarisce; oppure viene toccato dalla donna che sanguina e ancora una volta questo basta a guarirla, oppure invita Tommaso a vincere la propria incredulità offrendogli di toccare la sua ferita. Avrebbe potuto imporre le mani, fare gesti di guarigione a distanza. Invocare e basta. Gesù avrebbe potuto, ma non lo ha fatto. Come Dio non lo ha fatto. L’Incarnazione è questo definitivo inno alla meravigliosa bellezza e necessità del corpo. Per questo il corpo (in un modo misterioso, che non conosciamo) rinasce nella Risurrezione. Intanto, comunque, qui, il corpo ci permette di riconoscerci fratelli.
Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!