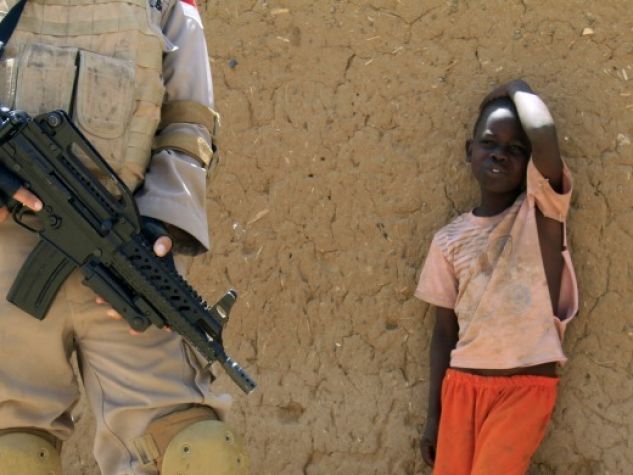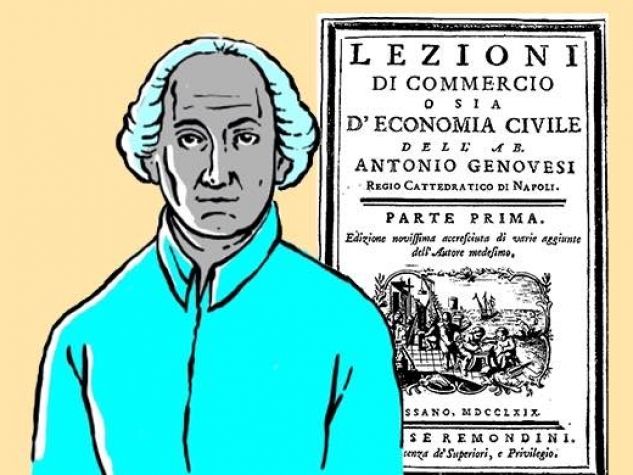America, mito e illusione
«La storia della grande emigrazione degli italiani negli Usa è un vero e proprio romanzo popolare che ha riguardato intere generazioni, e ha segnato in profondità le vicende dei due Paesi». Ne sono convinti Mario Avagliano e Marco Palmieri, autori del saggio Italiani d’America - La grande emigrazione negli Stati Uniti (il Mulino, pagg. 552). Consultando un’enorme mole di fonti: lettere, diari, testimonianze, documenti ufficiali, Avagliano e Palmieri hanno indagato le cause che spinsero milioni di italiani a emigrare nel Nuovo Mondo, i loro sogni e le loro aspirazioni in quella stagione epica e drammatica che va dal 1870 al 1940, evidenziando il ruolo cruciale delle donne: mogli, madri, sorelle in quella sofferta diaspora che le portò a misurarsi con pregiudizi e stereotipi oltre Atlantico, ma anche a emanciparsi dalle condizioni economiche, sociali e culturali da cui avevano cercato di affrancarsi partendo con le loro famiglie.
Un processo lungo e complesso, non privo di rischi e, spesso, di cocenti delusioni. Gli italiani che emigravano dal Sud fuggivano dalla miseria e dalla disperazione. La mancanza di prospettive riuscì in molti casi ad anestetizzare anche il dolore dello sradicamento. Purtroppo il lavoro nei campi non dava frutti così generosi da poter sostentare i contadini e le loro famiglie. «L’Italia, infatti, era alle prese con una profonda crisi economica e sociale – ricordano i due autori – e il compimento del sogno risorgimentale non era valso a migliorare la situazione delle classi meno abbienti, specie della gran massa di contadini meridionali, anzi il bilancio del nuovo Stato pativa il peso degli sforzi fatti per raggiungere l’unità nazionale ed ereditava le grandi difficoltà nei conti pubblici degli Stati preunitari. Fu in questo contesto che nacque il sogno americano. Oltreoceano gli italiani cercavano lavoro e fortuna, in un Paese dove tutto era ignoto, ma di cui prendeva a circolare e a diffondersi un autentico mito. Non a caso nel linguaggio comune fare la Merica è diventato un modo per dire arricchirsi e fare fortuna».
Il saggio racconta tutte le tappe di questo romanzo popolare: dalla scelta sofferta di partire, al viaggio in nave, dall’arrivo negli Stati Uniti al duro contesto sociale, economico e lavorativo che avrebbe atteso gli emigranti, dalle difficoltà nell’integrazione fino alle storie di successo di quelli che ce la fecero. Ma quale America trovarono gli italiani al di là dell’Atlantico? Gli Stati Uniti di allora, come traspare anche da alcuni brani di lettere drammatiche citate nel libro, non erano certo l’oleografico Bengodi che l’America stessa aveva (e ha sempre) consegnato all’immaginario collettivo, e da cui quei migranti erano stati sedotti prima ancora della partenza dall’Italia. Un po’ come avviene oggi per chi approda in Italia.
«La stragrande maggioranza degli emigranti italiani che arrivarono negli Stati Uniti sbarcarono a New York, mentre un numero inferiore scelse come destinazione Boston, Philadelphia, Baltimora, New Orleans e San Francisco – rammentano Avagliano e Palmieri –. Fino al 1892 a New York il punto di smistamento degli emigranti era Castle Garden. In seguito, sotto la pressione di una nuova imponente ondata di emigranti provenienti da tutta Europa, venne aperta una stazione d’arrivo più funzionale a Ellis Island. Ed è qui che, dopo l’emozione della vista della Statua della Libertà dai ponti delle navi, dopo viaggi lunghi e spesso burrascosi, avveniva il primo impatto con il Nuovo Mondo».
Gli italiani sbarcavano accompagnati da pregiudizi e razzismo. Ma gli Stati Uniti stavano vivendo una fase di forte crescita industriale e demografica, e avevano bisogno di una grande massa di manodopera da sfruttare. «Gli italiani andarono a ingrossare le fila dei lavoratori non qualificati, impiegati nelle mansioni più umili e faticose. Erano considerati manodopera di second’ordine, adatta a lavori pick and shovel (piccone e pala) che non richiedevano competenze o capacità tecniche, ed erano esclusi dalle categorie con retribuzioni più alte, nei grandi cantieri stradali e ferroviari, dove rimpiazzavano irlandesi, tedeschi e scozzesi che li avevano preceduti; nelle miniere di ferro, rame e carbone, dove diventarono il gruppo nazionale più consistente; nell’edilizia, nei lavori per la costruzione delle metropolitane nelle grandi città, nella costruzione di fognature, nello scavo di tunnel e nello scarico merci dalle navi, spesso come lavoratori stagionali. Solo successivamente passarono a lavorare nell’industria, come in quella dell’abbigliamento a New York, Chicago e Philadelphia, negli stabilimenti tessili a Patterson e Lawrence, in quelli metalmeccanici del New England e nella lavorazione dei sigari in Florida».
La doppia arma di Mussolini
Un’inversione di rotta si registrò durante il periodo del fascismo. Le partenze per gli Stati Uniti si ridimensionarono. Mussolini era preoccupato dell’idea che dava dell’Italia chi se ne andava per sfuggire alla miseria e all’arretratezza del Paese, mentre l’Italia, nella rappresentazione del regime, voleva invece apparire per quello che, in realtà, non era affatto. «Mussolini e il fascismo erano molto sensibili al tema dell’emigrazione – confermano Avagliano e Palmieri –. Da un lato perché un regime che propagandava di aver elevato l’Italia tra le grandi potenze mondiali non poteva permettere il perpetuarsi delle partenze di navi cariche di disperati che andavano a cercare fortuna altrove, dall’altro perché la gran massa degli italiani all’estero poteva avere un ruolo importante nel fare da cassa di risonanza della dittatura. Nelle Little Italy, infatti, il regime arrivò con la propria propaganda, e all’inizio riuscì a portare molti italiani dalla sua parte, facendo leva sull’orgoglio nazionale e sulla rivalsa rispetto alle umiliazioni e allo sfruttamento che avevano caratterizzato la prima fase dell’emigrazione italiana. La comunità italo-americana osservava, attraverso il filtro della distanza, l’affermazione del fascismo, e l’immagine che giungeva loro era quella di una nazione finalmente risollevata e rispettata nel consesso internazionale. Per la prima volta, inoltre, un governo italiano mostrava di considerare e di interessarsi ai propri connazionali all’estero, fino ad allora trascurati e dimenticati». Così gli emigrati italiani trovarono un modo ulteriore per rinsaldare il senso di appartenenza e il riconoscimento di un’identità nazionale comune superando la frammentazione campanilistica che tradizionalmente li aveva caratterizzati. Solo la Seconda guerra mondiale avrebbe spezzato questo legame.
Gli zii d’America e gli sconfitti
Un’epopea così complessa come quella dell’emigrazione italiana negli Stati Uniti non poteva nascondere storie di fallimenti sebbene emergano spesso solo vicende di successo. Degli «sconfitti» non parla quasi mai nessuno. «Degli emigranti che ritornarono in Italia si ha sempre e solo l’immagine stereotipata dello “zio d’America” che ha fatto fortuna, che ha realizzato il sogno americano e ha abbracciato gli usi e i costumi del Nuovo Mondo, e quando torna a casa fa vedere tutto questo – ammettono Avagliano e Palmieri –. Ma non è tutta la verità. Tra coloro che rientrarono in Italia, oltre a chi era mosso dal desiderio di ricongiungersi con la propria famiglia e le proprie origini, c’erano anche molti emigranti che affrontarono il viaggio di ritorno perché non erano stati ammessi negli Stati Uniti oppure erano stati protagonisti di esperienze fallimentari a causa delle quali non avevano fatto la fortuna sperata. Uno dei momenti più drammatici era quello in cui il traghetto attraccava a Ellis Island e gli emigranti dovevano mettersi in fila e recarsi al Main Building, sotto l’occhio delle guardie della dogana, rimanendo in attesa davanti all’ingresso per svariate ore senza che venissero distribuiti loro cibo o acqua. Attraverso una lunga e ripida scalinata, raggiungevano la sala delle registrazioni (The Registry Room) e si apprestavano ad affrontare la tanto temuta Special Inquiry: l’ispezione che doveva accertarne l’idoneità psico-fisica e legale richiesta dalla legge americana per essere ammessi». Chi veniva respinto per motivi di salute o legali (in genere il 2% degli emigranti) non sempre accettava il verdetto e «a volte si tuffava in mare, di notte, nel disperato tentativo di raggiungere Manhattan a nuoto oppure si suicidava. Sono noti almeno 3 mila casi. Si veniva espulsi per vari motivi, tra cui “malattie contagiose”, “per demenza”, perché “idioti” oppure perché ritenuti delinquenti».
I nomi degli italo-americani che scrissero storie di successo sono tanti e in molti campi. È anche grazie a queste vicende di integrazione e di affermazione sociale, economica, imprenditoriale e culturale che l’italianità è presente oggi con forza nella società americana. Il Made in Italy è sinonimo di bellezza e di qualità. Italiani illustri si contano numerosi nell’istruzione, nel teatro, nel cinema, nella musica, nel settore enogastronomico, nel commercio, in politica. «Solo per fare qualche nome: il sindaco d’origine italiana più famoso è Fiorello La Guardia, nato a New York nel 1882. Nel 1942 Charles Poletti – nato nel 1903 a Barre, nel Vermont, figlio di uno scalpellino anarchico del Novarese – fu il primo politico italo-americano a ricoprire la carica di governatore dello Stato di New York per il Partito democratico, sia pure per un solo mese. Nel cinema una delle prime star, ancora al tempo del muto, fu Rodolfo Guglielmi, col nome d’arte di Rudolph Valentino. Il cinema portò alla ribalta anche il siciliano Frank Russell Capra, che dopo tanti sacrifici, diventò, negli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso, uno dei registi più importanti dell’epoca d’oro di Hollywood, girando film memorabili. Poi nello sport si va dai pugili Jake LaMotta e Rocky Marciano a Joe DiMaggio nel baseball».
Il dilemma dell’integrazione
Vivere e adattarsi al nuovo Paese non fu sempre facile. La questione dell’integrazione innescò anche un conflitto intergenerazionale. Alle ali estreme c’era, da una parte, chi voleva restare legato alle proprie radici italiane e, dall’altra, chi voleva totalmente americanizzarsi, quasi vergognandosi della sua identità e delle sue radici. «Se il dramma della prima generazione di emigranti fu quello di sbarcare in un Nuovo Mondo, di cui letteralmente non conoscevano nulla: né la lingua, né gli usi e i costumi, né la geografia, per i figli degli emigranti italiani che si erano già stabiliti oltreoceano o che vi trasferirono le loro famiglie, la difficoltà fu quella di essere compressi tra la chiusura dei genitori e la voglia di essere accettati e integrati con i loro coetanei americani. I giovani della seconda generazione di italiani, durante i primi decenni del XX secolo affrontarono un enorme dilemma psicologico ed esistenziale sulla propria identità, schiacciati tra il mito italiano e il mito americano: a casa e in famiglia vivevano la cultura italiana ed erano educati e cresciuti secondo i suoi canoni, mentre fuori erano esposti a quella americana fatta di modi di vita, di espressioni, di abitudini alimentari e abbigliamento molto diversi, che osservavano e assimilavano frequentando cinema, scuole e luoghi di ritrovo dei loro coetanei. Poiché erano due culture difficili da amalgamare, spesso quei giovani di seconda generazione si sentivano ai margini di entrambe. Una sensazione che li avrebbe accompagnati per tutta la vita».
Furono 4 milioni e mezzo gli italiani che tra il 1870 e il 1940 partirono per gli Stati Uniti in cerca di fortuna. Oggi gli italo-americani sono quasi 18 milioni su una popolazione di più di 330 milioni di cittadini ovvero tra il 5% e il 6% dei residenti. «Secondo altre fonti – osservano Avagliano e Palmieri – il dato sarebbe quasi doppio, cioè circa 25-30 milioni. È una realtà il fatto che la comunità italo-americana oggi è parte integrante della società americana, e che conserva radici profonde che la tengono idealmente o materialmente legata alla terra d’origine». Non a caso il libro si chiude con i versi evocativi del poeta italo-americano Joseph Tusiani: «Due lingue, due terre, forse due anime… / Son io un uomo o due strane metà d’uno solo? / (…) Sono il presente perché sono il passato / di quanti per il loro futuro son giunti, / umili ed innocenti eppure scacciati».
Prova la versione digitale del «Messaggero di sant'Antonio»!